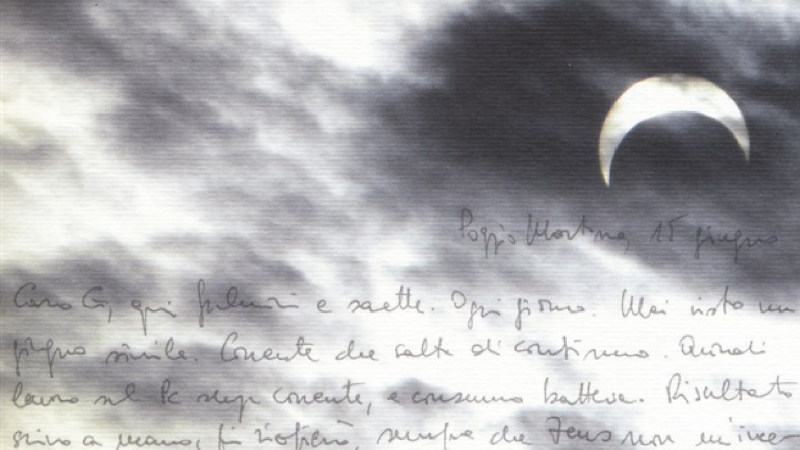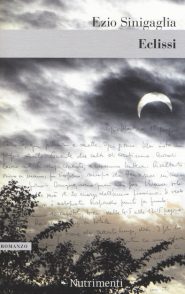 Vincitore di Modus Legendi 2020, iniziativa organizzata dal gruppo Facebook Billy, il vizio di leggere che prevede il coinvolgimento diretto dei lettori per portare in classifica romanzi di case editrici indipendenti meritevoli di attenzione letteraria, Eclissi, di Ezio Sinigaglia, è tornato in questi giorni in libreria.
Vincitore di Modus Legendi 2020, iniziativa organizzata dal gruppo Facebook Billy, il vizio di leggere che prevede il coinvolgimento diretto dei lettori per portare in classifica romanzi di case editrici indipendenti meritevoli di attenzione letteraria, Eclissi, di Ezio Sinigaglia, è tornato in questi giorni in libreria.
Pubblicato nel 2016 dai tipi di Nutrimenti, e ambientato durante l’eclissi solare dell’equinozio 2015, il volume narra la storia dell’ex architetto triestino, “a un soffio dai settant’anni”, Eugenio Akron e del suo viaggio su un’isola scandinava per assistere per la prima volta in vita sua a un’eclissi totale. Lo scopo dell’impresa, puntare all’oscurità per cogliervi una luce, è in realtà più inconsueto del solito, in quanto l’obiettivo finale di Eugenio è trovare una domanda, e non una risposta, a un qualcosa di ben radicato nel suo passato e nel suo inconscio e destinato più che mai a emergere grazie all’atmosfera del luogo e all’incontro fortuito con un’americana quasi ottuagenaria.
Il libro è strutturato in dieci capitoli brevi che marcano l’evolversi della storia e degli eventi fino alla rivelazione finale, abbastanza scontata, a dire il vero, e intuibile dal momento in cui Mrs. Wilson stabilisce un contatto fisico con il protagonista risvegliando in lui emozioni provate in passato in una circostanza analoga.
Descrizioni minuziose di paesaggi e situazioni si alternano a dialoghi che escono dallo standard linguistico cui si è abituati quando si legge un romanzo. Eugenio Akron parla italiano, inglese e, negli episodi di gioventù, dialetto triestino; Mrs. Wilson utilizza un italiano maccheronico, anzi “acrobatico”, di cui viene accuratamente riportata la pronuncia storpiata; la signora Hagen e Kurtli parlano un inglese duro, tipicamente scandinavo, che si contrappone alla dolcezza e amabilità del loro carattere.
Una scelta stilistica di questo tipo porta con sé, e lo dico con rammarico, una serie di difetti. Innanzitutto, il dialetto triestino. È raro, quando due giovani dialogano tra di loro, che alternino lingua italiana e dialetto. O parlano in italiano, o parlano in dialetto, ma l’inserimento di un condizionale italiano all’interno di una frase dialettale è altamente improbabile (pag. 46: “Che cosa cazo sarebbe, Ben, sta paiazada?”, un triestino la pronuncerebbe: “Cossa cazo sarìa, Ben, ‘sta paiazada?”). Certo, va considerato che il contesto del ricordo sono gli anni Sessanta, ma anche in quel periodo, tra amici, il dialetto aveva la meglio sulla lingua. Lo stesso problema, paradossalmente, si presenta quando viene riportata una frase del nipote del protagonista, che ha lo stesso nome del nonno: “Ci verrei di corsa con te, nonno Senior, in questa avventura di grandezza astronomica. Peccato che sono ancora tròpo mulo. Dovresti tenermi d’occhio dal mattino alla sera al posto della mamma ed eseguire le sue istruzioni telefoniche minuto per minuto, compresi i due e quarantasette dell’eclissi” (pag. 57). Ora, stiamo parlando di un ragazzino di tredici anni che, nel 2015, si rivolge al nonno con un linguaggio tipicamente letterario che nella vita reale nessuno dei suoi coetanei utilizzerebbe mai. Capisco l’importanza di mantenere una certa accuratezza di stile, ma lo stile, secondo me, non deve andare contro la verosimiglianza. Altro problema, la parlata di Mrs. Wilson. È innegabile che espressioni come “livatacci”, al posto di “levataccia”, suscitino il riso e alleggeriscano una situazione che altrimenti, per il protagonista e per il lettore, sarebbe solo drammatica e priva di speranza, ma il riportare fedelmente tutte le sue storpiature alla lunga non facilita l’entrata in simbiosi con i protagonisti ma crea una sorta di distanza che fatica a essere colmata.
Un’altra critica va rivolta all’utilizzo delle similitudini. In un romanzo di centosette pagine sarebbe bene avvalersene con parsimonia, per dare modo anche al lettore di sfruttare la sua stessa immaginazione e per non rischiare che l’eccessiva ripetitività appesantisca la narrazione. Da pag. 7 a pag. 12 se ne contano dodici. E questo, ahimè, rende il capitolo iniziale piuttosto debole: – […] come il grande letto di un ciclope insonne; – […] come una pioggia d’estate tra i capelli; – […] come l’aureola argentea di un santo di secondo rango; […] come le acque minerali; – […] come i cubi multicolori di un gioco di bambini; – […] come una bocca aperta che succhiasse alla mammella magra e lunghissima del fiordo; – […] come spese superflue dopo una scrupolosa revisione dei conti; – […] come una mosca assetata del suo ragno; – […] come il grido stridulo di un cormorano; – […] come uno strangolatore irresoluto; – […] simile a una figura danzante dipinta sul globo di vetro di una lampada; – […] come un granello di brace.
Nonostante le osservazioni di cui sopra, Ezio Sinigaglia possiede un talento descrittivo davvero raro nell’attuale panorama letterario, e questa sorta di “isola con fantasmi”, dove i fantasmi sono quelli che ognuno di noi si porta dentro e che finiscono per forgiare la nostra personalità, vale la pena di essere scoperta per come scava a fondo dell’animo umano dimostrando che il vero dolore è superabile solo quando, anziché combatterlo, ci abbandoniamo a esso e troviamo la domanda che lo ha causato, non la risposta.