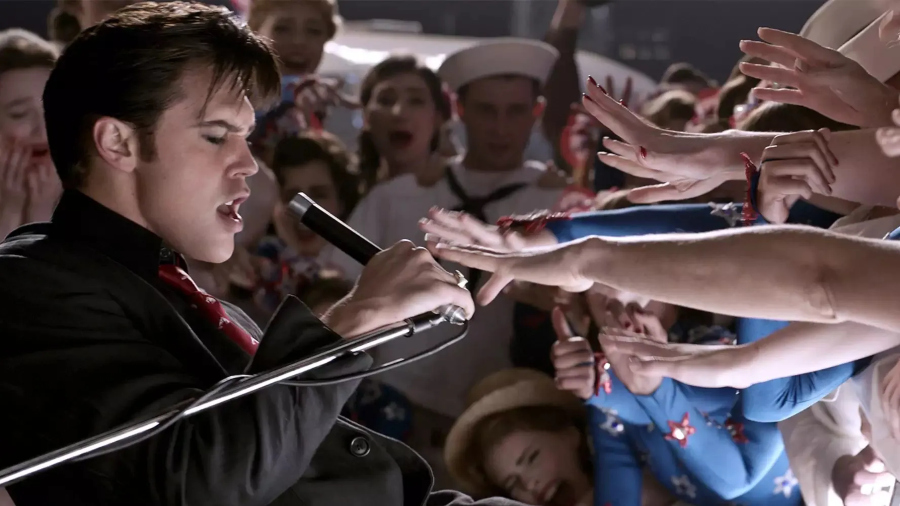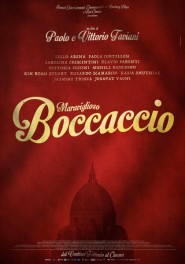 La filmografia di Paolo e Vittorio Taviani è, già di per sé, un’affermazione perentoria dell’indeperibilità dei classici, di quanto ancora essi abbiano da insegnarci e quali pietre di paragone possano offrire al presente, da Shakespeare su fino a Pirandello, lungo Goethe, Dumas, Tolstoj. Se all’alacre riscoperta delle fondamenta letterarie della civiltà si accosta l’orgogliosa identità toscana dei due fratelli di San Miniato, ribadita fieramente in film come La notte di San Lorenzo, l’incontro con Giovanni Boccaccio appare quanto meno fatale.
La filmografia di Paolo e Vittorio Taviani è, già di per sé, un’affermazione perentoria dell’indeperibilità dei classici, di quanto ancora essi abbiano da insegnarci e quali pietre di paragone possano offrire al presente, da Shakespeare su fino a Pirandello, lungo Goethe, Dumas, Tolstoj. Se all’alacre riscoperta delle fondamenta letterarie della civiltà si accosta l’orgogliosa identità toscana dei due fratelli di San Miniato, ribadita fieramente in film come La notte di San Lorenzo, l’incontro con Giovanni Boccaccio appare quanto meno fatale.
Ed ecco Maraviglioso Boccaccio, cinque novelle tra le cento “in dieci dì dette da sette donne e da tre giovani uomini” nel Decameron, esposte in barba all’ordine cronologico dell’originale. Mentre a Firenze la peste falcidia la popolazione e gli armenti, mentre montano la disperazione, l’isteria, l’intolleranza, una combriccola di sopravvissuti si apparta in un castello fuori porta… Il resto è noto. Attraverso il verbo dei novellatori, prenderanno corpo, in successione, l’eterea Catalina data per morta e rediviva grazie all’amore accudente di Gentile; Calandrino che, beffato da amici e compaesani, finisce per sfogare sulla moglie la sua rabbia; Ghismonda che si priverà della vita dopo che il padre, Tancredi, principe di Salerno, le ha ucciso l’innamorato Guiscardo; la monaca Isabetta, infelice e lussuriosa, e l’ancor più lasciva badessa Usimbalda; Federico Degli Alberighi e il suo povero falcone finito in pentola.
Se Pier Paolo Pasolini, con il suo Decameron del 1971, intendeva esaltare, secondo un’interpretazione personale ma, sul piano filologico, alquanto eterodossa, la sessualità disinibita ed esuberante della società agreste, prima che la cultura borghese giungesse a imporre la sua morale, l’obiettivo dei Taviani è ben altro. “Raccontiamo questa storia, anzi queste storie, ispirate al Decamerone di Boccaccio”, si legge nel pressbook, “perché accettiamo la sfida: ai colori cupi della peste –ieri come oggi la peste, in varie forme, è dappertutto- contrapporre i colori trasparenti dell’amore, dell’impegno, della fantasia”. Un’ode all’immaginazione, alle sue virtù salvifiche e redentrici. E ai sentimenti, com’è naturale. Ma è difficile esaltare la fantasia con un film che di fantasioso ha così poco. La maggior parte degli episodi non supera la soglia dell’illustrativo e, nonostante la bellezza dei paesaggi che, tra Toscana e Lazio, hanno ospitato le riprese e l’accurata confezione formale, non lasciano il segno, inalterati, per giunta, da un cast nel complesso promovibile ma senza guizzi o mordente, che tanto lascia rimpiangere una Laura Betti o attori di tal pasta nel cinema di oggi.
La cornice narrativa, dal canto suo, cerca di darsi un’importanza maggiore che nel libro, ma rimane una cornice, e non basta infonderle un po’ dell’erotismo delle novelle per vivificarla. Il tentativo, poi, di creare una continuità visiva tra i due piani del racconto, richiamando Kasia Smutniak dal reame della finzione e ponendola tra le novellatrici, si risolve una goffa soluzione visiva. Inoltre, quanto il film sappia parlare al presente è tutto da stabilire. L’intuizione da cui muove il ticket, che il consorzio umano sarebbe afflitto, oggigiorno, da una pestilenza che si manifesta nella rassegnazione e nella rinuncia dei più e alla quale bisogna trovare un antidoto intellettuale ed emotivo è, indubbiamente, sagace, ma abbastanza contorta e ciò che, nel Decameron, suona ancora attuale è piuttosto la creta stessa dei suoi personaggi, che ci parlano di amore, passione, magnanimità ma anche dell’indole truffaldina dell’essere umano, degli abusi del potere, della cupidigia e dell’ingiustizia. E tutto ciò da Maraviglioso Boccaccio stenta a emergere. Se, poi, è corretto aggiornare i dialoghi alla lingua corrente, il Guiscardo di Michele Riondino che liquida con “È una me…” lo stemma che sta disegnando non si può proprio ascoltare.
Peccato, perché l’episodio di Guiscardo è la parte migliore del film, l’unica in cui si intravvede un lacerto della grandezza dei Taviani e che, merito forse di una sorprendente Smutniak, si lascia ricordare per intensità. Si sa quanto il melodramma, il più significativo esempio di spettacolo popolare prima dell’avvento dei Lumière, abbia sempre contato per i due fratelli che, infatti, e non è la prima volta, scelgono di conferire, alla più melodrammatica delle storie, tratta dalla quarta giornata e perciò dal catalogo degli amori infausti, un assetto teatrale quanto a scenografia e inquadrature, come se il teatro, goduto ora dalla platea, ora dal loggione, facesse da mediatore tra la letteratura e l’immaginario cinematografico. Certo, gli apici figurativi di Allonsanfàn erano altra cosa…