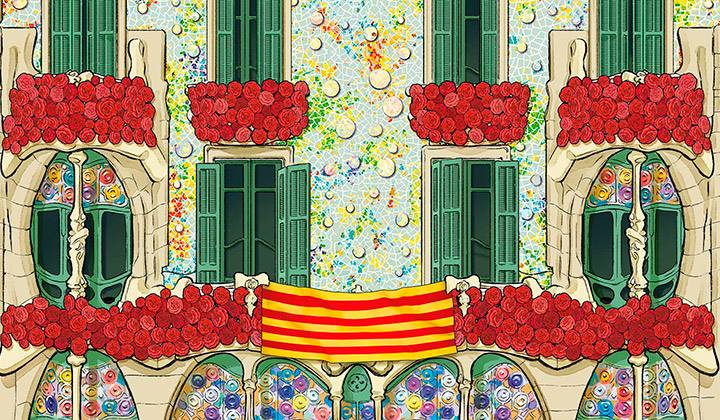C’è un luogo, in Italia, non me ne vogliano altrove, dove la creazione esplode lungo le coste con ogni colore della tavolozza, dove la meraviglia colpisce gli occhi di chi ama il mare con violenza improvvisa, facendo quasi male. Dove le foto non hanno bisogno di ritocchi successivi, e alla saturazione dei colori provvede, da sola, la natura. Ebbene, sono stato in Sardegna, visitandone tre luoghi ed altrettante spiagge, ed era la prima volta. Di sicuro ci ritornerò.
C’è un luogo, in Italia, non me ne vogliano altrove, dove la creazione esplode lungo le coste con ogni colore della tavolozza, dove la meraviglia colpisce gli occhi di chi ama il mare con violenza improvvisa, facendo quasi male. Dove le foto non hanno bisogno di ritocchi successivi, e alla saturazione dei colori provvede, da sola, la natura. Ebbene, sono stato in Sardegna, visitandone tre luoghi ed altrettante spiagge, ed era la prima volta. Di sicuro ci ritornerò.
Per decenni sinonimo di turismo elitario, la grande isola del Tirreno non è soltanto il Billionaire e Porto Cervo, yacht arroganti e vip, e paparazzi che l’inseguono. Quella che è dipinta come realtà è nicchia; la verità si trova altrove. Si trova in un numero sterminato di discese a mare e in coste infinite a disposizione di tutti, in un litorale incontaminato e così poco sfruttato da apparire talvolta deserto; si trova nel fatto che, in prossimità di suggestioni della natura che hanno lor pari soltanto a latitudini tropicali, delle volte trovare un bar per prendere un caffè è stata un’impresa. Si trova anche in una grave assenza d’infrastrutture, in centinaia di chilometri di tracciato stradale privi finanche d’un lampione, in un mondo per lo più ancora rurale, dove i produttori di formaggio pecorino sono migliaia, e i pochi farmacisti fanno i turni in aree che includono sei o sette centri abitati, mentre se hai il gpl, di domenica devi fare ottanta chilometri per raggiungere un distributore.
Ho visto una Sardegna che credevo dei vip, e che invece è di tutti. Di migliaia di turisti della domenica, del weekend o del mese intero, che fanno uso dei mezzi delle autostrade del mare per raggiungerne le coste a prezzi accessibili, e che una volta sbarcati andranno in auto, in moto e persino in autostop al villaggio, al camping, o nella villetta presa in affitto. Gente d’ogni stratificazione sociale è accolta da queste immense navi traghetto che traghetti più non sono, e che ospitano più che altri mezzi un’umanità articolata e multiforme, rendendo lo spostamento un percorso e il viaggio un’esperienza, con collegamenti marittimi regolari, su navi insospettabilmente moderne, sicure, veloci; che fanno d’una traversata quasi una crociera, coniugando metà dei lussi di queste a metà del fascino indimenticato dei viaggi per mare sui battelli a vapore, mentre l’ambiente non può che ringraziare, complice il modesto impatto ecologico del muoversi navigando.
I passeggeri alloggiano in cabine di lusso come sulle poltrone, ma anche su giacigli improvvisati fatti di materassi gonfiabili e trapunte leggere; per poi riunirsi attorno a una televisione, esultando per le gesta delle proprie nazionali del pallone – giocavano Italia e Spagna, e sulla tratta da Civitavecchia a Barcellona c’erano passeggeri d’entrambe le nazionalità – in un abbraccio suggestivo, inconsueto e irrituale, in mezzo al mare, degno della voce narrante di Hemingway. Mentre Navas, dal dischetto, mandava gli iberici in finale di Confederations, un milieu sociale tanto variegato da far dell’imbarcazione un piccolo melting pot di culture diverse rendeva la grande sala un non luogo antropologico, ove le culture si contaminano e, con la compresenza, si fondono.
La traversata fino in Sardegna dura circa sette ore, e il tempo scorre lieve a bordo, permettendomi di raccogliere varie testimonianze. “La provenienza dei passeggeri, assolutamente trasversale, è ciò che amo più di questo lavoro”, mi confida M., giovane membro dell’equipaggio che desidera mantenere l’anonimato: “lavoro da meno d’un anno, ed è stata una conquista faticosa, non vorrei mettere tutto a repentaglio per un’intervista”. Ciò che più ama, dice, “è far fronte alle richieste provenienti da passeggeri d’ogni estrazione sociale e d’ogni nazionalità, calarmi nelle loro culture, imparare ogni giorno da loro cose nuove. Gli spagnoli sono i più esigenti, gli italiani i più accomodanti. Ma i peggiori sono gli irlandesi: sono pochi, ma hanno spesso richieste folli. Uno pretendeva di viaggiare in cabina in compagnia del suo porcellino”. Una varissima umanità che su queste navi non viaggia solo per evasione, non ci sono solo vacanzieri. Il trasporto merci è molto frequente, e i conducenti di grandi camion sono in gran numero a bordo. “Prendo spesso questa nave” – rivela Joaquin, autotrasportatore spagnolo diretto a Valencia da Firenze, accompagnato da Enrique, il fratello sordomuto, col quale comunica si direbbe quasi telepaticamente, per mezzo di sorrisi e gesti ineffabili – “ho occasione di riposarmi a bordo, e devo dire che il servizio è eccellente. La mia azienda preferisce che viaggi per mare: per loro è più economico, e io posso rilassarmi dopo ore ed ore di guida. Inoltre ho sempre conosciuto bella gente; a bordo, due mesi fa, mi son pure fidanzato con una ragazza francese, Miriam: la raggiungerò ad agosto e faremo insieme le vacanze, probabilmente a Lisbona. Dopo, la presenterò in famiglia”. Particolarmente interessante è far breccia nelle vite dei membri dell’equipaggio: “Lavoro a bordo da sei anni” – mi dice Suzette, cameriera honduregna – “e non cambierei questo lavoro con nulla al mondo, sono molto soddisfatta. E ho anche la possibilità di mantenere i miei genitori in Honduras. Mi mancano tanto, ma è stata mia madre a dirmi: «va’ e fatti la tua vita»”.
Ecco le autostrade del mare, metà crociera, con le piscine, gli ottoni splendenti, il casinò e il piano bar; metà traghetto, coi camionisti, i sacchi a pelo, i bambini che han bisogno urgente d’una doccia e la gente che tifa Spagna, o Italia, e si scalmana davanti alla tivù. Ecco le autostrade del mare, che trasportano da un porto a un altro sogni di belle vacanze e speranze di destini migliori, accompagnati da un equipaggio che è anch’esso a metà tra i fasti crocieristici e la dimensione del libero servizio, pur mantenendo la grande professionalità tipica della gente di mare: “Han detto di no, mi spiace” – mi disse M. – “Dopo quel ch’è successo, dicono che è meglio evitare. Non può salire in plancia di comando. E poi ci avviciniamo a Bonifacio, bisogna stare attenti”.