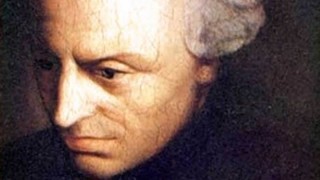La Terza Critica kantiana è un capolavoro della storia del pensiero; seppur in maniera sintetica, proviamo a toccare alcuni dei punti centrali dell’opera, dal concetto stesso di giudizio, ai problemi del principio di conformità a scopi e del senso comune. Pubblicata nel 1790, è destinata a ispirare alcuni dei maggiori pensatori e artisti romantici, la Critica della Facoltà di Giudizio è un’opera essenziale nella produzione del filosofo tedesco Immanuel Kant, e in genere per tutta la riflessione filosofica moderna; attraverso di essa, Kant inaugurò i principi dell’estetica moderna, e al contempo offrì strumenti speculativi anche per la filosofia politica.
La Terza Critica kantiana è un capolavoro della storia del pensiero; seppur in maniera sintetica, proviamo a toccare alcuni dei punti centrali dell’opera, dal concetto stesso di giudizio, ai problemi del principio di conformità a scopi e del senso comune. Pubblicata nel 1790, è destinata a ispirare alcuni dei maggiori pensatori e artisti romantici, la Critica della Facoltà di Giudizio è un’opera essenziale nella produzione del filosofo tedesco Immanuel Kant, e in genere per tutta la riflessione filosofica moderna; attraverso di essa, Kant inaugurò i principi dell’estetica moderna, e al contempo offrì strumenti speculativi anche per la filosofia politica.
Un errore spesso diffuso, che oltretutto emerge anche in parecchi manuali scolastici, è pensare che Kant si sia occupato rispettivamente del “vero” nella Critica della ragion pura, del “bene” nella Critica della ragion pratica, e poi del “bello” nella terza Critica. In realtà, a partire da quest’ultima opera, è lo stesso criticismo kantiano che viene coinvolto in un “ripensamento” o, quanto meno, in un “approfondimento”. La nozione di giudizio, infatti, viene adottata da Kant per mettere in comunicazione le due sfere del reale, la realtà fenomenica (l’unica realtà alla quale possiamo attingere, che è composta da elementi e fatti dell’esperienza che passano sempre attraverso il filtro della soggettività) e la realtà noumenica (la realtà oggettiva eternamente al di là dei limiti della ragione e della percezione soggettiva). Questo interrogativo su come mettere in rapporto facoltà umane e ambiti o elementi trascendentali è uno dei nuclei essenziali di quest’opera di Kant.
Sebbene vi sia un incommensurabile abisso tra il dominio del concetto della natura o il sensibile, e il dominio del concetto della libertà o il soprasensibile, in modo che nessun passaggio sia possibile dal primo al secondo (mediante l’uso teoretico della ragione) quasi fossero due mondi tanto diversi che l’uno non potesse avere alcun influsso sull’altro, tuttavia il secondo deve avere un influsso sul primo.
La filosofia critica kantiana presuppone un “dubbio preliminare” intorno alle possibilità della ragione stessa particolarmente in quei campi, come quello metafisico, in cui, mancando un controllo scientifico da parte dell’esperienza, sembra diventare possibile qualsiasi affermazione. La filosofia non ha il compito di descrivere e spiegare il modo in cui acquisiamo le nostre conoscenze o la coscienza morale, bensì quello di determinare le condizioni di possibilità e la validità di esse.
La facoltà di giudizio non ha un proprio definito “dominio”, al contrario dell’intelletto (la natura) e la ragione (la libertà). Anzi, la sua “forza” e importanza stanno proprio in questo suo essere tramite di due domini; la parola tedesca per “giudizio” è Urteil, e –teil ha significato di “tagliare, dividere”. Il taglio operato dal giudizio è in realtà una conciliazione (ma non identificazione) della ragion pura e pratica. La facoltà del giudizio è la facoltà del porre confini e, non potendo assegnarli a se stessa, tale facoltà non ha un dominio determinato, né limiti.
Nella terza Critica kantiana, assume un ruolo essenziale il “principio di conformità a scopi”. Tale principio non è un’idea regolativa, tanto meno un’istanza teoretica. Tale principio si esprime con la formula als ob: “come se”; il “come se” è un piacere, o fiducia, o anche necessità (intendendo l’uomo come animale teleologico) che permette all’uomo il suo “essere-nel-mondo” e il suo processo conoscitivo: dobbiamo supporre un ordine nella natura per avere accesso alla sua conoscenza; devo supporre che esista un senso ed una finalità in ciò che accade nel mondo, altrimenti non potrei vivere in esso e sarebbe impossibile ogni evoluzione scientifico-conoscitiva.
Il soggetto delle terza Critica è un “chi”: non è né l’ “Io” dell’Io penso proprio della prima Critica, né il “Tu” del Tu devi (Tu come “Io-dentro”), imperativo categorico proprio della seconda Critica. Questo chi è un “io-con-gli-altri”; il giudizio di gusto, d’altronde, non è un sentimento privato, come potrebbe sembrare: chi giudica “bello” qualcosa, giudica mettendosi al posto di chiunque altro.
In tutti i giudizi coi quali dichiariamo bella una cosa, noi non permettiamo a nessuno di essere di altro parere, senza fondare tuttavia il nostro giudizio sopra concetti, ma soltanto sul nostro sentimento, di cui così facciamo un principio, non però in quanto sentimento individuale, ma in quanto sentimento comune.
Questo soggetto, perciò, si costituisce passando attraverso l’alterità. Il senso comune è la norma della facoltà di giudizio: come dicevo sopra, il giudizio presuppone un’intersoggettività profonda fra il giudicante e gli altri individui; chi giudica, lo fa in vista del suo “essere-con-altri”, perché per giudicare è necessario porsi al posto di ogni altro. Senza gli altri (in un’isola deserta) lo stesso giudizio del bello sarebbe sterile e svanirebbe. L’orizzonte del senso comune è la comunicazione e la convivenza, per questo ha profonde valenze politiche e conoscitive (la conoscenza si basa sul giudizio, ed il giudizio non è possibile senza senso comune). Tralasciamo in questa occasione un argomento che meriterebbe un’attenzione specifica, e che viene trattato largamente da Kant, ovvero la distinzione tra “bello” e “sublime”.
Il senso comune si attiene a tre massime:
- pensare da sé;
- pensare mettendosi al posto di ognuno;
- pensare sempre in accordo con sé stessi.
La seconda massima è propria del modo di pensare ampio. Una volta che l’individuo acquisisce la prima massima (liberandosi da ogni pregiudizio e rendendosi attivo), il suo atteggiamento sarà angusto, al contrario di ampio, se non si eleverà al di sopra delle condizioni private e soggettive del giudizio; inoltre, esso dovrà riflettere sul proprio giudizio mettendosi, appunto, nel punto di vista altrui, ossia nel punto di vista universale. Questa massima è propria della capacità di giudizio, come la prima dell’intelletto e la terza (conseguente alle prime due) della ragione.
Pur sorgendo da un palese “disinteresse”, in seguito, il giudizio di gusto può acquisire due particolari interessi: l’interesse empirico, motivato dalla fondamentale comunicabilità del giudizio, per cui il bello ci interessa solo in società, rivelando una specie di contratto originario fra gli uomini; e l’interesse intellettuale, che invece sorge “in solitudine”: chi lo prova non ha bisogno di comunicare tale piacere a qualcuno, e l’oggetto a cui si riferisce è reputato bello non per vanità (non vogliamo impossessarcene per abbellire la nostra casa), ma unicamente per la sua esistenza. Questo interesse è rivolto particolarmente agli oggetti della natura ed ha senso morale.