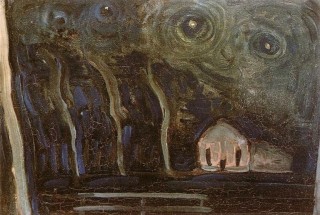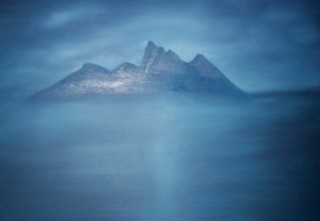“Questo breve romanzo è anche l’atto di nascita di un nuovo narratore…”[1]. Con queste parole, Guido Piovene introduceva nel 1958 Notte del diavolo di Oliviero Honoré Bianchi, un testo affascinante e di forte impatto che non sarà seguito da altri romanzi, come Piovene auspicava, ma che indubbiamente lascerà un segno. Un testo dalla realizzazione travagliata, come la vita del suo autore, che però saprà portargli grandi soddisfazioni.
“Questo breve romanzo è anche l’atto di nascita di un nuovo narratore…”[1]. Con queste parole, Guido Piovene introduceva nel 1958 Notte del diavolo di Oliviero Honoré Bianchi, un testo affascinante e di forte impatto che non sarà seguito da altri romanzi, come Piovene auspicava, ma che indubbiamente lascerà un segno. Un testo dalla realizzazione travagliata, come la vita del suo autore, che però saprà portargli grandi soddisfazioni.
Inizialmente, di Notte del diavolo esistevano solo un paio di capitoli scritti dall’autore alcuni anni prima della fine della Seconda guerra mondiale su suggerimento di Cesare Pavese, che ne aveva riconosciuto il talento. La chiamata alle armi, però, costringerà Oliviero Honoré Bianchi a sospenderne la stesura e a riprenderla solo molti anni dopo quando, unico sopravvissuto della sua famiglia, riuscirà a risolvere i problemi finanziari che lo attanagliano. Nel 1953, dalla fusione dei pochi capitoli già scritti, l’autore trarrà un racconto breve, Uno senza scampo, vincitore quello stesso anno del Premio Pordenone. Visto il successo di questa prima stesura, Bianchi riprenderà definitivamente in mano il testo per ultimarlo nel 1958 quando sarà pubblicato dalla Mondadori.
L’uscita del libro porterà una certa fama a Honoré Bianchi, che non solo sarà in lizza per il Premio Strega e per il Viareggio-opera prima, ma vincerà nel 1959 il Premio Bagutta-Fracchia raccogliendo più di sessanta recensioni dei maggiori critici letterari italiani, tutte positive. A colpirli favorevolmente sarà non solo la maturità del testo, cosa rara in un’opera prima, ma anche la profondità psicologica e uno stile narrativo impeccabile[2].
Date simili premesse, può alquanto sorprendere che Honoré Bianchi, durante un’intervista, dichiarasse che il genere letterario in cui si riconosceva di più era quello dell’elzeviro, ma bisogna considerare che la sua era una produzione molto varia, che includeva la prosa, la narrativa, la poesia e perfino la critica e l’arte, senza dimenticare l’opinione che aveva di se stesso: “Come scrittore, mi considero un autodidatta, un irregolare; quanto all’indole, sono un discontinuo-dispersivo, con le aggravanti dell’incontenibilità e della parsimonia: incline cioè a compimenti molto ritardati.”[3] Il romanzo sarà tradotto in inglese un paio di anni dopo con il titolo Devil’s Night e con una presentazione volta a sottolineare più l’aspetto “ironico” del testo che quello “tragico”.
Il libro è stato ripubblicato nel 2004 nella collana Trieste d’Autore del quotidiano Il Piccolo, ma nel resto d’Italia è reperibile solo presso alcune biblioteche, mentre il nome di Oliviero Honoré Bianchi è completamente dimenticato.
La storia di Notte del diavolo parte da un’idea molto semplice che comporta innumerevoli risvolti. I personaggi principali sono tre, Gianna, Fabio e l’antiquario Mainardis, che in una notte come tante decidono di organizzare un furto al museo dove i genitori di lei lavorano come custodi. Il colpo è stato ideato dall’antiquario che, approfittando di un impellente bisogno di denaro da parte di Fabio, ha ben pensato di suggerirgli il furto e di obbligarlo a coinvolgere anche la sua ragazza, Gianna, per la quale Mainardis prova un’attrazione morbosa. L’operazione, di per sé, non comporta alcuna difficoltà, e tutto andrebbe per il verso giusto se non fosse per le personalità tormentate dei tre , ai quali l’atmosfera notturna farà sorgere dubbi e incubi che li indurranno a non concludere nulla: Gianna, vogliosa e consapevole di quel potere che è in grado di esercitare sugli uomini, approfitterà del buio del museo per attrarre ancora una volta a sé Fabio; Fabio, volgare seduttore per il quale una ragazza vale l’altra, si lascerà vincere da mille timori e rinuncerà ai suoi propositi e l’antiquario Mainardis passerà una vera e propria notte da incubo, tra sotterfugi, tentativi di omicidio falliti e soprattutto terribili pensieri che gli bombarderanno la mente rendendolo incapace di ragionare.
Come afferma lo studioso Bruno Maier, si tratta in effetti di personaggi che risentono fortemente dell’influenza del mito sveviano dell’«inettitudine» e di quello moraviano dell’«indifferenza», sono esseri umani destinati fin dall’inizio al fallimento e avviati verso una strada di perdizione che sembra senza uscita. Soprattutto la figura dell’antiquario Mainardis, che cerca in amori morbosi quella scintilla che gli dia la forza di andare avanti, e che pur essendo consapevole della sua condizione di uomo finito si illude, distruggendo la vita degli altri, di trovare ancora la forza di continuare la propria.
Quello che colpisce e che cattura di questo romanzo è soprattutto la straordinaria abilità di Oliviero Honoré Bianchi, nato ad Abbazia nel 1908 da padre triestino e madre francese, di descrivere la notte, con le sue atmosfere e i suoi incubi. La notte come metafora di un animo tormentato che non trova pace, come simbolo di un uomo che cerca i suoi nemici all’esterno e non si rende conto di essere lui stesso il suo peggior nemico. Una notte, che si presenta apparentemente serena e tranquilla ma che sa risvegliare i sentimenti più reconditi mettendo a nudo la vera personalità dell’uomo. Una notte, che per il solo fatto di esistere, è in grado di suscitare l’angoscia più terribile, in cui la psicologia profonda di Italo Svevo si fonde all’ossessione schizofrenica di Edgar Allan Poe. A questo si aggiunge l’abilità dell’autore nel mantenere sempre alta la tensione attraverso l’utilizzo di quel monologo interiore tanto caro a Moravia e a molti altri autori:
[…] Pur seguendo con gli occhi lo sbracciarsi della sua ombra attraverso la via, non sembrava farci caso. Parve accorgersi, invece, di voci sussurrate che erano dentro di lui, o intorno chissà dove, ma nitide e vicine: come d’un tratto, nel silenzio e in solitudine, inattese battute di una radio che non si sapeva aperta. “Tanto per incominciare, signor Mainardis, questo c’è: istigazione a delinquere”. “Io?”. “Lei”. “Ho istigato a delinquere, io? Che storia è questa?”. “Una storia semplicissima. Tutt’e due gli imputati hanno dichiarato ch’è stato lei a consigliarli, a istruirli, per quel furto al museo”. “Fantastico! E nient’altro?”. “Sì, c’è ancora dell’altro”. “Ah, sì? Benone! Sentiamo allora…”.
Era meno sciolto nel passo, ora. Le labbra seguivano un moto di parole non dette; il viso si componeva e scomponeva nell’alternarsi di due espressioni contrastanti: una intenta, severa, l’altra stupefatta e ironica. “Sciocchezze!”, si disse; e fece un risolino. Sarebbe entrato nel caffè senza indugiare, ma calmo, badando di non apparire precipitoso. Chiesta la consumazione, e prima che gliela servissero, si sarebbe recato nella cabina a telefonare, quasi svogliato, indifferente. Dopo avrebbe potuto bere in santa pace il suo caffè: dopo. […]
Sarebbe importante riscoprire quest’opera di Oliviero Honoré Bianchi, per la forza della sua scrittura e per le emozioni che può ispirare, anche attraverso quel suo stile cinematografico che stimola l’immaginazione a mano a mano che si procede nella lettura.