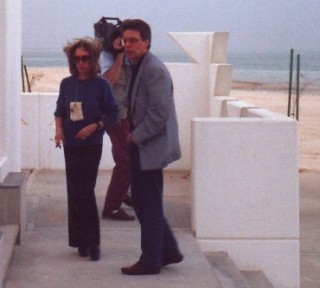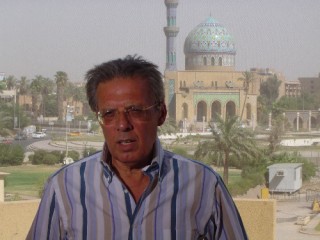Nella splendida cornice della chiesa di San Francesco, nel cuore di Cividale del Friuli, si è tenuto nel pomeriggio del 14 luglio il secondo appuntamento del ciclo dei Mittelincontri, dal titolo Sul filo delle guerre: Pino Scaccia: vent’anni da inviato, dedicato allo storico inviato della Rai.
Scaccia ha lavorato più di trent’anni per il TG1, e ha raccontato con chiarezza e professionalità questi ultimi due decenni che hanno cambiato il mondo. Al Mittelfest del ventennale, il cronista commenta, insieme al caporedattore della sede Rai di Trieste Giovanni Marzini, il documentario da egli stesso realizzato Vita da inviato, un vero e proprio diario in prima linea – in cui sono raccolti i migliori servizi, reportage e dirette della sua carriera – segnato da due spartiacque della storia: il 1991 e il 2001. L’incontro è, però, anche l’occasione per ragionare sul modo di fare giornalismo oggi e su quanto sia cambiata la professione in questi anni.
“Ho passato diciotto direttori al Tg1, ma tutti mi hanno sempre chiamato il cronista delle emergenze” ha detto Scaccia al pubblico.“Ogni volta che accadeva un avvenimento importante, io partivo già il giorno stesso”. La stoffa del cronista con la valigia sempre pronta l’ha sempre avuta, e le immagini che scorrono sullo schermo in fondo alla chiesa documentano ogni anno degli ultimi venti, di cui Scaccia è stato un testimone privilegiato: dal 1991, con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, l’inizio del conflitto jugoslavo e la prima guerra del Golfo, passando per l’11 settembre 2001, fino alla più recente guerra in Libia, ancora in corso. Scaccia è stato presente ad ognuno di questi eventi, ai quali si aggiungono anche le stragi di mafia del 1992, la guerra civile in Albania, le guerre in Afghanistan e in Iraq.
Non ama, però, definirsi inviato di guerra, ma solo un semplice cronista. “In guerra si raccontano fatti, vicende esattamente come si fa per la normale cronaca di un omicidio o di un processo giudiziario. E a me piace essere considerato un semplice cronista, il tramite tra l’evento e gli spettatori a casa, a differenza di molti altri miei colleghi”, afferma Scaccia.
Il suo battesimo del fuoco avvenne con la prima guerra del Golfo, nel 1991, con una grande penna del giornalismo italiano: Oriana Fallaci. Le immagini del loro incontro aprono il documentario: “Ci incontrammo in Arabia Saudita, lei stava per lasciare il Medio Oriente mentre io ero appena arrivato, e a breve sarei andato a Kuwait City. Mi scrisse una dedica, che custodisco gelosamente nel mio studio”, riporta il cronista.
E quelle righe rappresentano una piccola lezione di storia del giornalismo:
A Pino Scaccia,
la vigilia del tuo ingresso a Kuwait City –
(con l’augurio da una che ne è appena tornata e ci ha trovato quel che gli altri non ci hanno trovato, e non ci ha trovato quello che gli altri ci hanno trovato…)
Affettuosamente, Oriana Fallaci.
Ma il mondo corre, così come la sua storia. Ed è già tempo di un viaggio verso un nuovo conflitto che sta insanguinando i Balcani: la guerra in Croazia. “Sono stato il primo giornalista occidentale ad entrare a Vukovar, nel novembre 1991, durante i primi combattimenti tra serbi e croati. Ero in trincea tra le linee croate, mentre venivano attaccate”, ricorda Scaccia. Con la troupe del TG1 ha raccontato il capodanno di una famiglia di Karlovac, a qualche centinaio di chilometri da Zagabria, nascosta in un bunker per avere salva la vita. “Quando il mondo intero si concedeva di festeggiare per il nuovo anno, in Croazia le bombe non hanno mai smesso di cadere, neanche durante le feste”, diceva il cronista nelle immagini del servizio inserito nel documentario.
“Tutti avevano capito la guerra del Golfo, tutti sapevano che la ragione prima del conflitto era il petrolio. Eppure, la guerra nei Balcani non l’abbiamo mai capita fino in fondo, soprattutto noi italiani, nonostante si sparasse a qualche chilometro dai nostri confini”, afferma. Anche in Jugoslavia, però, c’erano ragioni economiche che l’Europa, e l’Occidente tutto, forse, non vedevano chiaramente. “C’era una battuta che girava quando stavo a Zagabria: noi guadagniamo i soldi, e Belgrado incamera e spende tutto”, ricorda Scaccia.
Una delle pagine più belle del nostro giornalismo, tuttavia, l’ha scritta entrando nella centrale nucleare di Chernobyl, cinque anni dopo l’incidente che aveva sconvolto il mondo. Ha visitato quel che restava di quel mostro di cemento e lamiere sventrato dall’esplosione del reattore numero 4, spingendosi fin là dove nessun cronista occidentale aveva voluto recarsi. “Quel viaggio mi ha colpito molto. In quel luogo ho visto la morte del mondo. Tutto era immobile, freddo e abbandonato. Non c’era vita, non c’era nessuno”, afferma il cronista.
E mentre i Balcani bruciavano e la prima guerra del Golfo volgeva al termine, l’Italia era scossa dalle stragi di mafia del 1992, con l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. “Era impossibile intervistare Falcone a Palermo, perché era super-blindato, davvero inavvicinabile”, ricorda Scaccia. E mentre parla, sulla sfondo scorrono le immagini dell’unica intervista che ha realizzato con il giudice Falcone, a Stoccolma, durante un convegno. Questa triste pagina della nostra storia contemporanea offre lo spunto per una riflessione sul fare giornalismo oggi, incalzato da una domanda del caporedattore Marzini sulla maggiore responsabilità del mestiere di cronista negli anni Novanta.
“Certo, al tempo c’era un giornalismo più responsabile, si prestava molta più attenzione e cura nel proprio lavoro. Oggi, con l’avvento della tecnologia, molte cose sono cambiate”, dichiara Scaccia. L’informazione ai tempi di internet corre veloce e le notizie devono essere pubblicate subito dopo il fatto che raccontano, quasi in tempo reale. La sete di notizie non è mai troppa. Per il giornalista “è così nato un giornalismo più attento alla quantità che alla qualità, c’è tanta immediatezza degli eventi e poco approfondimento”.
È bene però tornare al documentario, intanto arrivato al 1994. Un annus horribilis per i reporter italiani: nel marzo di quell’anno la troupe della sede Rai di Trieste inviata in Bosnia, composta dal giornalista Lucchetta, il tecnico Alessandro Ota e il cameraman Dario D’Angelo, veniva uccisa da una granata mentre stava girando un servizio sui bambini ricoverati nell’ospedale di Mostar Est, mentre in Somalia venivano uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Le immagini inserite nel documentario si riferiscono al servizio che Lucchetta stava preparando, ma che purtroppo non ha mai montato.
Durante la guerra in Croazia mi è capitato spesso di essere a Trieste, ed è stato in quel periodo che ho conosciuto Lucchetta. Lui, come la Alpi, non erano, anzi, non sono degli inviati di guerra, ma semplici cronisti. Lucchetta raccontava la difficile vita dei bambini in guerra, e Alpi i malaffari dei trafficanti a Mogadiscio .
Arriviamo così al secondo spartiacque della storia degli ultimi due decenni, quell’11 settembre che ha portato alla guerra in Afghanistan e Iraq. Tutti noi ci ricordiamo la crudezza della immagini delle Torri Gemelle che si piegavano su loro stesse, portando con sé la vita di più di tremila persone. E Scaccia c’era, anche in questa occasione.
“Ero arrivato a New York con il primo volo dall’Italia. Ho trovato una città in silenzio, per più di tre giorni. Era davvero surreale”, ricorda. Tre mesi dopo era già a Kabul, per raccontare la guerra contro i Talebani voluta dall’ex-presidente Bush. “Dopo dieci anni di conflitto, possiamo benissimo dire che l’intervento in Afghanistan si è dimostrato privo di benefici e risultati positivi”, sostiene il giornalista.
1991, 2001, 2011: ogni dieci anni, la storia cambia. E questo è l’anno delle rivolte popolari nell’area del Nord Africa, con la destituzione dei regimi di Ben Alì in Tunisia e Mubarak in Egitto. E la Libia, di cui si parla sempre meno sui giornali e nelle televisioni, che fine ha fatto?
“Io sono stato a Bengasi per molte settimane, e posso dire che il caso della Libia non è affatto quello della Tunisia e dell’Egitto. Là in tre giorni i despoti sono stati cacciati e arrestati, ma in Libia Gheddafi è ancora al suo posto. Se fosse stata una rivolta vera, l’avrebbero preso subito”, dice. La disinformazione, poi, ha giocato un ruolo molto importante, capitanata dall’emittente del Qatar Al-Jazeera, mettendo in piedi una serie di notizie che poi si sono rivelate dei falsi clamorosi – su tutti l’infondata notizia del rinvenimento di una fossa comune nel cimitero di Tripoli.
Così, parlare delle rivolte del mondo panarabo, stimolati da un pubblico molto attento, spinge i due interlocutori ad interrogarsi sulle nuove tecnologie che tanto hanno trasformato e stanno trasformando la professione del giornalista. Scaccia è un cronista della vecchia generazione, ma attento ai nuovi mezzi di comunicazione. Ha una pagina su Facebook, un profilo Twitter ed è un blogger da molto tempo. “Credo che Internet sia uno strumento incredibile, ma bisogna usarlo con attenzione” – afferma – “ma al tempo stesso è da usare consapevolmente. Io posso caricare un qualsiasi video su YouTube, raccontando un fatto falso, e basta che quel video venga visto, commentato e ripreso da migliaia di utenti fino ad arrivare sul sito dei grandi quotidiani e considerato come notizie vera e propria”. Sembrerebbe questo l’avviso per le nuove generazioni di giornalisti: usare Google, ma con criterio.
“Non bisogna confondere l’anarchia del dire ciò che si vuole su Internet con la libertà di stampa e di espressione”, sostiene.
Il documentario, volgendo al termine, mostra le immagini di Scaccia impegnato nel raccontare la guerra in Libia: prima a Bengasi, poi davanti ai pozzi petroliferi della Cirenaica, e infine tra gli insorti a Rās Lānūf. E quello che si porta con sé dopo questo incontro, è la certezza che la vita dell’inviato di guerra – come testimonia l’esperienza di Scaccia – è sempre più difficile. Si stima che ogni anni perdano la vita circa cento giornalisti impegnati nel loro lavoro. E in situazioni e contesti ardui, viene naturale chiedersi se valga la pena andare avanti, continuare, rischiando la propria vita, a riferire i fatti crudi e tragici di un conflitto. Scaccia prova a raccontare al pubblico la sua esperienza: “C’è stata solo una volta in cui ho temuto davvero il peggio. Eravamo poco fuori Bagdad, quando siamo stati attaccati da un gruppo di banditi armati di kalashnikov che volevano rapinarci. Scappammo via velocissimi, ma ci bucarono comunque una ruota e ferirono il nostro autista. Lì ho pianto, e dissi che non sarei mai più tornato in Iraq. Il mese dopo ero di nuovo lì”.
E allora, in futuro, ci sarà ancora posto per gli inviati di guerra nel nuovo mondo dell’informazione? “Penso proprio di sì, perché un mondo senza testimoni è un mondo peggiore, e per mia fortuna ho assistito a molti fatti che questo mondo lo hanno cambiato”.