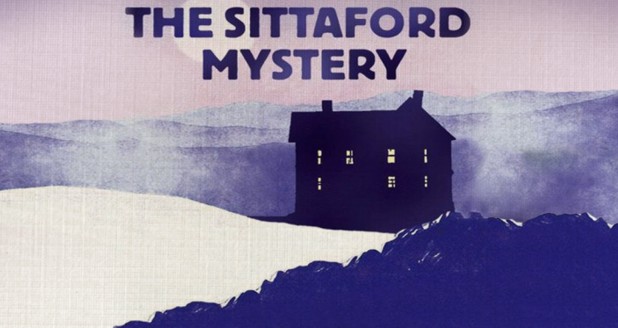Autore: Herta Müller
Traduzione: Alessandra Henke
Titolo originale: Herztier
Anno di pubblicazione: 1994
Prima ed. italiana: 2008
Editore: Keller Editore, Trento
Collana: Vie
Pagine: 256
Prezzo: 16,00 Euro
ISBN: 9788889767078
E quando ci penso, è come se ogni morto si lasciasse alle spalle un sacco di parole. Mi vengono sempre in mente il barbiere e le forbici, perché i morti non li utilizzano più. E il fatto che i morti non perdono un bottone.
Herta Müller, Il paese delle prugne verdi

“Con la forza della poesia e la franchezza della prosa, descrive il panorama dei diseredati”. Con queste parole gli accademici svedesi, sottolineando nuovamente la loro attenzione per una scrittura impegnata dai contenuti etici e sociali, nel 2009 hanno incoronato Herta Müller Premio Nobel per la Letteratura. Ed è stata una vittoriaa sorpresa: la scrittrice era poco conosciuta al grande pubblico, in Italia come negli Stati Uniti. E lo stupore è stato perfino maggiore vista la concorrenza al titolo di nomi celebri quali Amos Oz, dato alla vigilia per favorito, e Philip Roth, anche se per questi ultimi probabilmente si tratta solo di un arrivederci al prossimo anno.
Nota agli addetti ai lavori, soprattutto di lingua tedesca, Frau Müller si era già distinta in numerosi premi letterari, tra cui ricordiamo l’Impac Dublin Literary Award, il Premio Kleist, il più prestigioso premio letterario tedesco, il Premio Franz Kafka, il Premio Konrad Adenauer e il Premio letterario europeo Aristeion. Nata nel 1953 a Nitzkydorf, nel Banato svevo — una regione di cultura e di lingua tedesca passata intorno al 1920 sotto il controllo della Romania — ha studiato letteratura tedesca e romena nella città di Timisoara. Ha fatto parte di un gruppo di scrittori dissidenti raccolti attorno al giornale Neue Banater Zeitung, impegnati in una cultura di opposizione al regime di Nicolae Ceauşescu. In seguito al suo rifiuto di diventare una spia e di collaborare con la Securitate (la polizia segreta rumena), ha perso il lavoro e la possibilità di pubblicare. Perseguitata e censurata, si è così trovata costretta ad emigrare in Germania nel 1987. Questa breve biografia è importante per capire e apprezzare l’itinerario artistico della scrittrice, che è spesso una rielaborazione delle esperienze personali, avvenute in un contesto storico-sociale ben preciso.
 Purtroppo, nel nostro paese sono poche le tracce del passaggio della Müller, anche se, grazie all’effetto Nobel, l’editore milanese Feltrinelli ha acquistato i diritti di alcune opere che non tarderanno ad arrivare. Tra gli scritti attualmente tradotti in Italia possiamo trovare Una mosca attraversa un bosco dimezzato, breve storia inserita in Fuoricampo, antologia di racconti di autrici austriache e tedesche edito da Avagliano; Bassure, del lontano 1987, per Editori Riuniti, che è la traduzione dell’opera d’esordio Niederungen del 1982. La casa editrice Marsilio invece, già nel 1992, pubblicava In viaggio su una gamba sola — altro scritto dai contenuti autobiografici — sulle difficoltà e l’amarezza dell’esilio volontario e della costante fuga dalla dittatura. Infine, nel dicembre 2009, è uscito in Italia, edito da Sellerio, Lo sguardo estraneo, dove la scrittrice rumeno-tedesca racconta, con il suo stile abituale, la fatica l’angoscia e le oppressioni di un’esistenza sotto il controllo del regime.
Purtroppo, nel nostro paese sono poche le tracce del passaggio della Müller, anche se, grazie all’effetto Nobel, l’editore milanese Feltrinelli ha acquistato i diritti di alcune opere che non tarderanno ad arrivare. Tra gli scritti attualmente tradotti in Italia possiamo trovare Una mosca attraversa un bosco dimezzato, breve storia inserita in Fuoricampo, antologia di racconti di autrici austriache e tedesche edito da Avagliano; Bassure, del lontano 1987, per Editori Riuniti, che è la traduzione dell’opera d’esordio Niederungen del 1982. La casa editrice Marsilio invece, già nel 1992, pubblicava In viaggio su una gamba sola — altro scritto dai contenuti autobiografici — sulle difficoltà e l’amarezza dell’esilio volontario e della costante fuga dalla dittatura. Infine, nel dicembre 2009, è uscito in Italia, edito da Sellerio, Lo sguardo estraneo, dove la scrittrice rumeno-tedesca racconta, con il suo stile abituale, la fatica l’angoscia e le oppressioni di un’esistenza sotto il controllo del regime.
E poi c’è l’opera più importante di Herta Müller, pubblicata in Germania nel 1994, Herztier, che suonerebbe più o meno come la “bestia del cuore”. In Italia si è preferito riprendere il titolo dell’edizione inglese, e possiamo così fortunatamente apprezzare Il paese delle prugne verdi, divenuto protagonista di una simpatica fiaba editoriale. Roberto Keller, appassionato quarantenne che fa capo appunto alle Edizioni Keller, aveva comprato al tempo i diritti dell’opera per mille euro. La piccola case editrice di Rovereto, nel 2008 vendette solamente 800 copie del romanzo su una tiratura di 1500. Oggi si conta invece la quinta ristampa, con 48 mila copie distribuite. Un Nobel cambia la vita, non solo a chi lo riceve.
Il titolo del libro si rifà al ricordo delle parole del padre alla narratrice: “Non bisogna mai mangiare prugne verdi, il nocciolo è ancora tenero e s’ingoia la morte. Nessuno ti può aiutare, allora si muore e basta. Con una febbre chiara il cuore ti brucia da dentro”. Popolarmente, “mangiaprugne” era anche un insulto. Si chiamavano così gli arrivisti, i ruffiani. Eppure tutti, nel paese delle prugne verdi, se ne riempiono le tasche delle giacche e ne mangiano con avidità. Capiamo che Herta Müller ci narra di un paese morto, desolato e senza futuro. Di un paesaggio spoglio, fatto di poveri villaggi e città tristi, di uomini abbruttiti dal terrore della dittatura e di operai di un mattatoio che rubano frattaglie e bevono sangue di animali.
 In questa Romania degli anni Ottanta, quattro persone si avvicinano dopo lo strano suicidio di una ragazza di nome Lola. Iniziano a condividere le loro paure, le letture proibite dal governo e i segreti più difficili da confessare. Ad unirli intensamente è un sentimento di disprezzo verso il regime e l’immensa voglia di libertà e di amicizia in un paese dove regna la diffidenza verso il prossimo in quanto potenziale spia arruolata dalla Securitate. Ma il terrore si stende come un’ombra e i quattro amici subiscono interrogatori umilianti da parte del capitano Pjele, accompagnato dal suo cane chiamato anch’esso Pjele, presenza che spesso rende difficile distinguere quale dei due sia la bestia. I protagonisti vengono sottoposti a vili intimidazioni, pedinamenti e persecuzioni che rischiano di portarli alla follia. Finché uno di loro viene assassinato e il suo omicidio fatto passare per suicidio, probabilmente per l’ennesima volta. In questo mare di morte e terrore, tuttavia, l’amore e l’amicizia sopravvivono nella speranza di un espatrio, attraversando il Danubio, alla ricerca di un futuro.
In questa Romania degli anni Ottanta, quattro persone si avvicinano dopo lo strano suicidio di una ragazza di nome Lola. Iniziano a condividere le loro paure, le letture proibite dal governo e i segreti più difficili da confessare. Ad unirli intensamente è un sentimento di disprezzo verso il regime e l’immensa voglia di libertà e di amicizia in un paese dove regna la diffidenza verso il prossimo in quanto potenziale spia arruolata dalla Securitate. Ma il terrore si stende come un’ombra e i quattro amici subiscono interrogatori umilianti da parte del capitano Pjele, accompagnato dal suo cane chiamato anch’esso Pjele, presenza che spesso rende difficile distinguere quale dei due sia la bestia. I protagonisti vengono sottoposti a vili intimidazioni, pedinamenti e persecuzioni che rischiano di portarli alla follia. Finché uno di loro viene assassinato e il suo omicidio fatto passare per suicidio, probabilmente per l’ennesima volta. In questo mare di morte e terrore, tuttavia, l’amore e l’amicizia sopravvivono nella speranza di un espatrio, attraversando il Danubio, alla ricerca di un futuro.
Il romanzo non appassiona per le vicende dei personaggi, i “senza nome” della Storia, che da essa sono schiacciati per mano e nel ruolo di Ceauşescu. Non sono predominanti i fatti. Sono il tessuto narrativo e lo stile utilizzato dalla scrittrice a far vibrare l’opera. Anche per merito della traduzione di Alessandra Henke, vediamo Herta Müller porsi ai margini della narrazione, alla ricerca di una visione distaccata e svuotata di sentimenti personali. Ne nasce un poema in prosa dalla scrittura basilare ma febbrile. Grazie alla poesia delle sue figure, l’autrice riesce ad evocare la povertà di un intero paese e la memoria di un crimine del passato.
Raccontando un “realismo socialista” — alla vicenda principale spesso si alternano alcuni flashback della narratrice bambina — l’autrice esprime l’illogicità di ciò che vede. Senza mediazioni di sorta, rende lo scritto surrealista, e le immaginifiche descrizioni sono l’unico mezzo per poter cogliere la realtà. Si incontrano, così, i gesti e la scrittura, in una ridondanza di frammenti spezzati che danno una sensazione di nonsense, venendo a mancare qualsiasi soluzione di continuità.
Privati della logica di causa effetto, non si ha più nessun controllo sulle cose, le quali avvengono perché avvengono, tautologicamente, e si ripetono nel tempo, eliminando così il significato profondo di ogni gesto o azione. Indicativa, in tal senso, è la frase che scatena un cortocircuito, perché al contempo inizio e fine del romanzo: “Se stiamo in silenzio, mettiamo in imbarazzo, diceva Edgar, se parliamo, diventiamo ridicoli”.
Un’irrealtà dove le parole non sono più la metafora del senso: “Scrivendo, non dimenticare la data e metti sempre un capello nella lettera, disse Edgar. Se dentro non c’è, vuol dire che la lettera è stata aperta. Singoli capelli, pensai tra me, sui treni, attraverso il paese. Un capello scuro di Edgar, uno chiaro, mio. Uno rosso di Kurt e Georg. Entrambi venivano soprannominati dagli studenti ragazzi d’oro. Per l’interrogatorio una frase con forbici per unghie, disse Kurt, per la perquisizione una frase con scarpe, per il pedinamento una frase con raffreddato. Dopo il titolo sempre un punto esclamativo, per una minaccia di morte solo una virgola”.