Autore: Elena Pulcini
Traduzione: Riccardo Duranti
Editore: Bollati Borlinghieri, Torino
Anno di pubblicazione: 2009
Collana: Nuova cultura
Pagine: 298
Prezzo: 16 Euro
ISBN: 8833920135
Elena Pulcini è Professore Ordinario di Filosofia Sociale presso l’Università di Firenze ed è indubbiamente una delle personalità più attive e produttive dell’odierno scenario filosofico italiano. I suoi interessi si concentrano sulla teoria critica e sul ruolo della donna nella società moderna, nonché sulle dinamiche culturali sottese alla globalizzazione. Il suo ultimo volume, dal titolo La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale, pubblicato da Bollati Boringhieri, ha ricevuto lo scorso anno, spartendosi il primo posto con Eugenio Borgna, uno dei premi di filosofia più prestigiosi d’Italia, ovverosia il “Viaggio a Siracusa”, presieduto da Remo Bodei e Umberto Curi. Un riconoscimento meritato per la qualità dello splendido testo, scorrevole nella scrittura senza mai sacrificare il tenore teorico e concettuale dei contenuti.
La cura del mondo è una lucida e pregevole testimonianza di come la filosofia possa essere in grado, oggi, di relazionarsi alle specifiche problematiche della contemporaneità, abbandonando astrazioni lontane dal mondo e dai suoi problemi. Soprattutto, perché dall’analisi e dall’interpretazione del mondo e delle sue caratterizzazioni odierne l’autrice passa anche alla proposta concreta, per certi aspetti utopica, mantenendo uno sguardo speranzoso nei confronti dell’avvenire.
Chilometri di pagine sono state scritti sulla società cosiddetta “postmoderna”, sulla globalizzazione e sulle modalità attraverso le quali gli individui si relazionano all’interno di essa e delle sue influenze. Approssimando, la maggior parte dei testi sono suddivisibili in due categorie, che sostengono due tesi opposte: quella dell’esasperante individualismo del capitalismo avanzato oppure la prospettiva comunitaria, che rivela, come fenomeno evidente, la tendenza al ritorno della costituzione di gruppi fondati su interessi comuni.
La Pulcini assume nella sua riflessione la dialettica di entrambe queste dimensioni, parlando di “individualismo illimitato” e “comunitarismo endogamico”, manifestazioni entrambe della patologia dell’età globale. Nell’individualismo, il protagonista è l’Io narcisistico, che «si fa portatore di un’immagine di riconciliazione e di quiete» dove è possibile «liberare ciò che è stato sacrificato al principio di prestazione capitalistico: l’immaginazione, il piacere, il sentimento di una profonda alleanza con la natura, la pienezza di un’esistenza non più soggetta al ricatto di una strumentale progettualità e di un’illimitata appropriazione». Tale illimitatezza raggiunge livelli parossistici, degenerando nel narcisismo sconclusionato; con la perdita dell’autorità parentale, con la trascuratezza nei confronti delle sorti altrui e del mondo, questo mondo diviene il teatro delle sue volontà: «un Io desiderante e fluido, vuoto di contenuti e unicamente sensibile alle pressioni e agli imperativi del presente». L’individuo nell’era globale, d’altronde, ha a che fare con rischi a lui un tempo sconosciuti, frutto dell’indiscriminata evoluzione tecnologica, erodendo il «sentimento di immunità» caratteristico dei membri dello Stato moderno.
A tale individualismo corrisponde «in maniera speculare e complementare, un bisogno di ri-delimitazione che si esprime nella (ri)nascita di aggregazioni comunitarie». Dal bisogno di comunità, il rischio è quello di passare a un’autentica patologia. Il referente più importante, in questa prospettiva, è il sociologo Zygmunt Bauman, teorizzatore della «società liquida» e autore che nelle sue opere ha messo in evidenza la necessità, nel mondo postmoderno, di ri-costituire gruppi sociali dispersi nel vortice della globalizzazione. Pulcini ci tiene a precisare come la tendenza alla costituzione di gruppi non sia di per sé la manifestazione di una regressione, ma nemmeno una valida opposizione alle dinamiche della globalizzazione. Ci sono infatti «due matrici fondamentali del bisogno di comunità: la prima consiste nella risposta alle patologie dell’individualismo globale, la seconda, nella risposta alle dinamiche di esclusione che la società globale radicalizza estendendole a livello planetario».
Ciò a cui assistiamo oggi, in maniera sempre più diffusa (specie nel nostro paese), è l’ambizione a una comunità della paura, «la quale nasce difensivamente come luogo protettivo per individui orfani, contro coloro che non devono farne parte». Si tratta di comunità “in negativo”, che nascono basandosi sul principio di esclusione, alimentando ulteriormente quella paura trasmessa loro dall’immagine del diverso e dell’altro. L’assolutizzazione dell’Io coincide con l’assolutizzazione del Noi: «L’altro (lo straniero, il diverso, il migrante, il clandestino) diventa il bersaglio su cui spostare le proprie paure, su cui proiettare un’angoscia persecutoria che lo trasforma nel responsabile dei pericoli che minacciano una società sempre più privata delle tradizionali istanze di controllo».
Il concetto di «paura» ha una funzione essenziale all’interno di tutto il saggio, visto che tale concetto incarna in sé la dialettica fondamentale attorno a cui ruota l’intera argomentazione: Elena Pulcini tenta di ricomprendere la paura liberandola dalla sua connotazione dispregiativa, spiegando come una paura “positiva” sia essenziale per mutare le modalità del nostro “abitare il mondo”. D’altronde, la paura aveva una funzione essenziale già nel Leviatano del filosofo politico Thomas Hobbes: secondo il pensatore secentesco, è proprio dinanzi alla paura nei confronti della natura che l’uomo ha deciso di costituire dei gruppi sociali regolamentati secondo una normatività politica. Nella modernità, le soluzioni adottate per sconfiggere la paura e annullare il pericolo sono state la tecnica e la politica. Il paradosso a cui assistiamo in epoca moderna, però, è che tale tecnica ha rimosso a tal punto la paura dalla quale sorse da renderci tutti assolutamente indifferenti per le sorti del mondo, e al contempo, la stessa tecnica nata per arginare la paura del mondo è diventata la fonte di nuove paure (oggi, i rischi maggiori sono relativi a minacce di ordine nucleare, ad armi sempre più sofisticate, a catastrofi che trovano la loro ragione nel dominio dell’uomo sull’ambiente…). Ciò a cui assistiamo ora è la diffusione di due fenomeni solo apparentemente antitetici: un’assenza di paura come dimostrazione di deresponsabilizzazione nei confronti delle sorti del mondo e un eccesso di paura che porta al rifiuto di qualsiasi azione e al tentativo di comporre gruppi sociali riuniti attorno a tale paura: «l’assenza di paura e l’eccesso di paura altro non sono che due facce della stessa medaglia».
Da un lato, perciò, la necessità è quella di «riattivare la paura». In questa prospettiva è centrale il contributo di Hans Jonas e del suo «principio responsabilità»: tornare ad aver paura, coincide ad «aver cura» del mondo, perché significa sensibilizzarsi nei confronti delle sue sorti. Per questo, Pulcini ci tiene a mettere l’accento sulla contrapposizione tra una «paura per…» e una «paura di…»: la seconda esplicita una determinazione dell’oggetto della paura, circoscrivendolo forzatamente e inquadrandolo in maniera maniacale. La «paura per» si relaziona invece alla minaccia che riguarda tutti, e induce a un «riconoscimento solidale». Così l’uomo può ritrovare un limite al proprio egoismo, e al contempo al suo desiderio di difesa espresso nell’appartenenza a un gruppo: «rompere il muro del diniego e dell’indifferenza per restituire all’individuo, attraverso la percezione del pericolo, la memoria della propria vulnerabilità e la consapevolezza del limite; nel secondo caso, vuol dire interrompere, attraverso la capacità di esporsi all’altro e di accettare l’inevitabile contaminazione, la strategia difensiva e persecutoria prodotta da un distorto bisogno di comunità».
Avere «cura del mondo» significa ripensare l’intima natura relazionale di ciascuno di noi, assumendosi la responsabilità nei confronti dell’avvenire, sfidando il suo carattere di minaccia, perché tale futuro «è gia presente» nel nostro agire, un agire che trova fondamento nella consapevolezza che ciò che ci circonda «ci riguarda». Non solo «pre-occuparsi» del mondo, ma «occuparsene», avendo paura «per lui» e perciò prendendolo in cura, come una mamma fa col proprio bambino. L’etica della cura si configura così come la risposta adeguata nel mondo globalizzato: «Da un lato la sua universalità le consente di infrangere i limiti angusti della sfera privata e di includere come oggetto di preoccupazione e di attenzione un «mondo» esposto al rischio di degrado e di distruzione. Dall’altro, la sua concretezza si traduce nella capacità di intervento attivo e capillare nella infinita molteplicità delle situazioni, prima di tutto quotidiane, nelle quali il soggetto si trova ad agire».
Partendo dalla «vulnerabilità» di ciascuno, si tratta di creare un mondo, assumendolo come fragile a sua volta, gestendolo con cura; paradossalmente la vulnerabilità si prospetta come unica condizione per la creazione di un mondo nuovo, dove l’accettazione della pluralità degli individui coincide col «prendersi cura» del mondo, ovverosia con la consapevolezza e la paura per quegli scenari che l’uomo sarà capace di produrre a causa proprio della sua vulnerabilità.

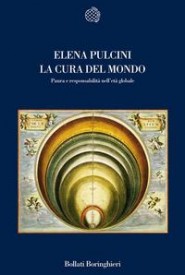

ottimo lo compro