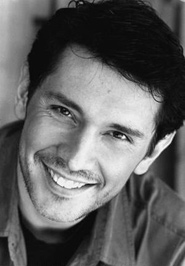 La parola “spazio” apre molte possibilità di dialogo per gli avvezzi ai teatri: si potrebbero intessere profondi discorsi sullo spazio scenico, sullo spazio tra finzione e realtà, sullo spazio interpretativo. A pochi, però, verrebbe in mente di accostare il teatro allo spazio stellare, a quello spazio fatto di pianeti e di universi. Non è una novità che la cultura si interessi a tali temi, basta pensare a tutta una serie di film che coinvolgono astronavi e alieni, o ai tanti romanzi che hanno reso le stelle dei mondi accessibili ai nostri sguardi. Si tratta appunto di un filone ben definito: quello della fantascienza. L’originalità del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia sta, invece, nella scelta di ospitare sul suo palco un concetto di spazio scientifico. Con Storia di un astronauta inizia dunque per lo spettatore un’avventura che mette al bando la fantasia e dona uno spaccato reale della vita a bordo della “Stazione Spaziale internazionale”. Il Rossetti festeggia i quarant’anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna con uno spettacolo di Fabio Poggiali, che ne è autore e interprete.
La parola “spazio” apre molte possibilità di dialogo per gli avvezzi ai teatri: si potrebbero intessere profondi discorsi sullo spazio scenico, sullo spazio tra finzione e realtà, sullo spazio interpretativo. A pochi, però, verrebbe in mente di accostare il teatro allo spazio stellare, a quello spazio fatto di pianeti e di universi. Non è una novità che la cultura si interessi a tali temi, basta pensare a tutta una serie di film che coinvolgono astronavi e alieni, o ai tanti romanzi che hanno reso le stelle dei mondi accessibili ai nostri sguardi. Si tratta appunto di un filone ben definito: quello della fantascienza. L’originalità del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia sta, invece, nella scelta di ospitare sul suo palco un concetto di spazio scientifico. Con Storia di un astronauta inizia dunque per lo spettatore un’avventura che mette al bando la fantasia e dona uno spaccato reale della vita a bordo della “Stazione Spaziale internazionale”. Il Rossetti festeggia i quarant’anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna con uno spettacolo di Fabio Poggiali, che ne è autore e interprete.
Il progetto è un omaggio alla memoria del capitano dell’Aeronautica Militare Maurizio Poggiali, suo fratello, scomparso nel 1997 nell’incidente aereo di Monte Lupone. Il capitano era studioso di Ingegneria spaziale e sarebbe diventato presto astronauta. Lo spettacolo si concentra sulla figura di Umberto Guidoni, il primo astronauta italiano a vivere a bordo della Stazione Spaziale internazionale, una vera e propria città costruita ed abitata nello spazio. In particolar modo, Poggiali ripercorre tre momenti della vita dell’astronauta europeo: la missione con la navetta “Columbia”, la missione sullo Space Shuttle Endeavour e il percorso di studi che ha permesso al protagonista di diventare astronauta. Nel cartellone dello Stabile la proposta di Poggiali è stata definita “un reading multimediale sull’avventura dell’uomo nello spazio” ed effettivamente Storia di un astronauta non può esser considerato uno spettacolo teatrale nel senso convenzionale del termine.
Le proiezioni video, sebbene notevolmente stimolanti da un punto di vista contenutistico, specie per chi è digiuno sull’argomento, risultano nozionistiche e prive di pathos, dei veri e propri documentari sulla vita spaziale. Le immagini descrivono l’assenza di gravità, gli esperimenti tecnici, le partenze degli shuttle, le modalità di lavorare nello spazio… per un attimo ci si dimentica di essere a teatro e si cerca il telecomando abbandonato sulla poltrona. Poi l’attore, quasi a voler ricordare al pubblico l’elemento teatrale, interviene con dei reading.

Purtroppo anche i momenti a leggio si mantengono sullo stile informativo e, mancando l’elemento emotivo, il pubblico si sente scarsamente coinvolto. In questa atmosfera prettamente didattica, i nobili moniti alla pace, alla tolleranza e alla collaborazione dei popoli risultano talmente scollegati dal contesto da apparire banali prediche “buoniste”. Certo il collegamento logico è evidente: “nello spazio — osserva l’autore — ed in particolar modo a bordo della stazione spaziale, vivono uno accanto all’altro russi, europei, americani, ognuno con la propria cultura, la propria religione, la propria lingua e tutti sono pronti a mettere insieme le risorse per il bene del progresso del mondo”. I richiami sono del tutto legittimi e veritieri ma, nell’insieme, risultano piuttosto naif. L’uomo è riuscito a conquistare la Luna ma non a portarla sulla terra: la cantano i poeti, la studiano gli scienziati, ma non c’è ancora stato un poeta-scienziato capace di raccontare al mondo le sue peculiarità salvaguardando la sua incredibile magia.

