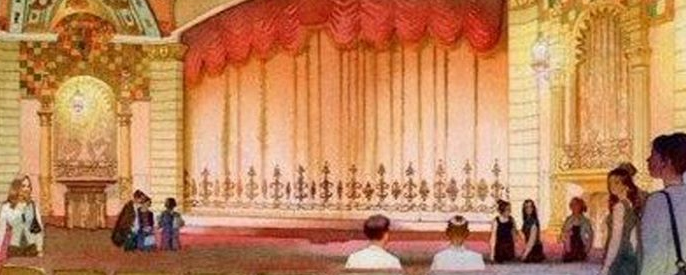Gabriele Vacis affronta il Checov maturo di Zio Vanja: opera scritta dal drammaturgo russo alla fine del diciannovesimo secolo, nel suo periodo di massimo successo, in parte grazie all’apprezzamento tributatogli da Stanislavskij.

Vacis impone il suo ritmo ad una commedia teatrale di per sé ben poco dinamica. Proprio sulla mancanza di dinamismo si abbatterono le critiche di Majakovskij, che condannava uno spettacolo in cui Zio Vanja si soffia il naso o conversa di argomenti domestici con Marija. In quel frangente d’inizio secolo, dove in Europa i nazionalismi diventavano predominanti, alla condanna del teatro senza idee di Checov parteciparono in molti, dal responsabile sovietico alla cultura, Lunacarskij, al futurista Marinetti. Unica voce fuori dal coro quella di Stanislavskij che, anzi, aveva rappresentato al Teatro d’Arte di Mosco l’altro capolavoro di Checov, Il Gabbiano.
Vacis, dunque, rispettando il parte i suggerimenti di Checov, sceglie di mantenere la scena a stretto contatto con il pubblico, lasciando aperto il sipario già durante l’ ingresso degli spettatori. Gli attori parlano sul palco tra di loro, mentre il pubblico un poco stupito si accomoda in sala. Per tutta la durata dello spettacolo, gli attori dialogheranno con il pubblico, senza, però, arrivare a mischiarsi con esso, come nelle indicazioni di regia volute da Checov. Vacis chiude idealmente il palco e, terminati i dialoghi, gli attori si accomodano ai margini della scena rimanendo ad osservare l’azione o magari il pubblico.
 La trama è semplice: al centro del racconto ci sono Zio Vanja e il professore Serebrjakov, interpretati rispettivamente da Eugenio Allegri e Alessandro Marchetti. Ad un certo punto, annoiato dalla monotonia della vita di campagna, il professore decide di vendere la sua tenuta, amministrata da Vanja, per trasferirsi in città. Quest’idea accende i rancori di Vanja, che arriva perfino a tentare l’omicidio nei confronti di Serebrjakov. Alla fine Serebrjakov partirà e Vanja ritornerà alla sua vita quotidiana, senza nessun sussulto e nessuna emozione.
La trama è semplice: al centro del racconto ci sono Zio Vanja e il professore Serebrjakov, interpretati rispettivamente da Eugenio Allegri e Alessandro Marchetti. Ad un certo punto, annoiato dalla monotonia della vita di campagna, il professore decide di vendere la sua tenuta, amministrata da Vanja, per trasferirsi in città. Quest’idea accende i rancori di Vanja, che arriva perfino a tentare l’omicidio nei confronti di Serebrjakov. Alla fine Serebrjakov partirà e Vanja ritornerà alla sua vita quotidiana, senza nessun sussulto e nessuna emozione.
In questa tragedia, tutta familiare, un solo personaggio esterno, il dottor Astrov, interpretato da Michele di Mauro, porta un minimo di suspence, seducendo, a un certo punto, Elena, la giovane moglie del professore, la quale si innamora e per un certo periodo si lascia andare tra le braccia del dottore. Sarà proprio questa debolezza di Elena, mai rivelata al marito tradito, ad accelerare i tempi e portare il professore e la sua giovane e infelice moglie fuori dalla scena definitivamente, mentre Vanja e sua figlia Sonja rimangono da soli a parlare della vita, della “…lunga fila di giorni, di lente serate…”.
Per quanto riguarda le interpretazioni, la critica si è spaccata, promuovendo o affossando la riduzione di Vacis. A nostro parere, lo Zio Vanja di Vacis è convincente, anche se evidentemente molto aderente alla personalità dell’attore, che ogni tanto tentenna su qualche battuta o se la cava troppo velocemente. Godibilissimo l’Astrov interpretato da Michele di Mauro, capace di entrare in questo quadro familiare portandovi il giusto scompenso, seducendo la moglie del professore e mettendo a nudo le miserie dei rapporti interpersonali.
Alessandro Marchetti dipinge un professore stanco e svogliato, forse esagerando in certi momenti, specialmente nel costruire il mito del professore erudito in una famiglia di illetterati. Per quanto riguarda gli altri comprimari, sicuramente una prova corale significativa e piena di buone intenzioni, anche se spesso si ha come l’impressione di una imprecisa amalgama tra i componenti. Essenziali, ma gradevoli, le scenografie di Roberto Tarasco, che contribuiscono in modo decisivo ad esaltare l’atmosfera creata dagli stati d’animo in tumulto dei personaggi, in una società dove non esistono gesti eroici, ma solo un lento procedere della quotidianità.