Si immagini un occhio non limitato da artificiali leggi prospettiche, un occhio non pregiudicato da logiche compositive, un occhio che non risponda al nome di una qualsiasi cosa ma debba conoscere ogni oggetto incontrato nella vita attraverso un’avventura percettiva. Quanti colori vi sono in un prato per un bambino che ignora il verde?
Stan Brakhage

Nato a Kansas City nel 1933, Stan Brakhage è considerato uno degli autori più importanti del cinema indipendente americano e uno dei massimi sperimentatori del cinema mondiale.
Ha realizzato nella sua carriera tra i trecento e i quattrocento film, iniziando a girare all’età di diciannove anni, influenzato, come lui stesso ha ricordato in un’intervista a Bruce Kawin, dal Neorealismo, da De Sica e Rossellini e, nello stesso tempo, da Gertrude Stein e dal surrealismo di Jean Cocteau, un poeta che egli ammirava e di cui aveva potuto vedere Le sang d’un poète (un’opera importante per la nascita dello stesso New American Cinema).
Le Sang d’un poète — film analizzato anche da Freud — fu proiettato a New York per anni insieme a Dreams That Money Can Buy, realizzato a New York nel 1949 da Hans Richter. L’insegnamento di Richter a New York, la cui importanza è generalmente sottovalutata, fu invece determinante per la formazione di diversi autori come ad esempio Mekas e Anger. È da quell’insegnamento che nasce nei filmaker newyorkesi l’esigenza di una riappropriazione del mezzo cinematografico e delle sue tecniche; fondamentale presa di coscienza che gli autori americani, a loro volta, trasmetteranno al cinema sperimentale italiano ed europeo.
Tuttavia, l’approccio dell’underground americano all’inconscio è alquanto diverso da quello del cinema surrealista classico. Il film surrealista si limitava a imitare l’orrore e il caos dell’inconscio in una sorta di voyeurismo schizofrenico, mentre il New American Cinema è aperto alla «dimensione dionisiaca» e non ritiene l’inconscio un mero caos distruttivo: alcuni autori individuano zone «superconscie», luminose e armoniche, fuori da un modello abituale di consapevolezza interiore.
Le prime produzioni di Stan Brakhage evidenziano chiaramente le peculiarità artistiche di quegli anni, ma risentono ancora dell’influenza “un po’ neorealista, un po’ onirica”, generando talvolta quello che uno dei più importanti storici del New American Cinema, P. Adams Sitney, ha chiamato «psicodramma da camera» (l’esteriorizzazione a fini catartici da parte dell’autore di allucinazioni e ossessioni). The Way to the Shadow Garden, del 1954, è già un invito per lo spettatore alle prime «metafore della visione»: il protagonista, oppresso dalle proprie frustrazioni, si cava entrambi gli occhi e procede attraverso un giardino di fiori bianchi, in una notte fiabesca.

Quattro anni dopo, con Anticipation of the Night, Brakhage realizza il suo primo capolavoro, elaborando una nuova forma espressiva: il film lirico (nel frattempo inizia a scrivere il suo libro teorico più famoso, Metafore della visione, pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 1970).
Nel film lirico l’eroe è assente: il protagonista è il filmaker dietro la macchina da presa. Le immagini corrispondono a quello che il cineasta vede, alle sue reazioni a ciò che osserva, girate in modo che la sua presenza non possa mai essere dimenticata dallo spettatore. Scrive Sitney: “Lo schermo è denso di movimento e quel movimento, sia della macchina da presa sia del montaggio, amplifica l’idea di un uomo che guarda”. E, grazie alle sovrimpressioni, prospettive e tempi diversi coesistono in uno stesso spazio. L’esperienza intensa della visione può essere così trasmessa allo spettatore. In questo senso, Brakhage fa pienamente sua la posizione dell’artista platonico: un anello nella catena che collega la musa al fruitore
Il suo cinema diventa estremamente poetico, visionario e rituale. Antinarrativo per eccellenza, nel tentativo di tradurre senza censure un’interiorità esplorata anche con pratiche magiche, sostanze psicotrope, tecniche orientali di meditazione. La rappresentazione cessa d’essere naturalistica e cerca di rendere, dall’interno, sensazioni, emozioni ed esperienze visionarie. Il tempo diventa quello del ritmo psichico e del sogno. La violenza dell’inconscio, ribollente sotto la coscienza ordinaria, viene esplorata e rivelata in un outing rabbioso o follemente gioioso.
Ripercorrendo questi concetti, gli aspetti fondamentali della ricerca estetica di Stan Brakhage ruotano intorno ad un’idea fenomenologica: quella della visione. E per visione s’intende la «fenomenologia trascendentale» di Husserl, che assegna primaria rilevanza, in ambito gnoseologico, all’esperienza intuitiva, la quale guarda ai fenomeni, che si presentano a noi indissolubilmente associati al nostro punto di vista, come punti di partenza e prove per estrarre da esso le caratteristiche essenziali delle esperienze e l’essenza di ciò che sperimentiamo.
La visione, quindi. Ma come può essere impressa sulla pellicola? Come può influenzare lo sguardo? E se la visione è il punto di arrivo di un film, allora la cinepresa e il cineasta devono lasciare che la visione avvenga piuttosto che ricercarla ansiosamente? Interrogativi che richiamano alla mente una pseudo-provocazione felliniana, quanto mai attuale nella produzione sperimentale contemporanea: “L’unico vero realista è il visionario”.

Dal punto di vista tecnico, l’acuta sensibilità ai cambiamenti del fuoco, l’attività dei fosfeni sulla superficie dell’occhio chiuso, e la visione periferica permisero a Brakhage di elaborare uno stile di ripresa poetico e coinvolgente, anche mediante l’utilizzo di tecniche riscontrabili nei cosiddetti trancefilm. Per la realizzazione di alcune intuizioni espressive, le riprese venivano sottoposte ad altri interventi in fase di postproduzione: sovrimpressioni, pittura a mano, graffi all’emulsione, incorporazione di parti del negativo. Brakhage era convinto che vi fosse un livello di cognizione che precedeva il linguaggio e che definiva “pensiero visivo in movimento”.
Nelle produzioni successive ad Anticipation of the Night, decise di eliminare l’aspetto drammatico dai suoi film e, quindi, di tentare il superamento della struttura in 3 atti della sceneggiatura, che consente di individuare la posizione di ogni evento in relazione agli altri, cioè il modo in cui gli eventi si concatenano. Si tratta del paradigma hollywoodiano che divide la storia in 3 atti interdipendenti, individuando la storia come metafora della vita, quindi nascita, crescita e morte; il paradigma affonda le sue le radici nella drammaturgia dell’antico teatro greco, così come teorizzato da Aristotele nella Poetica. Secondo Aristotele, il tutto è fatto di parti, ha un principio, uno sviluppo e una conclusione. La narrazione è caratterizzata dalla centralità dell’azione, dalla descrizione dei comportamenti dei personaggi, e dalla centralità del personaggio.
In tal senso, risulta interessante analizzare questo ipotetico superamento strutturale di Brakhage mediante la lente teorica di Filberg, secondo il quale la narrazione ruota sempre attorno ad un personaggio centrale, attraverso cui passa l’immedesimazione dello spettatore, ma tale personaggio centrale ha due obiettivi: Desire, cioè un obiettivo fisico; Need, cioè un bisogno interiore, dapprima latente, perché nascosto fra le pieghe dello spirito del personaggio.
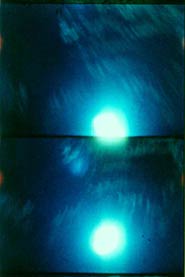 È innegabile che sotto altri punti di vista Brakhage possa essere considerato anche un filmaker strutturale, soprattutto per il ricorso a sequenze d’immagini dal ritmo regolare che sembrano avere una loro logica inafferrabile (come nel famoso film strutturale di Frampton, Zorns Lemma). In alcuni suoi film, dove ad essere protagonista è la luce, lo spettatore è invitato a inventare un principio che possa associare ogni piano al precedente. Il preteso dualismo creativo tra “lo sguardo tecnologico” (meccanico, quindi potenzialmente perfetto) e “lo sguardo umano” (biologico e dunque imperfetto) in realtà non esiste. Anche un autore come Snow ha dichiarato di voler trasmettere nei suoi film “l’analisi ma anche l’estasi” — cioè le emozioni dell’esperienza sensoriale completa — così come Brakhage è sempre stato consapevole dei limiti che la tecnologia poneva alla sua creatività.
È innegabile che sotto altri punti di vista Brakhage possa essere considerato anche un filmaker strutturale, soprattutto per il ricorso a sequenze d’immagini dal ritmo regolare che sembrano avere una loro logica inafferrabile (come nel famoso film strutturale di Frampton, Zorns Lemma). In alcuni suoi film, dove ad essere protagonista è la luce, lo spettatore è invitato a inventare un principio che possa associare ogni piano al precedente. Il preteso dualismo creativo tra “lo sguardo tecnologico” (meccanico, quindi potenzialmente perfetto) e “lo sguardo umano” (biologico e dunque imperfetto) in realtà non esiste. Anche un autore come Snow ha dichiarato di voler trasmettere nei suoi film “l’analisi ma anche l’estasi” — cioè le emozioni dell’esperienza sensoriale completa — così come Brakhage è sempre stato consapevole dei limiti che la tecnologia poneva alla sua creatività.
In un’intervista Stan Brakhage dichiarò di essere cresciuto molto in fretta come artista, da quando si era sbarazzato del dramma come fonte d’ispirazione, iniziando a sentire che tutta la storia, la vita, tutto il materiale su cui lavorare doveva cercarlo dentro di sé e che non poteva essere una forma imposta dall’esterno; aveva la sensazione che più fosse diventato soggettivo ed ‘egocentrico’, più sarebbe riuscito ad andare in profondità, a toccare quelle ansie universali comuni a tutti gli uomini. Una posizione, quest’ultima, assai diffusa tra gli autori del New American Cinema, e ancor prima da Maya Deren, che già negli anni Quaranta aveva rifiutato la «dimensione orizzontale» del dramma — il suo procedere «da emozione a emozione» — e ad approfondire il concetto di poesia nel cinema. Poesia intesa come risultato di una coraggiosa «esplorazione verticale», tale da permettere allo spettatore ricettivo d’intuire i mondi invisibili celati alla mente razionale.
 La fase lirica di Brakhage culmina con la realizzazione di Dog Star Man, il più stupefacente tra i suoi capolavori (recentemente il film è stato inserito dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel registro nazionale di film «a futura memoria»). In Dog star man non c’è trama, ma solo una scansione temporale divisa in un prologo e quattro frammenti, dove la compressione dell’immagine sboccia in un caos incomprensibile. Ogni fascio di luce si frammenta, si fonde, colorando oggetti mai visti prima, che si smaterializzano per poi ricomporsi nella memoria.
La fase lirica di Brakhage culmina con la realizzazione di Dog Star Man, il più stupefacente tra i suoi capolavori (recentemente il film è stato inserito dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel registro nazionale di film «a futura memoria»). In Dog star man non c’è trama, ma solo una scansione temporale divisa in un prologo e quattro frammenti, dove la compressione dell’immagine sboccia in un caos incomprensibile. Ogni fascio di luce si frammenta, si fonde, colorando oggetti mai visti prima, che si smaterializzano per poi ricomporsi nella memoria.
La visione del mondo è quella dei suoi film lirici ma rielaborata in termini mitici. Un cinema mitopoietico, dunque; tale da rappresentare quegli avvenimenti cosmici o inerenti alle aspirazioni e alle passioni fondamentali dell’umanità. Che in Dog Star Man riguardano la nascita della coscienza, il ciclo delle stagioni, l’antagonismo tra uomo e natura, e l’equilibrio sessuale nell’evocazione della caduta di un titano, dal nome cosmico «Uomo della Stella del Cane».
È in Dog Star Man che emerge con forza la sua concezione dell’arte: per Brakhage l’ispirazione poetica è poiesis, azione per eccellenza, diversa e superiore all’azione comune. E dunque azione magica, tale da esprimere ed evocare una (super)realtà creativa, medicatrice delle passioni dell’animo umano.
Sempre a proposito di Dog Star Man, in Metafore della Visione Brakhage scrive: “Da quando cominciai a lavorarci continuai a dire: ‘Credo sarà qualcosa come un brano Noh al rallentatore.’ Non so perché parlassi del Noh perché non me ne ero mai occupato. Non ne avevo studiato granché a parte quanto me ne era venuto per via di Ezra Pound. Come scoprii più tardi, quello era esattamente ciò che m’importava: ciò che Ezra Pound prese dal Noh, che diede forma al suo concetto di Imagismo e più tardi di Vorticismo; quando scrisse il libro su Gaudier-Brzeska. Quello fu il senso strutturale letterario che mi suggerì la forma della prima parte nella sua totalità.

Eppure dovevo liberarmi la mente. In primo luogo, dovevo fare spazio perché Jane potesse venire e sedersi con me e vedere ogni stadio del montaggio così che potessi essere aperto emotivamente a quanto lei diceva e faceva. Dovevo occupare la mia mente in un’area che lasciasse quanto restava di me libero per un’espansione di amore; ed il mio metodo consistette nel pormi il problema se potessi rafforzare la forma attraverso operazioni casuali o decisioni consce (non fu più serio di così). Mi sforzai di aderire ad una decisione conscia, non lasciando mai che un pezzo venisse usato per puro caso e non lasciando mai spazio ad una decisione che fosse più debole di un’operazione casuale. Volevo che laprima parte fosse l’opposto di Prelude quanto a ritmo. Volevo che fosse lenta, stirata, estesa alla massima tensione che il materiale potesse tollerare.”
Anche il montaggio di Dog Star Man fu assai lento e laborioso, tanto che per terminarlo Brakhage e sua moglie Jane impiegarono un anno e mezzo. “Intanto ogni volta che la mente interferiva la tenevo a freno con la gabbia di John Cage. Ricorsi con successo a Cage durante la composizione di questo film nel senso che ogni momento potevo tendere la mano ed afferrare la sua gabbia e salvaguardare la possibilità di operazioni casuali da ogni prepotere intellettuale del cervello”. Tuttavia, i «silenzi» del film non hanno niente a che fare con il Silenzio di Cage. Pur apprezzando la musica di Cage, Brakhage ama in modo particolare alcuni episodi musicali di Morton Feldman: un suono che accade e poi silenzio, quel tanto che basta per sostenere «quel» suono prima che ne giunga un altro.
Dalla seconda partedi Dog Star Man in avanti, Brakhage tornò al metodo di montare più rotoli di film, di lunghezza uguale all’intera parte, da sovrimporsi poi integralmente in fase di stampa. Per la seconda parte (che presenta immagini di rigenerazione) i rotoli furono due; tre per la terza parte (il cui tema è di carattere sessuale), e quattro per la quarta parte (che si conclude con una sequenza sincopata in cui il protagonista spacca con un’accetta il tronco dell’albero bianco).

Passando a The Art of Vision, Brakhage unì i rulli di ogni parte in tutte le combinazioni matematicamente possibili, con un procedimento che egli riferisce all’ultima opera di Bach (paragoni che sostanzialmente demeritano il lavoro di entrambi). Di fatto, il processo di scomposizione e di ripetizione porta ad un’indubbia estensione poetica il materiale di Dog Star Man. Ne viene messa in evidenza tutta la vitalità propria di queste immagini, di cui seguiamo la lenta evoluzione negli accostamenti sempre diversi ma simili, che generano un’intensa e parallela variazione dei significati.
Stan Brakhage è morto nel marzo 2003 a Victoria, in Canada, la città dove si era da poco trasferito con la sua seconda moglie, Marilyn, dopo essersi ritirato dall’insegnamento cinematografico all’Università del Colorado. Sul letto di morte, nonostante i tremendi dolori causati da un cancro in fase terminale, ha continuato a creare fino all’ultimo, girando The Chinese Series.
Il suo maggiore esegeta, P. Adams Sitney, (autore di Visionary Film, testo importantissimo per la comprensione del New American Cinema), alla sua morte lo ha definito “il più grande vitalista del cinema”, quello che ha saputo conciliare “nel modo più vitale” il cinema — cioè l’arte — con la vita.


Trackback/Pingback