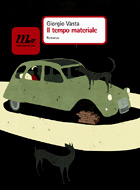
Titolo: Il tempo materiale
Autore: Giorgio Vasta
Anno di pubblicazione: 2008
Editore: Minimum Fax, Roma
Collana: Nichel
Pagine: 350
Prezzo: 13,00 Euro
ISBN: 9788875211882
Ce n’è sempre di più, troppa, la nuova ironia italiana che brilla su tutti i musi, in tutte le frasi, che ogni giorno lotta contro l’ideologia, le divora la testa, e in pochi anni dell’ideologia non resterà più niente, l’ironia sarà la nostra unica risorsa e la nostra sconfitta
Giorgio Vasta
Il sequestro di Moro non è un’azione andata male, un piccolo o grande errore di valutazione, è la fine di un modo di pensare la guerriglia, la fine della teoria sulla propaganda armata. Non otterremo più con un’azione di guerriglia un obiettivo sulla scena politica, perché la scena politica si è ridotta a pura difesa dello stato
Mario Moretti [1]
 Leggere Il tempo materiale di Giorgio Vasta equivale a rileggere la storia degli anni Settanta in Italia, di ciò che hanno rappresentato le Brigate Rosse[2], della loro evoluzione a movimento di guerriglia. Significa un po’ rievocare lontani ricordi, fantasmi che si aggirano tra le coscienze di chi quegli anni li ha vissuti e di chi, come me, ne ha visto solo il lento strascico di fine secolo, con l’affermazione delle Nuove Br e le loro azioni emulative.
Leggere Il tempo materiale di Giorgio Vasta equivale a rileggere la storia degli anni Settanta in Italia, di ciò che hanno rappresentato le Brigate Rosse[2], della loro evoluzione a movimento di guerriglia. Significa un po’ rievocare lontani ricordi, fantasmi che si aggirano tra le coscienze di chi quegli anni li ha vissuti e di chi, come me, ne ha visto solo il lento strascico di fine secolo, con l’affermazione delle Nuove Br e le loro azioni emulative.
Proprio di emulazione e solitudine parla questo libro. Di un gruppo di ragazzini, all’apparenza normali, che vivono il 1978 come un’escalation di violenza durata nella realtà un decennio; in pochi mesi, i tre giovani protagonisti si trasformano da studenti in pseudo-brigatisti. I loro nomi di battaglia sono Volo, Raggio e Nimbo. La metamorfosi avviene repentinamente, senza che nessuno sospetti nulla. Definiscono addirittura un codice univoco di linguaggio, l’alfamuto, formato solamente da ventuno parole di senso compiuto e di impossibile comprensione ai non iniziati. Inizialmente decidono di escludere la parola “paura”, perché secondo la mente del gruppo, Scarmiglia-Volo, è una parola fuorviante e pericolosa. Per essere veri guerriglieri, devono uscire dalla logica individualista dominante e ragionare come ragiona uno sciame di api: alle operaie può essere chiesto il sacrificio della vita se il bene primario, la regina, si trova in pericolo. Così i brigatisti. Devono mettere a rischio tutto, darsi completamente, anima e corpo, alla “causa”.
“Ogni individuo è come una cellula: necessario ma senza un nome. Per certi versi ancora individuale, ma non individuabile […] Le api passano il tempo a volare componendo codici e decifrandoli. Noi le osserviamo e non capiamo niente, vediamo solo dei puntini gialli che si agitano; ma se riuscissimo a leggere le linee invisibili che disegnano sapremmo che cosa si stanno dicendo”.
Già dalle prime pagine del romanzo, dalle parole di Vasta, appaiono evidenti la perdita di valori, lo smarrimento e il vuoto lasciato dalla deriva del movimento rivoluzionario del ’68, che non è stato in grado di compiersi fino in fondo.
Nonostante una chiara volontà di mutamento, la società italiana sembra dunque ancora incapace, se non attraverso il seme dell’odio e della violenza, di uscire da questa spirale di terrore che ha radici lontane, nell’insofferenza delle masse e del proletariato. Il finale sembra già scritto, perché è il finale che la storia ci insegna: c’è la chiara consapevolezza di chi sa che l’utopia rivoluzionaria del ’78 sarà sconfitta, distrutta dal suo interno, da un processo irreversibile che corrode le sue fondamenta, prive di umanità; non c’è perdono, non c’è clemenza nelle azioni delle Br. La società è malata, ma il male non si può sconfiggere infliggendone dell’altro a persone innocenti, ree dell’unico peccato di appartenere a quella stessa società.
Quel che Vasta ci mette di fronte è un mondo decadente, visto con gli occhi di un ragazzino che si confronta con la morte, con la brutalità della violenza e la sua spettacolarizzazione attuata dalle Br. È un mondo in evoluzione, che fa paura e che deve essere domato, secondo l’antico principio mors tua vita mea. Un’istantanea del nostro paese nel suo ultimo frangente di lucidità ed innocenza.
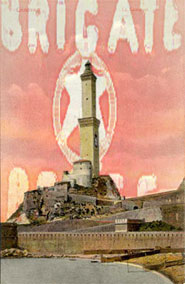 “Io di brigatismo non so niente. Quello che leggo. Qualcosa. Niente. So che se ne parla, che ha a che fare con la morte […] In questi giorni vedo in televisione le immagini di Via Fani e ho un prurito che mi mangia la pelle e una cosa nella pancia che mulina e raschia, un presentimento a gorghi che mi si apre sul petto e sul palmo delle mani”.
“Io di brigatismo non so niente. Quello che leggo. Qualcosa. Niente. So che se ne parla, che ha a che fare con la morte […] In questi giorni vedo in televisione le immagini di Via Fani e ho un prurito che mi mangia la pelle e una cosa nella pancia che mulina e raschia, un presentimento a gorghi che mi si apre sul petto e sul palmo delle mani”.
Nimbo è un ragazzino strano, riflessivo ed introverso, che vive in una Palermo surreale e a tratti inquietanti. Cerca un senso nelle parole che vada al di là del loro significato formale. Parla con un linguaggio da adulto, lui appena undicenne. La sua esperienza da terrorista va ben oltre quella compiuta dai brigatisti: la sua è una ricerca spasmodica della morte, della distruzione fine a se stessa. Non ha nessun tipo di rivendicazione da fare, è semplicemente alla ricerca dell’essenza della vita e dell’essere. L’infanzia è vista come un corpo corroso da un cancro invisibile, insospettato agli adulti, che rende i ragazzi un branco di lupi affamati di sangue.
“[…] La conseguenza del nostro modo di esprimerci è che i nostri compagni di classe non ci riconoscono. Per loro siamo delle anomalie. Degli idioti […] Le Brigate rosse, dice Scarmiglia. Loro parlano come noi. I loro comunicati sono complessi, le frasi lunghe e potenti. Sono gli unici in Italia a scrivere così.”
Si respira, in ogni singola pagina del romanzo, un senso di solitudine interiore e di abbandono; l’essere coscienti di sentirsi incompresi è amplificato dagli eventi storici e politici che si stanno verificando in quei mesi. Ma si sente anche, molto forte, la rassegnazione, un senso di beata impotenza di fronte al succedersi incalzante dei fatti, che in un crescendo di crudeltà trasformano la vita dei tre undicenni in un delirio cieco e insensato.
Scarmiglia emerge dapprima lentamente e poi con sempre maggior prepotenza come figura dominante del gruppo; è lui la mente della cellula neo-rivoluzionaria di ispirazione brigatista; lui che dirige, che detta gli ordini e impartisce le istruzioni che gli altri due devono seguire rigorosamente; lui è l’artefice dei pedinamenti e dell’organizzazione del rapimento di Morana; lui è quello che organizza la sua prigionia e pianifica torture e omicidio. E sempre lui progetta il piano per il sequestro di Winbow, la ragazzina creola della quale il protagonista è innamorato.
Il linguaggio, si diceva sopra, è spunto di riflessione: un undicenne che vede e si spiega con gli occhi di un adulto è cosa assai strana ed inusuale; la parola in se stessa è vista come fonte di dolore: dover parlare, spiegare e spiegarsi agli altri, la necessità di motivare ogni azione, l’impossibilità di agire senza uno scopo perché non ci possono essere movimenti irrazionali, perché il diverso deve venire isolato; tutto ciò porta ad una visione pessimistica della vita e della realtà, esasperata dalla crisi d’identità di una società in rapida evoluzione ma con conflitti sociali non del tutto chiariti. In un mondo così, viene da pensare, è meglio dunque tacere, smettere di dare spiegazioni, e fingere, fingere che tutto vada bene e sia normale, anche quando nulla lo è.
“Il linguaggio è un’esistenza immensa […] ma a un certo punto cominci a desiderarne un’altra di esistenza. Più limitata, ma più comprensibile[…] Un’esistenza nella quale sia semplice distinguere tra i buoni e i cattivi? […] Io non ne potevo più del linguaggio. E la militanza è la soluzione. […] Così rinunci al piacere Nimbo. Così rinuncio al dolore.”
Il rapimento di Morana è visto come gesto estremo ma necessario. Il dolore ed il male sono necessari. La violenza è necessaria. Una prova di forza con se stessi che non lascia spazio ad alternative: in un mondo in guerra, o combatti o soccombi. Le pressioni sul corpo di Morana, in ogni sua parte. Ogni centimetro della sua pelle deve sopportare il peso del mondo, tutte le sue colpe. Egli è come un Cristo che si sacrifica per espiare tutto il male del mondo; nelle pagine di Vasta appare molto remissivo, non oppone resistenza alcuna al rapimento e poi alle torture, non cerca di scappare, o di liberarsi. Si presta passivamente, con rassegnazione, a questo suo ruolo di capro espiatorio. Lascia che il suo fisico venga martoriato, non può che subire in silenzio i soprusi dei suoi aguzzini.
La cantina in cui è segregato non assomiglia alla prigione di Moro, ma assume l’aspetto di una gabbia: il prigioniero non può muoversi od alzarsi, non ha un bagno, un catino per lavarsi, non viene liberato nemmeno per mangiare. I suoi carcerieri gli infilano in bocca pezzi di pane raffermo e lo strofinano con un panno bagnato per pulirlo; egli è completamente impedito in ogni più piccolo movimento. La morte avviene in modo lento, non è un’esecuzione, ma un supplizio lento, inesorabile. Un gioco al massacro che dura alcune ore, finché il l’artefice di tutto, il compagno Volo non si stanca e decide che il gioco debba finire.

“La liturgia della distruzione alla quale ho assistito non è fatta di calci e pugni ma di pressione e densità. È una colonna nera che spinge in basso, piega e comprime. La violenza morbida. La violenza gentile. La concentrazione come dolore. Il corpo di Morana, la tenerezza del suo dolore incosciente. La nostra capacità di compiere il male”.
Il tempo materiale, in conclusione, è un libro che colpisce per la ricchezza del suo linguaggio, per la complessità della scrittura, per il fascino che suscita la narrazione di un undicenne che vive con gli occhi di un adulto le vicende socio-politiche di un’Italia in lenta disgregazione, sotto i colpi inferti da un movimento rivoluzionario che non lascia spazio alla trattativa, al compromesso. È un libro che parla, in fondo, di tutti noi, di una storia sofferta e ancora irrisolta che troppo spesso si vuole dimenticare.

