Continua da Hoodoo e voodoo
Immagini del sud
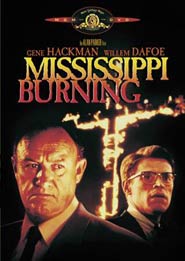 “ In che stato bisogna mettere l’orologio indietro di un secolo? Nel Mississippi”. Con queste parole l’agente dell’Fbi Anderson presenta lo stato americano al collega Ward mentre i due, in macchina, si stanno dirigendo a Jessub. Come se non bastassero più tardi le immagini di quei due lavandini posti uno accanto all’altro con sopra le insegne ‘black e white’. La pellicola prosegue: “Se non sei meglio di un negro di chi sei meglio figliolo?”, è la frase che un giorno il padre rivolse ad Anderson. Ma perché abbozzo questo tipo di analisi su Mississippi Burning? Per ricordare che nel 1964, il baseball, nel Mississippi e non solo, era probabilmente “l’unica occasione in cui un negro poteva agitare un bastone contro un bianco senza rischiare la pelle”.
“ In che stato bisogna mettere l’orologio indietro di un secolo? Nel Mississippi”. Con queste parole l’agente dell’Fbi Anderson presenta lo stato americano al collega Ward mentre i due, in macchina, si stanno dirigendo a Jessub. Come se non bastassero più tardi le immagini di quei due lavandini posti uno accanto all’altro con sopra le insegne ‘black e white’. La pellicola prosegue: “Se non sei meglio di un negro di chi sei meglio figliolo?”, è la frase che un giorno il padre rivolse ad Anderson. Ma perché abbozzo questo tipo di analisi su Mississippi Burning? Per ricordare che nel 1964, il baseball, nel Mississippi e non solo, era probabilmente “l’unica occasione in cui un negro poteva agitare un bastone contro un bianco senza rischiare la pelle”.
Frammento uno. Mississippi, 1964. A Jessub una piccola cittadina a dieci miglia da Memphis, tre attivisti per i diritti sociali dei neri vengono brutalmente uccisi. Gli agenti dell’Fbi Anderson e Ward decidono di investigare sulla loro scomparsa. Nel corso delle indagini, tuttavia, devono fare i conti con la polizia locale, responsabile dell’accaduto e legata segretamente al Ku Klux Klan. Malgrado gli sforzi per ottenere giustizia, i due assistono a un crescendo di odio e violenza nei confronti della comunità di colore del posto.
Alan Parker, un anno dopo Angel Heart (1987), ritorna nel Sud degli Stati Uniti per rievocare, stavolta, una drammatica storia che parla di libertà e integrazione. Ispirato a fatti realmente accaduti, modificati in alcune dinamiche ma non nella loro decisiva sostanza, Mississippi Burning denuncia, con grande intensità, l’insofferenza culturale e l’emarginazione sociale che pesavano sulla gente di colore — ma non solo — nel 1964 nello stato del Mississippi. In nome di una democrazia anglosassone e di un certo “standard” americano (o meglio: in nome di una supremazia e di un integralismo estremi), la minoranza nera non poteva votare, e incarnava diffusamente un problema da risolvere in qualsiasi modo.
Merito del film è quello di provare a fornire allo spettatore una visione ampia e obbiettiva sui motivi dell’odio, facendo parlare le persone, oltre che le immagini. Nonostante le fiamme, destinate ad aumentare fin dall’incipit, divampino furiosamente. Come nella scena dell’impiccagione, quando, un uomo di colore viene appeso a un albero mentre la sua casa brucia alle spalle. E una voce extradiegetica intona una preghiera triste e piena di rabbia.
Frammento due. Liberi di fare le proprie cose quando si vuole (c’è da esserne fieri, come dice Peter Fonda nei panni di Capitan America); di avere una fattoria, molti figli e una moglie cattolica. Oppure di fumare marijuana, la notte, attorno a un fuoco, e appena svegli, per affrontare la giornata da una prospettiva diversa. Ma anche liberi di sopravvivere scostati dal resto del mondo, di gettare semi su una terra arida, di portare in faccia le proprie cicatrici. Anche di questo ci parla Easy Rider (1969). Tuttavia, il sogno di libertà per Billy e Wyatt si infrange tragicamente a Sud.
Road movie sceneggiato dai due interpreti principali, Peter Fonda e Dennis Hopper, diretto da quest’ultimo, Easy Rider narra di un viaggio che ha per meta il Carnevale di New Orleans, la festa della città sul grande Delta. Un racconto che denuncia lo squallore e la paura (la quale si manifesta rozzamente nei confronti di qualsiasi minima e pericolosa traccia di diversità) della provincia bianca e conservatrice del Sud alla fine degli anni Sessanta. Una pellicola che offre una visione unica e irrepetibile nell’immaginario cinematografico, dove la mano dell’autore, (con quegli scatti di montaggio che anticipano spesso le inquadrature successive) si rivela in tutta la sua destabilizzante natura. E quando il desiderio di libertà si cristallizza in fuga e assume sembianze allucinatorie e lesionanti, come nella sequenza dell’acido, le voci e le immagini si fondono, delirano, trascinano chi guarda lentamente alla deriva.
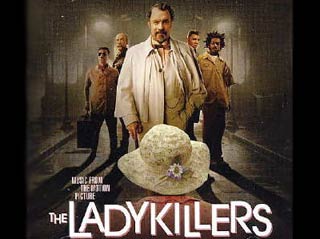
Frammento tre. Dal bianco e nero si passa lentamente al colore. Si entra così nel racconto di Fratello dove sei? (2000), mentre si osservano dei prigionieri lavorare e cantare sorvegliati a vista. Poco dopo, i protagonisti della vicenda, tre galeotti in fuga, arrivano nei pressi di un binario. In questo luogo incomincia l’avventura di Everett e dei suoi compagni.
La favola dei Coen è una sfacciata, ironica e spassosa versione dell’Odissea di Omero, ma che ha nella letteratura del Sud degli Stati Uniti un importante referente. In particolare nei due classici scritti da Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer (1876) e Le avventure di Huckleberry Finn (1884). C’è tanto stato del Mississippi in questo film: la politica, il tema del razzismo, questioni etiche e sociali, la religione e la musica. Una realtà ridisegnata mediante una narrazione che fa della sorpresa, del continuo coinvolgimento emotivo e sensoriale dello spettatore, uno dei suoi punti di forza. Il succedersi delle situazioni è travolgente, sempre diverso, e si ride spesso. Ma abbassando gli occhi sotto la superficie è facile provare anche rabbia per Baby Face Nelson, catturato e condannato alla pena di morte; e disprezzo, per gli incappucciati del Ku Klux Klan; infine indignazione, per le idee contrarie all’integrazione del candidato governatore. La satira dei Coen, infatti, una volta individuata, appare netta e lacerante.
In questo senso è il fiume a rammentarci, con le sue acque sparse per i boschi del Sud, l’altra faccia della favola. Lo fa travestendosi di spiritualità e d’incanto. Come quelle ninfe bagnate che lavano i panni e fanno riecheggiare la loro splendida cantilena nelle menti dei tre protagonisti. In verità, si riveleranno, ingannevoli “meretrici di Babilonia”.
Frammento quattro. I fratelli Coen confermano il loro spirito e la loro creatività cinematografica pochi anni più tardi in The Ladykillers (2004). Anche in questo film, come in Fratello dove sei?, è la musica a diventare molte volte protagonista e a fare da supporto a immagini perfette. Ma se la pellicola ispirata all’Odissea ritraeva e si soffermava su varie realtà dello stato del Mississippi, qui, siamo ancora più a sud, in una cittadina sul Delta, in Louisiana. Si spiega con questo motivo la presenza molto forte di una rappresentazione della cultura di colore (dall’anziana donna padrona della casa, ai costanti canti gospel della chiesa battista), che in Fratello dove sei? era quasi del tutto assente.
Il fiume assume un ruolo fondamentale. È sede del casinò galleggiante, illegale sulla terra ferma e consentito sulle sue acque. Soprattutto è questo che risolve continuamente le situazioni più delicate, portandosele via, silenzioso, attraverso quella barca che trasporta la spazzatura sulla quale, dal ponte, i protagonisti gettano i loro scomodi problemi, terra in eccesso o cadaveri che siano. Geniale poi, la sequenza finale: il corvo si posa, esattamente come all’inizio (un cattivo presagio presente già nell’incipit, quindi), sulla statua gotica che si spezza e frana in testa al povero Tom Hanks, unico superstite della banda di rapinatori. Il suo corpo rimane aggrappato al ponte con gli abiti appigliati prima di cadere nel vuoto. E di nuovo, come una mistica presenza, compare la barca tra la nebbia. Scorrendo sulle acque, stavolta buie, del Mississippi.

Continua su Lungo il fiume



