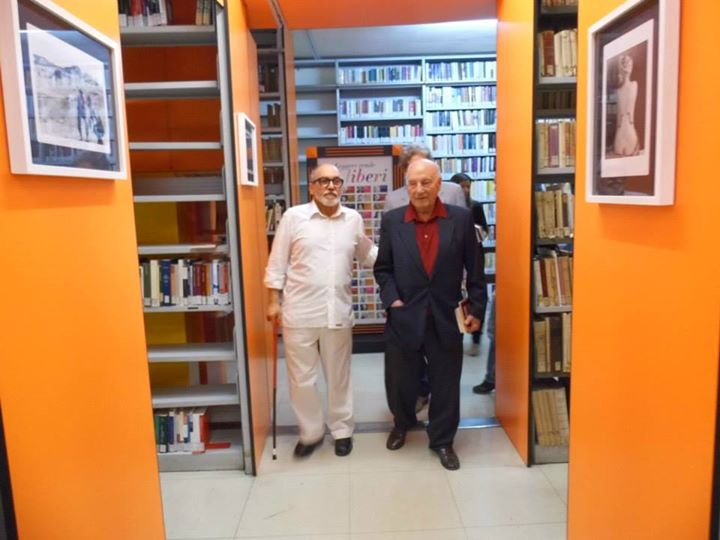Titolo: La misura del mondo
Autore: Daniel Kehlmann
Traduzione: Paola Olivieri
Titolo originale: Die vermessung der welt
Anno di pubblicazione: 2005
Prima ed. italiana: maggio 2006
Editore: Feltrinelli Editore, Milano
Collana: Universale Economica
Pagine: 254
Prezzo: 8,00 Euro
ISBN: 9788807720031
Ma mentre Humboldt superava la periferia di Berlino e si immaginava Gauss seduto al suo telescopio a osservare i corpi celesti, le cui orbite sapeva riassumere in formule semplici, per la prima volta non avrebbe più saputo dire chi dei due aveva girato mezzo mondo
e chi era sempre rimasto a casa.
La misura del mondo è ormai un caso letterario. Tradotto in venticinque lingue, vanta più di un milione di copie vendute. Si tratta di un’opera imprevedibile e difficilmente catalogabile, poiché al suo interno sviluppa temi scientifici, filosofici o d’avventura, inseriti in un determinato milieu storico — tra Illuminismo e Restaurazione — con i suoi fermenti sociali.
La nota principale che permea il romanzo è l’umorismo. Kehlmann, dopo aver tessuto una rete di avvenimenti storici più o meno autentici, li reinterpreta, andando a creare situazioni inverosimili e assurde. Queste stesse situazioni permettono lo svelamento dei caratteri dei due personaggi principali, i quali risulteranno buffi e surreali, ridicoli e strampalati. Il tutto ornato da una scrittura schietta e veloce che, grazie all’abbondante uso del congiuntivo, permette un flusso scorrevole di dialoghi indiretti.
I protagonisti dell’opera sono due notevoli figure storiche, che pertanto portano con sé una grande eredità. Alexander von Humboldt, esploratore, geografo, scienziato, riconosciuto come il padre della geografia moderna; e Carl Friederich Gauss, matematico, fisico, astronomo, definito il “principe della matematica”. All’interno del libro si incontreranno altre personalità importanti come Immanuel Kant, Wolfgang Goethe, Wilhelm von Humboldt, Napoleone Bonaparte e molti altri, anch’essi vittime della deformazione ilare messe in atto dall’autore.

Il racconto inizia con l’incontro dei due in occasione di un congresso di scienziati tedeschi a Berlino, nel 1828. Ci si rende subito conto della differenza di temperamento che c’è tra il matematico e l’esploratore, il primo scontroso e ostile agli spostamenti, l’altro cortese e gentile.
Facendo un salto nel passato, l’opera procede raccontando in maniera alternata, e per capitoli, la crescita e la vita dei protagonisti, permettendo un parallelismo e un confronto tra gli scienziati. Alexander proviene dall’ambiente della nobiltà tedesca. Improvvisamente gli muore il padre e, per chiedere consiglio sull’educazione sua e di suo fratello maggiore Wilhelm, la madre si rivolge a Goethe in persona. Dopo una risposta profondamente enigmatica e sconclusionata da parte del sommo letterato, Alexander viene indirizzato verso studi scientifici, Wilhelm verso studi classici. La rivalità che si instaurerà tra i due sarà la forza che li spingerà a volersi sempre superare tra loro.
Ma è la morte della madre l’evento più importante per Alexander, questo episodio gli restituisce la libertà necessaria per poter intraprendere i suoi viaggi. Munito di due barometri, un ipsometro, un teodolite, un sestante a specchio con un orizzonte artificiale, un sestante tascabile pieghevole, un ago declinatorio, un igrometro a capello, un eudiometro, una bottiglia di Leida, un cianometro e di due orologi — come un novello Don Chisciotte, accompagnato dal fedele Sancho Panza – Aimé Bonpland, il botanico francese che, stufo della vita in provincia, decide di seguire l’amico all’avventura — gira per il Nuovo Mondo. Saggia su di sé gli effetti del curaro, si inoltra nell’Amazzonia, naviga sull’Orinoco, si arrampica su vulcani (mettendo definitivamente fine alla teoria del nettunismo) e scende nelle grotte più profonde, misurando, studiando, catalogando, archiviando qualsiasi cosa al suo passaggio. Accarezzando una dracena dimostra tutto l’amore che prova per la natura, che è di molto superiore a quello che nutre per le donne.
Gauss, al contrario del suo compagno, provieneda una famiglia umile, ma grazie al suo genio, e al sua talento per la matematica, riesce a sottrarsi a quella condizione. Con l’aiuto del suo maestro Bűttner, che lo consiglia al Duca di Brunswick, Gauss può frequentare l’università, e a soli ventiquattro anni scrivere l’opera che lo rende celebre, le Disquisitiones Arithmeticae. La passione per il sesso femminile, e la sua libertà e velocità di pensiero sono i tratti che lo distinguono.
In seguito, nel corso della sua vita nella piccola Gottinga, Carl Friederich Gauss insegnerà all’università, farà l’agrimensore, elaborerà un nuovo metodo per la definizione delle orbite dei corpi celesti, studierà la curvatura dello spazio, e molto altro ancora.
Particolarmente interessante è l’incontro, mai avvenuto nella realtà, con Kant. Grazie ad esso si può intuire quella che è stata la situazione vissuta dall’estroso matematico: Aveva infatti l’impressione che lo spazio euclideo non fosse, come il professore affermava nella Critica della ragion pura, il presupposto della forma della nostra stessa intuizione e dunque il presupposto di qualsiasi possibile esperienza, ma piuttosto una finzione, un bel sogno. La risposta dell’unico uomo che poteva capirlo fu: Salsicce. Raccontandoci quest’immaginaria disavventura di Gauss, Kehlmann esprime l’impossibilità di un uomo di comunicare con la propria epoca, non ancora pronta a capirlo.
L’antitesi tra ordine e caos fa sbocciare l’humor nel romanzo, tanto divertente quanto melanconico. Da una parte, l’inarrestabile volontà di ordinare e capire quel caos del mondo, dall’altra, la consapevolezza dell’impossibilità di comprendere e l’incapacità propria di ogni scienza ad essere esaustiva.
Dopo un inizio che poneva i due luminari quasi in antinomia, l’autore ci mostra — grazie anche alla struttura del romanzo che permette di seguire le due vite in parallelo — che non sono dissimili, che il sentimento che li spinge è lo stesso, quel profondo e primitivo bisogno di consapevolezza. Arriveranno a congiungersi per via telepatica, in un solo spirito, quando si penseranno reciprocamente eseguire lo stesso esperimento in luoghi lontani.
Curiosamente, l’opera si conclude con la partenza del figlio di Gauss, Eugen, verso l’America, una terra ancora ignota e da determinare. L’evento rappresenta simbolicamente la prosecuzione dell’attività di esplorazione iniziata dai due eroi.
 Si può assumere a metafora dell’opera l’elaborazione grafica dal disegno di Tullio Pericoli, La malinconia dell’architetto, 1985, che fa da copertina all’edizione italiana Feltrinelli. Con un tratto fiabesco e leggero, che può ricordare la scrittura di Kelhmann, ci mostra un pianeta diviso in due, ogni emisfero un prisma regolare, misurabile e misurato. Prendendo a prestito i due emisferi per assegnarli l’uno a Gauss, il cielo e le stelle, e l’altro a von Humboldt, la terra e i mari, otterremo come risultato il mondo conosciuto, il quale ha dato i natali a quello contemporaneo. L’uomo trasognante, armato di compasso, è lo spirito primigenio di conoscenza presente in entrambi gli scienziati.
Si può assumere a metafora dell’opera l’elaborazione grafica dal disegno di Tullio Pericoli, La malinconia dell’architetto, 1985, che fa da copertina all’edizione italiana Feltrinelli. Con un tratto fiabesco e leggero, che può ricordare la scrittura di Kelhmann, ci mostra un pianeta diviso in due, ogni emisfero un prisma regolare, misurabile e misurato. Prendendo a prestito i due emisferi per assegnarli l’uno a Gauss, il cielo e le stelle, e l’altro a von Humboldt, la terra e i mari, otterremo come risultato il mondo conosciuto, il quale ha dato i natali a quello contemporaneo. L’uomo trasognante, armato di compasso, è lo spirito primigenio di conoscenza presente in entrambi gli scienziati.
Tra le due parti, tra cielo e terra, difficile e minimo è il punto di contatto che possa assicurare l’equilibrio e il dialogo. Attorno il nulla o quasi, il caos.