Antropologia e cinema hanno, nella riflessione teorica di entrambi gli ambiti, almeno un punto essenziale in comune: lo statuto dello sguardo.

Fondamentale per ogni riflessione sull’immagine, la questione del punto di vista, che si parli di semi-soggettiva o del ruolo dell’osservatore nel momento in cui incontra l’altro, può essere l’anello di giunzione tra due discipline che si sono viste evolvere ed integrarsi in uno scambio reciproco. Il cinema etnografico diventa allora un campo di studi privilegiato dove, riferendoci ad un genere incentrato sul contenuto, paradossalmente, è proprio nell’estetica cinematografica che nascono le riflessioni più interessanti sul ruolo della cultura nella creazione di molteplici visioni del mondo, sulla sua messa in prospettiva.
Dall’uso che Jean Rouch (vedi scheda correlata a fondo articolo, ndr) fece della macchina da presa Aton a 16mm, inventando per pure questioni contingenti il cinéma verité negli anni ’60, l’etnografia s’interroga sullo stato attuale della ricerca scientifica attraverso uno strumento, il cinema, che è per definizione il regno della finzione e della menzogna.
E il rapporto tra i due ambiti ha un particolare fascino e interesse, soprattutto considerando che, nel 2008, la maggior parte dei popoli studiati ha preso oramai coscienza del mezzo cinema, usandolo per descrivere la propria società e la nostra, spesso con straordinarie doti e una sensibilità nuova rispetto al cineasta occidentale. Il cinema etnografico iraniano o cinese assume sempre maggiore importanza nei dibattiti sull’antropologia visiva. L’oggetto di studi è divenuto dunque esso stesso produttore di rappresentazioni, di sé e di altre società, rendendo sempre più labile e interdipendente la frontiera tra l’osservatore e l’osservato.
Da 27 anni, nel Palais de Chaillot, di fronte alla Tour Eiffel, il Comité du Film Ethnographique — fondato nel 1952 da Jean Rouch, Luc de Heusch e André Leroi-Gourhan — offre al pubblico uno straordinario festival di cinema etnografico, chiamato da quest’anno Festival International Jean Rouch (XXVII Bilan). I corridoi maestosi e polverosi di un museo etnografico — semisvuotato per lasciar spazio al contestato e futuristico Musée du Quai Branly, giusto al di là della Senna, ma sempre affollato di gente, come ogni museo parigino — ospitano dunque ogni anno una manifestazione che invita antropologi e cineasti da tutto il mondo per fare in qualche modo un bilancio del panorama etnografico attuale, così come lo si può “vedere dal cinema”.
Quest’anno, la manifestazione, tenutasi dal 15 al 23 marzo, ha visto vincitore l’italiano Vjesh (“Canto”, nda), documentario dell’antropologa Roberta Schillaci sui canti delle minoranze albanesi in Basilicata. Ne abbiamo parlato con un personaggio eclettico, cineasta anch’egli, che vive tra la Francia e il Brasile: Marc-Henri Piault, professore di antropologia visiva all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, e presidente del Comité du Film Ethnographique.
Matteo Treleani (MT): Oggi che il “Bilan du Film Ethnographique” ha cambiato nome in “Festival International Jean Rouch”, c’è forse, nel cinema etnografico, un maggiore interesse per la forma rispetto al contenuto?
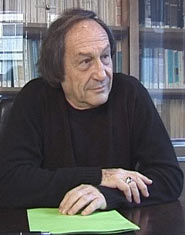 Marc-Henri Piault (MHP): Indubbiamente uno dei limiti del documentario etnografico è stato per molto tempo l’incapacità e il disinteresse a usare il mezzo cinema. Le opere prodotte e girate da ricercatori hanno privilegiato a lungo il contenuto, ciò che si doveva mostrare, in un certo senso l’oggetto della scoperta etnografica — la popolazione o il rito studiato — senza occuparsi della messa in prospettiva cinematografica. Credo che questa tendenza si sia allentata nel tempo. Malgrado le eventuali intenzioni autoriali, grazie al digitale e a una coscienza quasi implicita della cultura dell’immagine nell’epoca contemporanea, le opere etnografiche degli ultimi anni hanno un evidente accento sulla messa in forma, importante almeno quanto il contenuto. Dall’idea di semplice “documento visivo”, l’etnografia si è evoluta sino ad accettare l’interezza dell’opera etnografica nella sua complessità. Il cinema è un linguaggio che mette in relazione una forma e un contenuto, ma questi sono intrinsecamente legati e interdipendenti, esistono l’uno in funzione dell’altra e non si può concepire un cinema che privilegi un solo aspetto della stessa medaglia. La messa in prospettiva, il punto di vista, una volta dato e considerato che non si può parlare di oggettività nel cinema, d’altronde, è il principale dei temi trattati dall’antropologia fin dalla sua nascita.
Marc-Henri Piault (MHP): Indubbiamente uno dei limiti del documentario etnografico è stato per molto tempo l’incapacità e il disinteresse a usare il mezzo cinema. Le opere prodotte e girate da ricercatori hanno privilegiato a lungo il contenuto, ciò che si doveva mostrare, in un certo senso l’oggetto della scoperta etnografica — la popolazione o il rito studiato — senza occuparsi della messa in prospettiva cinematografica. Credo che questa tendenza si sia allentata nel tempo. Malgrado le eventuali intenzioni autoriali, grazie al digitale e a una coscienza quasi implicita della cultura dell’immagine nell’epoca contemporanea, le opere etnografiche degli ultimi anni hanno un evidente accento sulla messa in forma, importante almeno quanto il contenuto. Dall’idea di semplice “documento visivo”, l’etnografia si è evoluta sino ad accettare l’interezza dell’opera etnografica nella sua complessità. Il cinema è un linguaggio che mette in relazione una forma e un contenuto, ma questi sono intrinsecamente legati e interdipendenti, esistono l’uno in funzione dell’altra e non si può concepire un cinema che privilegi un solo aspetto della stessa medaglia. La messa in prospettiva, il punto di vista, una volta dato e considerato che non si può parlare di oggettività nel cinema, d’altronde, è il principale dei temi trattati dall’antropologia fin dalla sua nascita.
MT: Il fatto che il cinema etnografico sia generalmente realizzato da ricercatori e non da cineasti di formazione, non finisce per privilegiare una forma di cinema/documento al servizio dell’antropologia, come fosse un semplice supporto al testo?
MHP: Credo che fosse vero fino a pochi anni fa. Oramai si è creata una coscienza del mezzo cinema nei ricercatori. Non significa che lo sappiano usare bene, ma c’è la consapevolezza del ruolo dello strumento, il che nell’antropologia come nel cinema è essenziale. L’uso del linguaggio e l’importanza del linguaggio sono da tempo riconosciute nella ricerca etnografica. Tale consapevolezza si accompagna evidentemente, nel momento in cui è il cinema il mezzo utilizzato dall’antropologia, a una ricerca nello stile cinematografico. Nel caso di un documento che mostri l’oggetto di studio — sia esso un rito, una popolazione, un costume o una città — si tratta non solo di un supporto alla ricerca ma del modo stesso di farla. È nella forma del documento che la ricerca stessa si mette in opera e mostra la sua qualità e i suoi punti forti.
Gli albori del cinema etnografico, da Timothy Asch a Jean Rouch stesso, erano ben coscienti dell’importanza dello sguardo. Ricordiamo che Tim Asch fu tra i primi a mostrare i filmati sugli indiani Yanomami agli Yanomami stessi, con risultati sorprendenti nella percezione dell’opera.
Noto che nelle opere mostrate al festival negli ultimi anni c’è una certa libertà a livello formale ma anche di contenuto, soprattutto per quanto riguarda la narrazione, e trovo che questo sia particolarmente interessante. Anche nel documentario, presa coscienza dell’impossibilità di una resa obiettiva degli eventi, si riscontra una rottura della linearità tradizionale con la sperimentazione di nuove forme.
MT: Il cinema di Jean Rouch era sicuramente straordinario dal punto di vista etnografico ma la sua grandezza stava soprattutto nel modo in cui ha saputo rinnovare le regole cinematografiche, concorda?
 MHP: Ciò che indubbiamente Jean Rouch ci ha lasciato è la sua capacità di attraversare le frontiere, sia nel cinema che nell’etnologia. Si è trovato in Africa come etnologo e non come cineasta. Indifferente alle leggi della macchina da presa, le ha trasgredite per necessità. Al tempo stesso, trovandosi ai limiti tra un dominio e l’altro, il cinema e l’etnologia, ha finito per superare le frontiere che erano tradizionalmente imposte a entrambe. Sia da una parte che dall’altra Rouch ha dovuto reinventare le regole per adattarle alle sue necessità. La sua più grande eredità nel cinema etnografico attuale è proprio questa capacità anarchica di trasgredire le regole, rifondarle per dare nuove e originali visioni del mondo.
MHP: Ciò che indubbiamente Jean Rouch ci ha lasciato è la sua capacità di attraversare le frontiere, sia nel cinema che nell’etnologia. Si è trovato in Africa come etnologo e non come cineasta. Indifferente alle leggi della macchina da presa, le ha trasgredite per necessità. Al tempo stesso, trovandosi ai limiti tra un dominio e l’altro, il cinema e l’etnologia, ha finito per superare le frontiere che erano tradizionalmente imposte a entrambe. Sia da una parte che dall’altra Rouch ha dovuto reinventare le regole per adattarle alle sue necessità. La sua più grande eredità nel cinema etnografico attuale è proprio questa capacità anarchica di trasgredire le regole, rifondarle per dare nuove e originali visioni del mondo.
MT: Al festival Jean Rouch si vedono sempre più opere provenienti da quei paesi che una volta erano l’oggetto di studi dell’etnografia.
MHP: La cosa interessante in questi nuovi cineasti è che, lavorando sulla propria cultura e il proprio territorio, non hanno la stessa direzione dello sguardo. Evidentemente un documentario girato da un americano sui boshimani non sarà uguale a un documentario girato da un boshimano sui boshimani stessi. Allo stesso modo, dovremmo anche chiederci se il film di un americano sulla società parigina non possa darci quella nuova prospettiva sulla società che potrebbe essere necessaria alla sua analisi. La cosa interessante, scomparso l’ideale ottuso del punto di vista oggettivo, è l’idea di una prospettiva a partire dalla quale la nostra identità si autodetermina culturalmente. Attraverso degli sguardi comparati potremmo arrivare ad osservare l’influenza della cultura e il modo in cui questa può determinare il punto di vista.
Ora, una questione assolutamente rilevante nel modo in cui certi cineasti asiatici trattano il documentario, riguarda ad esempio la temporalità. Si nota spesso nei documentari dell’Est Europa e dell’Asia centrale, un interesse diverso al ritmo e al modo in cui la narrazione viene fatta scorrere lungo la durata. Al tempo stesso, anche nel documentario, c’è una diversa ricerca sulla linearità narrativa. Si tratta di un caso oppure è l’influsso di una diversa cultura? Credo sia su alcuni di questi aspetti che l’antropologia, così come il cinema, hanno interesse a lavorare di questi tempi.
MT: Quali sono le prospettive del Festival Jean Rouch per le prossime edizioni?
MHP: Con la chiusura del Musée de l’Homme per restauri, prevista in settembre, il Comité du Film Ethnographique dovrà spostarsi. Questa piccola rivoluzione credo possa apportare una certa novità nella struttura di un festival e di un’associazione storici che hanno bisogno di rinnovarsi per far fronte ai cambiamenti attuali.
Il prossimo festival si terrà alla Bibliothèque Nationale Francois Mitterand, luogo mitico, dove sale ad alta tecnologia e tutta una nuova serie di strumenti tecnici saranno forniti al Comité. Sarà forse l’occasione per rinnovare il programma stesso. Ogni anno arrivano più di trecento film ma ne vengono selezionati appena una trentina. Semplicemente per esigenze di programma, orari o temi delle proiezioni, siamo costretti a escludere delle opere straordinarie. In particolare amerei vedere nelle prossime manifestazioni una maggiore presenza di opere sperimentali, in modo da lasciare spazio a nuove forme di etnografia, provenienti da altre culture.

