 Prendendo spunto da un reale fatto di cronaca, l’incarcerazione di un cittadino svedese di origine araba, Gitmo -The new rules of war indaga sulla base americana di Guantanamo, diventata tristemente famosa come centro di detenzione e tortura per sospetti terroristi. Il film è co-diretto da Erik Gandini e Tarek Saleh, che si sono recati personalmente a Cuba, dove si trova il carcere. La loro permanenza è diventata una sorta di “soggiorno turistico” ad ottime condizioni, con i militari USA nell’insolita veste di guida turistica. Ai visitatori viene mostrato come vivono e si divertono i soldati, ma non viene permesso incontrare o parlare coi prigionieri. Di notte, le urla che echeggiano in tutto il campo vengono spiegate dai militari con: “stanno dicendo le loro preghiere”.
Prendendo spunto da un reale fatto di cronaca, l’incarcerazione di un cittadino svedese di origine araba, Gitmo -The new rules of war indaga sulla base americana di Guantanamo, diventata tristemente famosa come centro di detenzione e tortura per sospetti terroristi. Il film è co-diretto da Erik Gandini e Tarek Saleh, che si sono recati personalmente a Cuba, dove si trova il carcere. La loro permanenza è diventata una sorta di “soggiorno turistico” ad ottime condizioni, con i militari USA nell’insolita veste di guida turistica. Ai visitatori viene mostrato come vivono e si divertono i soldati, ma non viene permesso incontrare o parlare coi prigionieri. Di notte, le urla che echeggiano in tutto il campo vengono spiegate dai militari con: “stanno dicendo le loro preghiere”.
Il documentario dà la parola ai due detenuti svedesi che sono riusciti a tornare da Guantanamo, uno ancora capace di ironia, l’altro completamente spezzato dall’esperienza. Si indaga sulla rimozione del Generale Baccus, troppo tenero coi prigionieri, sostituito poi dallo spietato Generale Miller, lo stesso che venne nominato alla guida del carcere iracheno di Abu Ghraib.
Abbiamo incontrato Erik Gandini al NodoDocFest di Trieste, dove ha vinto un premio speciale, e gli abbiamo chiesto di raccontarci l’esperienza che lo ha portato a Cuba e le motivazioni che lo hanno accompagnato in questo viaggio.
Sarah Gherbitz (SG): Quale idea avevate di Guantanamo quando avete iniziato a lavorare?
Erik Gandini (EG): Tarek e io avevamo interesse a capire questo posto che sembra non esista, ogni tanto lo vedi nei giornali o in televisione, in qualche fotografia, ma è come se dovessimo accettare che questo posto non esiste. Ha attirato la nostra attenzione grazie al fatto che c’era questo prigioniero svedese, Mehdi Muhammed Ghezali, il cui padre si era chiuso in una gabbia nel centro di Stoccolma, in piazza. Incontrare questo padre disperato, che sembrava fosse l’unico che veramente si preoccupasse del figlio, ci ha fatto pensare molto e ci ha fatto anche decidere di non rimanere degli spettatori passivi rispetto a questo posto, a quello che si può vedere nei piccoli inserti sui giornali o in una fotografia ormai vecchia di qualche anno, del primo periodo di Guantanamo. Ma ci ha invece suggerito di fare una cosa che poteva sembrare assolutamente folle, quella cioè di cercare di andare a Guantanamo e capire che cosa succede.
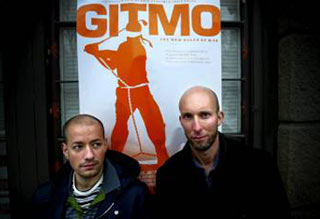
SG: Qual è stata la reazione a Guantanamo, quando li avete contattati per le riprese?
EG: Il film inizia con questa telefonata con cui chiamiamo l’esercito americano chiedendo se possiamo andare a Guantanamo. La risposta è stata una grossa sorpresa per noi, nel senso che ci hanno accolto a braccia aperte, sembrava che fosse veramente un viaggio organizzato, un chart per i Caraibi. Ci siamo resi conto strada facendo che questa è stata una strategia molto intelligente, nuova, di dare l’impressione che tutto sia aperto, che tutto sia accessibile. È una nuova strategia di censura: dire che tutto è aperto quando in realtà non lo è, in realtà è un modo di darsi un’apparenza che è solo di superficie.
È stata anche l’occasione di inventarsi tutto un nuovo linguaggio che noi chiamiamo newspeak, in un mondo in cui tutte le parole hanno perso di significato. Il fatto che noi siamo stati ben accolti a Guantanamo non significa assolutamente che fossimo autorizzati a fare niente, il fatto che ripetessero decine e decine di volte che i soldati fossero trattati “nello spirito della convenzione di Ginevra” vuol dire che della convenzione non gliene frega niente! Il fatto che dicessero che i detenuti erano trattati umanamente in realtà voleva dire il contrario, perché i detenuti venivano regolarmente torturati.
SG: Le ricerche per questo documentario sono durate tre anni, quali difficoltà avete incontrato durante questo percorso?
EG: Questo tipo di lavori iniziano con delle grandi incertezze, con delle grandi imprevedibilità. Siamo andati a Guantanamo nell’aprile del 2003 e non avevamo idea di quello che succedeva, abbiamo intervistato il generale Miller e non sapevamo che questo generale sarebbe poi riapparso ad Abu Ghraib, che avrebbe poi avuto un ruolo molto centrale in questa storia.
È stato un lavoro di inchiesta molto lungo proprio per il fatto che a periodi abbiamo dovuto veramente lasciare il lavoro, aspettare che succedessero cose nuove, che venissero fuori dati nuovi. Sempre appunto in una situazione di costante incertezza. La nostra idea di fondo era una sola: che ci fosse qualcosa di veramente malato dietro questa superficie di totale normalità.
Più le guide e i soldati di Guantanamo cercavano di fare dei gran sorrisi e di convincerci che tutto era a posto, che a Guantanamo si gioca a golf, che tutti i detenuti aumentano di peso — “di sei pound in media l’uno” -, che Guantanamo fosse il posto migliore dove stare… Be’, più loro cercavano di darci quest’impressione, più noi avevamo l’impressione che ci fosse qualcosa di malsano: malato è proprio la parola giusta. Questo è stato il motivo per cui abbiamo continuato a scavare e si è rivelata una giusta intuizione.

SG: Il film alterna alcune parti girate in digitale, come le interviste ai protagonisti, con delle parti realizzate in pellicola, come mai questa scelta?
EG: Le emozioni che provi quando sei in questi posti è il tuo capitale emotivo per poter trasmettere quello che hai provato attraverso il linguaggio cinematografico. Noi avevamo l’impressione di essere come Alice nel Paese delle Meraviglie, un mondo dove tutti sono gentili e contenti, con queste parole che non vogliono più dire niente. Cerchiamo di lavorare molto con la pellicola, per noi è importante la qualità dell’immagine: lavoriamo in 16 mm, cosa che quasi nessuno fa ormai con i documentari.
Proprio per il tipo di immagine che puoi cogliere con questa risoluzione la parte visiva è molto importante per noi, è forse quello che trasmette di più questa componente emotiva di cui parlavo prima. Per esempio, quando ci portano a vedere Gitmo by night, come se fosse una curiosità da turisti vedere il campo di notte: per fortuna più vicino di così non ci siamo arrivati di fatto! Sentire queste urla dei prigionieri dentro Guantanamo era una situazione da film dell’orrore. Quando senti gli effetti di qualcosa, quando non puoi vedere che cosa c’è dietro questi lamenti, il risultato è un’atmosfera da incubo, sicuramente rappresentativa per Guantanamo e per chi c’è dentro.
SG: Sono sempre più numerosi i filmaker che decidono di autoprodursi o reperire i fondi all’estero, lei ha addirittura fondato una società di produzione, la Atmo a Stoccolma, città dove abitualmente risiede e lavora…
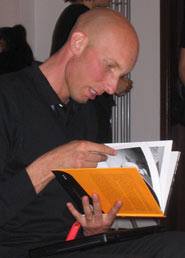 EG: Io vivo in Svezia da molto tempo e per il mio lavoro è assolutamente importante. È l’unico paese dove potrei fare questo lavoro nel modo in cui mi piace farlo. In Italia non potrei fare film, avrei molte difficoltà a finanziarli, avrei tantissima difficoltà a vederli in televisione. In Svezia ho trovato, invece, una realtà molto favorevole al documentario. Non solo è finanziato, ma è anche visto come una forma d’arte cinematografica dignitosa, è recensito, premiato, e considerato non la serie B del cinema ma, anzi, a livello di autorevolezza, un equivalente del cinema di fiction. Poi la Svezia è un paese piccolo, non c’è una grandissima produzione, però la tradizione della realtà è forte, e soprattutto di una televisione non commerciale, dove non c’è nemmeno la pubblicità. In Svezia, dagli anni Sessanta, c’è la concezione di usare la televisione come una finestra sul mondo, e non una finestra sulla televisione, come purtroppo avviene in Italia.
EG: Io vivo in Svezia da molto tempo e per il mio lavoro è assolutamente importante. È l’unico paese dove potrei fare questo lavoro nel modo in cui mi piace farlo. In Italia non potrei fare film, avrei molte difficoltà a finanziarli, avrei tantissima difficoltà a vederli in televisione. In Svezia ho trovato, invece, una realtà molto favorevole al documentario. Non solo è finanziato, ma è anche visto come una forma d’arte cinematografica dignitosa, è recensito, premiato, e considerato non la serie B del cinema ma, anzi, a livello di autorevolezza, un equivalente del cinema di fiction. Poi la Svezia è un paese piccolo, non c’è una grandissima produzione, però la tradizione della realtà è forte, e soprattutto di una televisione non commerciale, dove non c’è nemmeno la pubblicità. In Svezia, dagli anni Sessanta, c’è la concezione di usare la televisione come una finestra sul mondo, e non una finestra sulla televisione, come purtroppo avviene in Italia.
La tivù come finestra sulla tivù perde la sua funzione, mentre la tivù come finestra sul mondo è un’ottima idea!


