 Matteo Danieli (MD): Incominciamo dalla prima poesia di questo lavoro Capitoli della Commedia (Edizioni Atelier, 2005): “Il giorno che ho ucciso mio padre”. Hai trovato spunto da una storia reale oppure hai immaginato un omicidio in una realtà di provincia? E perché? E perché l’omicidio resta impunito?
Matteo Danieli (MD): Incominciamo dalla prima poesia di questo lavoro Capitoli della Commedia (Edizioni Atelier, 2005): “Il giorno che ho ucciso mio padre”. Hai trovato spunto da una storia reale oppure hai immaginato un omicidio in una realtà di provincia? E perché? E perché l’omicidio resta impunito?
Martino Baldi (MB): Niente di tutto questo. Il clima è chiaramente quello dell’evento di cronaca o del thriller, ma non ha niente a che vedere con precisi eventi realmente accaduti. È, se vuoi, una scelta di strategia “narrativa” per raccontare un parricidio simbolico. Il padre, credo si capisca rileggendo il testo, scompare da solo. Più che un vero e proprio parricidio alla fine è la presa d’atto necessaria di un’estinzione già di fatto avvenuta, e la propria liberazione. Non c’è l’atto omicida. Come non c’è nessuna ribellione giovanilistica, anzi. Quel parricidio per me ha significato ricominciare a pensare il mondo secondo la necessità di una “visione sistemica e non ideologica” personale e autonoma. Il nostro paese (o forse il nostro tempo) vive di una crisi profondissima soprattutto perché rifiuta l’ossigenazione del pensiero a tutti i livelli. I nostri padri, nell’arco di appena cinquant’anni, hanno costruito “un incubo a chiusura ermetica” in cui non riconoscono un vero ruolo di iniziativa alle nuove generazioni. Io credo che difendere la tradizione significhi rinnovarla in continuità; l’autorità che difende — come accade — solo le proprie prerogative porta la tradizione a consunzione, impedendole di nutrirsi. Rende se stessa semplicemente un ostacolo, come lo sono state tutte le forme sociali superate dai tempi perché non hanno saputo rinnovarsi.
Questa incapacità di rinnovamento è evidente oggi, per esempio, nella morale pubblica. C’è una nuova generazione che richiede comportamenti più retti, che pensa il bene come bene comune, che ha sviluppato una capacità enorme di auto-determinazione e auto-organizzazione “moralmente compatibili” e siamo invece nelle mani di autorità (a tutti i livelli) che… insomma, ci siamo capiti. Ecco, il poemetto iniziale racconta, in un certo senso, del momento in cui ho riconquistato “la legge morale dentro di me”. E non è possibile fare questo laicamente se non disconoscendo quanto modella acriticamente, in modo silenziosamente ideologico (in quanto non discusso), le nostre coscienze di uomini, ma anche le nostre posizioni di artisti o fruitori rispetto all’arte. Una nuova e forte coscienza laica, necessaria quanto mai oggi, non può che rinascere sulle ceneri dell’atteggiamento intellettuale e della prassi dominanti, misurati sul “particolare”, e deve innanzitutto riconquistare la forza intellettuale di pensare il tutto, la capacità di pensarlo tutto insieme e il diritto di pensarlo diverso. Nonché l’umiltà di volerlo comunicare con umiltà. Questo si può fare solo entro una assoluta libertà di pensiero che contempli una ridiscussione di molti giudizi, ovvero al termine di una lunga serie di “parricidi”.
MD: La pagina 230 del televideo oggi recitava: “Parola sta bene, problemi per Tosto”. Cosa puoi dirci di questo?
MB: All’epoca del parricidio, le pagine 101 e 230 del Televideo a cui si fa riferimento in “Il giorno che ho ucciso mio padre” erano rispettivamente “Ultim’ora” e “Altri sport”. Adesso la pagina 230 è diventata il bollettino sullo stato di salute dei giocatori dell’Ascoli, perché Televideo ha moltiplicato le pagine dedicate al calcio. Il progresso tecnologico cambia continuamente le carte in tavola. Detto questo, lascio a chi legge il poemetto le deduzioni del caso.
MD: Nella Casa Gialla sembri descrivere i personaggi di una struttura psichiatrica o per affetti da handicap. Ci lavori o ne sei a contatto? E come la diversità ha influito sul tuo scrivere?
MB: Ho fatto il volontario e poi l’obbiettore di coscienza in un istituto di assistenza per handicappati mentali. La casa gialla altro non è che quell’istituto. Non credo che questa esperienza, come esperienza della diversità, abbia influito particolarmente sulla mia scrittura. O meglio, vi ha influito al pari di tutte le altre esperienze che ho avuto e che hanno formato la mia mente, il mio corpo e quindi — va da sé — la mia voce. Credo invece, ma l’autoanalisi può certo essere fallace o parziale, che ad essere stata molto più decisiva per me sia stata una costante posizione di differenza rispetto a ogni cosa, perfino ai numerosi “me stesso” che ho conosciuto. Non ho mai abbracciato nessuna idea fino in fondo, ho avuto molte esperienze fuori dalla norma di chi mi stava accanto, ho compiuto e pagato moltissimi errori “in proprio”, ho sempre avuto posizioni fortemente anti-ideologiche, sempre orientate a un tentativo di pensare il tutto, partendo — come è normale — da giudizi di rifiuto nei confronti dell’esistente fino a giungere alla tensione verso una sorta di “armonia mobile”.
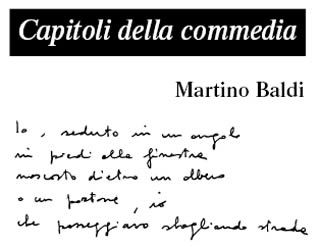
In questa armonia mobile, che va pensata come continuamente nuova, c’è un posto per tutte le diversità e le differenze. Nelle cose della vita e della scrittura questo si traduce nel tentativo di affrontare tutto senza regole ma con una costante e allertata presenza di spirito; che vuol dire contemporaneamente di pensiero e di cuore, in tutte le accezioni che questi due termini possano avere. Humor compreso, giacché credo che prendere sul serio le cose che si fanno ma non prendere troppo sul serio se stessi sia l’esercizio migliore che si possa fare per rendersi compatibili col mondo. È di sicuro più difficile a farsi che a dirsi.
MD: Come concepisci impegno sociale e impegno politico? E come si conciliano col quotidiano? Basta il micro-impegno nel quotidiano (non inquinare, magari boicottare alcuni prodotti aggiungo io, ecc.) o sono più efficaci azioni dirompenti?
MB: Se permetti, unisco le due domande, anche perché penso d’aver già soddisfatto entrambe, in parte, nelle risposte precedenti.
È un dubbio per cui non c’è una risposta, e infatti lo pongo in forma di dubbio in una delle poesie della sezione “Trentadue lattine”. In fondo, credo che non basti né l’uno né l’altro ma forse riesco ad essere più chiaro se posso risponderti con un paradosso. Sotto un regime monarchico mi augurerei di avere un sovrano saggio e magnanimo. Sotto un regime oligarchico, mi augurerei che i detentori del potere fossero il più possibile saggi e onesti. In democrazia sarebbe necessario che ad essere saggia, magnanima e onesta fosse la popolazione. Per questo credo che l’investimento principale della politica dovrebbe essere orientato verso la cultura, che è l’unico mezzo per far crescere il livello di coscienza critica autonoma di un individuo, e per questo motivo credo che fare arte o cultura abbia oggi un senso che va ben oltre i limiti ristretti dei meccanismi dello show business o dell’intrattenimento. Penso che l’impegno generale dovrebbe essere orientato all’arricchimento di cultura e penso che una politica che assecondi la superficialità, come ogni gesto politico che miri alla semplificazione, da qualunque parte miri, ci conduca sempre un gradino più in basso. È inutile organizzare perfettamente un supermercato se poi i dirigenti si prendono le tangenti dai fornitori, i commessi rubano i prodotti dagli scaffali e i cassieri intascano furtivamente parte dell’incasso.
Quindi, per risponderti, e rispondermi, non credo che ci sia bisogno di azioni dirompenti come non credo che basti un impegno quotidiano nelle piccole cose. Dobbiamo esigere più rettitudine, più pensiero e più cultura. Il capitale di una società sono gli uomini che la compongono: nient’altro. Se miglioreranno gli uomini, migliorerà la società. Il resto serve per la statistica. Che serve ai pubblicitari.

MD: L’ingordigia come peccato capitale derivato dal cattolicesimo, ingordigia come capitalismo, o semplicemente un vuoto da riempire?
MB: Ingordigia come tutto quello che può far venire in mente. E poi c’è anche il piacere del mangiare, perché no? Comunque, se dovessi proprio fare una raccomandazione a un lettore, inviterei a non leggere mai le mie poesie come allegoriche. Ogni cosa sta per se stessa, e sono già abbastanza i collegamenti con tutto il resto che questo comporta: imparare a vedere la realtà per quello che è, lasciar essere le cose e le persone, non dare per forza giudizi, anzi esercitare soprattutto il dubbio, e casomai interrogarsi su come un evento possa influenzare il contesto in cui si colloca e viceversa… Mi sembra che ce ne sia abbastanza per non dover scomodare una dimensione allegorica o addirittura, come si diceva un tempo, “altra”. Per me l’alterità delle cose è l’insieme delle cose, l’orizzonte è il sistema (anzi, i diversi sistemi) in cui ogni cosa si colloca.
MD: Il tuo scrivere è fortemente autobiografico, si concentra su una fatica del vivere che vanifica gli sforzi di trovare una bellezza nelle piccole cose, quanto è possibile poter mantenere costante il valore delle piccole cose nella frenesia del mondo moderno?
MB: Non sono d’accordo sul fatto che la mia scrittura si concentri, come dici, «su una fatica del vivere che vanifica gli sforzi…». Anzi, direi addirittura il contrario. Direi che si concentra sullo sforzo di riconoscere ovunque quel che c’è. La bellezza o la bruttezza, se di questa si tratta. A me pare che la realtà oggigiorno non la si guardi abbastanza. Siamo ormai contaminati da una sovrabbondanza di immagini e informazioni che hanno gravemente intossicato il nostro spirito critico e la nostra immaginazione. Ora, non credo che il modo corretto di reagire sia quello di darsi a una poetica delle piccole cose. Come a volersi concentrarsi sul proprio microcosmo personale, magari neutralizzandolo in uno sguardo affettuosamente elegiaco o in linguaggio gelido da piccolo tavolo di anatomia, per sfuggire al “rumore” del mondo. Credo che le cose vadano interrogate per quello che ci possono dire rispetto al mondo, a noi stessi e agli altri, al nostro destino e, soprattutto, a quello che possiamo fare per vivere meglio.
E che le risposte debbano il più possibile essere condivise. Per far questo è necessario prima di tutto guardarle bene, le cose, come se non si fossero mai viste prima o come se stessero per abbandonarci per sempre. Questo è un grande sforzo ed è una delle cose che credo di celebrare. O almeno è ciò che vorrei.
MD: Come ci si può immedesimare oggi in un testo di poesia? Personalmente mi riesce facile con un romanzo a prescindere che poi mi piaccia oppure no, ma nella poesia spesso sembra preclusa anche l’immedesimazione poiché il linguaggio si fa troppo personale. Ritieni che l’immedesimazione sia una chiave fondamentale nel rapporto autore-lettore? Quando scrivi, vuoi esprimere un’idea, suscitare un’emozione, creare bellezza o in primis vuoi essere qualcuno? Cioè ritieni di produrre idee, cultura con la tua opera e ti poni narcisisticamente come punto di riferimento?
MB: Mi chiedi innanzitutto dell’immedesimazione… Non lo so. Non mi sono mai posto il problema dell’immedesimazione. Mi sono invece posto il problema del linguaggio, e quindi del destinatario. Ritengo che non porsi il problema del destinatario più che un atto di purezza sia un atto di snobismo e onanismo intellettuale. Questo atteggiamento ha generato una grande quantità di poesia, minore per elezione, che rinuncia a priori sia a soddisfare il bisogno di poesia, che c’è ed è assolto da altre forme d’arte o d’espressione, sia a dire la sua su quello che conta. Si fanno molti grandi esperimenti linguistici sul niente o ci si ripiega su piccole cose insignificanti, come se non ci fosse una via mediana tra il minimalismo e lo sperimentalismo. In sostanza, si rimane entro una poetica sotto sotto sempre classicista, fondata su canoni di esclusione.

Più esplicitamente, concordo con te che sia difficile leggere poesia oggi ma non so se sia per una questione di immedesimazione o perché la poesia sia spesso scritta come esercizio destinato a una comunità ristretta all’interno della quale sono in vigore principi di valore derivati da una ristretta comunità e dal piccolo potere (reale o psicologico) che vi ha luogo. Il massimo a cui aspira normalmente un poeta è la pubblicazione e l’ammirazione di pochi lettori, che magari conosce per nome e cognome. Io trovo che l’ammirazione non sia un sentimento da augurarsi. È un sentimento gelido, che allontana. Preferisco, casomai, la compassione. Preferirei che qualcuno, dopo aver letto le mie cose, avesse voglia di condividere un buon vino (rosso) o di abbracciarmi o di sedersi accanto a me ad osservare in silenzio il panorama, piuttosto che di dirmi quando sono bravo. Preferirei che un lettore, dopo aver letto il mio libro, uscisse di casa e facesse finalmente quel che deve fare, piuttosto che cercare di imitarmi perché ammira la mia scrittura. Mi chiedo continuamente se la poesia che serve, anzi interessa solamente a se stessa, abbia un senso? Molti rispondono ancora di sì. Io la penso diversamente. E cerco di scrivere di conseguenza.
MD: Se la poesia è un mezzo supremo perché non esercita la sua supremazia su un mezzo come per esempio il cinema? A me sembra che sia collocata in una sorta di zona sospesa dove è di massa perché tutti la fanno, ma è d’elite perché pochi la comprano…Cosa ne pensi? Rimanendo nell’ambito del cinema sembra quasi la lotta tra il cinema di seconda visone e il cinema sette sale al centro commerciale.
MB: La poesia è un mezzo di espressione come tutti gli altri. Né più né meno. E come in tutte le cose, la qualità è nell’uomo, non nel mezzo.

