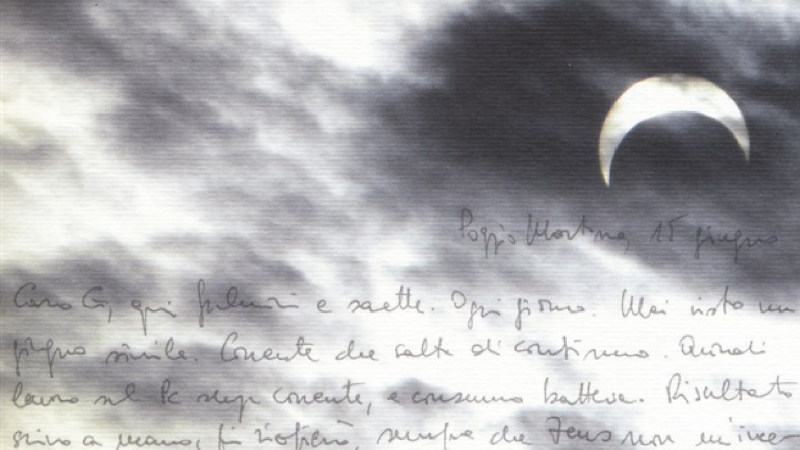Adriano Padua (AP): Cominciamo la discussione parlando di due volumi da poco presenti in libreria. Il primo è l’antologia Parola Plurale edita da Sossella, nella quale sei presente. A tuo avviso è possibile, per la critica che si occupa di poesia italiana contemporanea, operare una “mappatura dell’esistente”? L’antologia curata da Cortellessa è in questo senso un buon esempio? O è meglio esercitare la critica sui testi, senza proporre un quadro generale del complesso panorama odierno?
Tommaso Ottonieri (TO): Difficile, credo, poter contemplare la quantità di sommerso e di “inesistente” (nel senso, che è invisibile), che spesso ha dignità per nulla inferiore rispetto all’esistente. Comunque sia, vale la pena tentare di tracciare delle linee di tendenza, per quanto oggi (dalla parte degli autori o aspiranti tali) mi pare piuttosto si brancoli nel buio. A casaccio, spesso. Senza capire che la “tendenza” è tutto quello che c’è nell’aria (in troppi continuano a credere in un fantasma di poesia che permanga avulsa dalle forme che ci si sciorinano davanti, nell’attraversare l’immanenza della storia). La Parola Plurale è un testo veramente ottimo, e anche eroico; riesce a contemplare le tendenze ma anche le non-tendenze. Le controtendenze e gli accidenti. E però appunto (ironia del destino) non è più “esistente” in libreria, né più lo sarà — pur avendo esaurito in due mesi la prima tiratura. Misteri dell’industria editoriale.
AP: Concordi con le tesi contenute nell’ultimo libro di Romano Luperini, La fine del Postmoderno? Oggi è in atto una nuova fase di “controtendenza neomodernista”, sia in letteratura che nella realtà materiale? Il postmoderno è finito con il “ritorno della storia” nelle nostre vite? Gli intellettuali sono stati sostituiti nel ruolo di critici dei costumi e della società?
TO: È che tutto l’orizzonte in cui ci muoviamo, da una quarantina d’anni a questa parte, mi pare inscrivibile piuttosto in una categoria di “tarda modernità”. Esplosione del Capitale, e sua trasformazione genetica, su scala planetaria. La “globalizzazione” è l’orizzonte stesso del Moderno; solo, è ormai chiaro da tempo che i suoi sviluppi sono assai meno controllabili di quello che si (=il Capitale stesso) sperava. D’altra parte, credo che anche nel periodo più “ramazzottimista” (Milano-da-bere), gli anni ’80, fossero in molti ad avvertire disagio; e a elaborare tecniche di resistenza: le quali ovviamente, nella “scomparsa” di un nemico nettamente fronteggiabile, si nutrivano piuttosto delle proprie incertezze. Facendone pathos. — (Quanto al ritorno della Storia, certo, e ad una Storia che ha tutti i tratti dell’Arcaico, del Tribale: vorrei sottolineare la sua natura innanzitutto mediatica. La sua stessa scena iperlocalmente globalizzante. Eccetera). — Se per intellettuali s’intendono gli scrittori, o più in genere gli artisti, in linea di principio credo che il loro, sacrosanto “ruolo di critici dei costumi e della società” fanno bene a esprimerlo testualmente, e non sparando (banalità, spesso, o pseudo-provocazioni) dalle testate dei giornali: a meno che non abbia una responsabilità pubblica, un pubblico talmente vasto da giustificarne il presenzialismo. E credo inoltre che un testo non sia un palchetto ad Hyde Park; certo, è importante cosa dire (quale critica esprime — ciò che un’opera d’arte affronta, sempre, è Crisi): ma ciò che di un oggetto, linguistico, visivo, sonoro, ecc., fa un testo, è piuttosto il come.
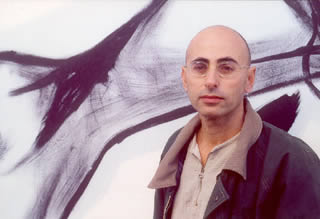
AP: Nella tua produzione, poetica e non, si avvertono sensibili mutamenti dai tempi del collettivo KB e del gruppo 93? Nel contesto odierno ritieni ancora possibile la formazione di gruppi e movimenti poetici?
TO: Tutto quello che attraversiamo ci riguarda. Il sodalizio instaurato con Frasca fin dalla tarda adolescenza, e poi subito con Durante e Frixione (“KB”), è stato, naturalmente, importantissimo, soprattutto per la mia produzione in versi. Negli anni del gruppo 93 sono entrato in contatto con tante realtà notevoli, ma c’era un’esposizione pubblica sbagliata, e decine di sedicenti poeti, con entrature editoriali, pronti a sparare al solo udire la parola “ricerca”. Ma “gruppi” e “movimenti”, persone che si raccolgono attorno a progetti, incontri, riviste, sono all’ordine del giorno, e solo in minima parte si può parlare di “sperimentazione”; d’altro canto (e qui rovescio l’istanza di cui sopra) è importante sempre partire da un’analisi delle situazioni attuali, storiche prima che estetiche. Da un sentimento del presente (spesso, si brancola invece in logiche che, consapevolmente oppure no, si rivelano restaurative: sotto il profilo formale, dunque politico).
AP: Cosa pensi delle generazioni di poeti successive alla tua? Ci sono tendenze, linee di ricerca o anche poetiche di singoli autori che, a tuo avviso, si distinguono da tutto il resto?
TO: Molti poeti di grande interesse, oggi trentenni, sono emersi dai tardi anni ’90. Soprattutto donne. Ma preferirei non citare — mi dispiacerebbe dimenticarne qualcuno/a.
AP: La situazione estremamente frammentaria della piccola editoria italiana che pubblica poesia è un freno alla diffusione e alla crescita qualitativa della stessa o sintomo di fervore culturale, anche a livello locale?
TO: Non vedo, salvo eccezioni rarissime (ad esempio, le edizioni d’if), un progetto reale, dietro le iniziative editoriali in poesia, che vengano da piccoli o da grandi editori. Il fervore naturalmente c’è, ma non trova sponde; e rischia di spegnersi. Suggerirei di ripartire dallo strumento della rivista.
AP: Cresce la presenza in rete di riviste o blog dedicati alla poesia e alla letteratura. Favoriscono lo sviluppo di un dibattito serio e proficuo o sono poco utili? Cucchi sostiene che la rete è soltanto una cloaca…
TO: Gente come Cucchi sostiene che solo chi pubblica nelle collane che (non si capisce bene come) controlla, ha diritto di esistere. La questione piuttosto è che solo quel che è mediocre non ha diritto di esistere. La rete va benissimo, la sua leggerezza favorisce il dibattito (oltre che grafomanie di ogni genere, non sempre più indegne delle scritture patentate). Il problema, piuttosto, è nel collegamento… Proprio perché la rete, nell’allargarsi, rischia di favorire soprattutto la dispersione.
AP: Si trascina ancora in varie sedi il dibattito sulla crisi o la morte della critica, qual è il tuo parere al riguardo?
TO: Ho scritto cose rispondendo, pagine su pagine, a un questionario della rivista “Atelier”, pagine e cose che adesso non ricordo. Comunque sia, rispetto a una situazione sicuramente fiacca, e finalizzata esclusivamente al Megastore, vi sono nuove voci originalissime e potenti. Credo che l’antologia, di cui si parlava all’inizio, testimoni anche di questo.
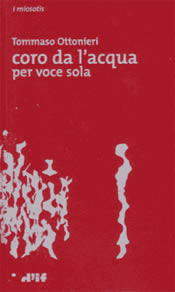 AP: Quanto è importante nella tua poesia la dimensione performativa e la collaborazione con musicisti o videoartisti? Secondo te la crescente presenza di festival, slam poetry, letture in pubblico è un fatto positivo?
AP: Quanto è importante nella tua poesia la dimensione performativa e la collaborazione con musicisti o videoartisti? Secondo te la crescente presenza di festival, slam poetry, letture in pubblico è un fatto positivo?
TO: La performatività, nel mio fare testuale, è presente all’atto stesso della scrittura. La performance effettuale può internsificarne la portata; ma anche, riduce il campo dei suoi possibili, che sono tutti compresenti nell’ordine della scrittura. Una partitura degna è quella destinata non ad una esecuzione, ma ad una molteplicità di esecuzioni, preferibilmente in conflitto. Ma naturalmente, l’esecuzione (come “altro” specifico) mi interessa moltissimo, in qualità di performer in prima persona. Importantissimo il contributo creativo di musicisti e artisti visivi: proprio per un rilancio, moltiplicativo, del testo, e del suo senso.
AP: Segui la poesia estera contemporanea? Apprezzi qualche autore straniero in particolare?
TO: Ehm… non sono aggiornatissimo. Ma poi, non è che sia del tutto uno specialista della disciplina; il fatto è che amo piuttosto definirmi uno scrittore (nel senso più pratico, tecnico, materiale, totale, che questa parola possa contemplare).