Dopo mesi di corteggiamento, finalmente Darrin Verhagen appare su Fucine Mute. Il progetto Shinjuku Thief è l’incontro perfetto tra minimalismo classico e industrial/ambient, armonia e disarmonia. Un disco come “The Witch Hammer”, che fa parte di una trilogia ispirata al Malleus Maleficarum, è una piccola gemma da custodire gelosamente, al pari di altri come “Medea” o “Sacred Fury”. Quest’ultimo album ricrea un campo di battaglia mediante l’uso dei campionamenti, commentando la tragedia della guerra attraverso il suono degli archi e di altri strumenti, come il flauto della struggente traccia iniziale.
La cultura, l’intelligenza e l’esperienza di Darrin hanno reso quest’intervista un’interessante panoramica su tutto un genere musicale e non solo su Shinjuku Thief.
 Fabrizio Garau (FG): Sei un docente. In Italia non abbiamo insegnanti come te e non abbiamo corsi come i tuoi. Raccontami qualcosa delle tue lezioni, per favore.
Fabrizio Garau (FG): Sei un docente. In Italia non abbiamo insegnanti come te e non abbiamo corsi come i tuoi. Raccontami qualcosa delle tue lezioni, per favore.
Darrin Verhagen (DV): Divido il mio tempo tra due classi: “Sound design” e ” Technology, Composition and Perception”. Sound design esamina i principi fondamentali (siano essi presi dalla biologia, dai processi neurologici o dalle convenzioni artistiche) che informano una relazione tra suono e visione. Tutto questo è esaminato attraverso esempi di sound design e colonne sonore di film, e questa base cinematografica viene messa a confronto e contrasto con altri media (videogames, teatro, danza, interfacce sonore ecc.). “Technology, Composition and Perception” esamina gli sviluppi tecnologici e la loro impronta sulla composizione. Studiamo un ampio raggio di approcci compositivi, attraverso un’ampia selezione di generi, e uniamo le nostre analisi di tutte queste diverse forme mediante un esame di teorie neurologiche che descrivono i modi con i quali il nostro cervello elabora i flussi di informazione estetica.
FG: In quanto rivista che ha a che vedere anche col postmoderno, è interessante per noi sapere come un musicista entri in contatto con la “cultura del campionamento” e perché decida di esprimersi attraverso la musica elettronica.
DV: Penso che abbia meno a che vedere con una conscia decisione filosofica e più con la disponibilità dei mezzi.
Inizialmente, quando volevo creare musica che suonasse orchestrale, non c’erano synths che potessero fare un lavoro decente, indi (e in assenza di un budget per un’orchestra) il bisogno di cercare i campionatori come un’alternativa. In ogni caso, unificare una così diversa gamma di artisti è probabilmente un po’ riduttivo. Posso usare lo stesso equipaggiamento di un mercante plagiarista, di un artista hip hop e di FM Einheit, ma abbiamo tutti interessi diversi, diverse tecniche e diverse agende. È come questo trend attuale di “unire” i possessori di un iPod con questo iNod: una qualche percezione di identità culturale condivisa semplicemente perché stanno usando lo stesso pezzo di equipaggiamento per ascoltare probabilmente delle playlist largamente differenti! È folle…
FG: Il nome “Shinjuku Thief” è stato preso dal titolo di un film giapponese: questo film era un misto di differenti generi narrativi. Possiamo dire che tenti di fare lo stesso con la musica?
 DV: Era certamente così quando lavoravamo sull’album “Bloody Tourist”, che saltava da un genere all’altro. Nonostante ci siano vari sentimenti negli ultimi lavori di Shinjuku Thief, sono di solito abbastanza omogenei all’interno di uno stesso album, così il succitato riferimento a stili diversi nel nome della band è meno adatto ora di quanto lo fosse prima.
DV: Era certamente così quando lavoravamo sull’album “Bloody Tourist”, che saltava da un genere all’altro. Nonostante ci siano vari sentimenti negli ultimi lavori di Shinjuku Thief, sono di solito abbastanza omogenei all’interno di uno stesso album, così il succitato riferimento a stili diversi nel nome della band è meno adatto ora di quanto lo fosse prima.
FG: Quando utilizzi un campione ti senti come un ladro oppure innocente perché stai facendo qualcosa di nuovo?
DV: Be’, paragonati ai primissimi CD, i miei lavori più recenti hanno avuto a che fare sempre meno coi campionamenti. Nel momento in cui le mie libraries orchestrali aumentavano, c’era sempre meno bisogno di saccheggiare la mia collezione di musica classica per avere qualcosa su cui lavorare. In ogni caso penso che l’analogia col ladro sia qualcosa di sbagliato. Se fotocopio una serie di quadri e fotografie e le uso in un collage, non ho realmente “rubato” nulla. Gli originali sono ancora intatti dove si trovano. L’idea di campionamento come furto è stata propagandata solo da una cultura litigiosa e addomesticata. L’idea di vera originalità per molte culture popolari era un anatema che ha nutrito la loro storia per secoli.
FG: Non ne sono certo, ma suppongo che “The Witch Hammer” sia il tuo disco più conosciuto. hai detto che “l’impeto iniziale per scrivere ‘The Witch Hammer’ venne da un interesse musicale nell’impiegare un approccio hip hop alla costruzione, sebbene usando una tavolozza ‘classica'”- Penso sia una definizione molto importante. Puoi chiarirla ai nostri lettori?
DV: Certamente. Ero interessato alla sfida di usare campionatori, che erano maggiormente associati alle idee di citazione, frammentazione all’interno di un contesto contemporaneo, per cucirli insieme in un unico mondo “classico”. L’impeto era comunque duplice: a un livello ero entusiasta della sfida tecnica ed ero motivato sul quello narrativo dalla ricchezza del “Malleus Malleficarum” come testo di partenza.
 FG: Sono personalmente molto colpito da “Medea”, perché (è una questione soggettiva) è possibile avere una sensazione concreta di che cosa siano sofferenza e disagio psicologico. Vorrei solo sapere qualcosa di più su questo lavoro, e assolutamente qualcosa in più sulla particolare rappresentazione teatrale di questo classico immortale (“Medea” è un lavoro su commissione).
FG: Sono personalmente molto colpito da “Medea”, perché (è una questione soggettiva) è possibile avere una sensazione concreta di che cosa siano sofferenza e disagio psicologico. Vorrei solo sapere qualcosa di più su questo lavoro, e assolutamente qualcosa in più sulla particolare rappresentazione teatrale di questo classico immortale (“Medea” è un lavoro su commissione).
DV: C’è un bellissimo videoclip, girato da i+t=r per uno dei brani di Medea, che fornisce un’ottima visione dell’estetica di quel mondo: vedendo quel clip si ha un’idea molto più completa e la si ottiene molto più velocemente di quanto potrei fare a parole. Durante le prime fasi della produzione, c’era l’idea di fare un lavoro estremamente sperimentale, motivo per cui ho deciso di basarlo su delle fondamenta tradizionali, armonie occidentali e contrappunto, strumentazioni orchestrali e cori. Con queste premesse, ho potuto permettermi di spingere i timbri del mio lavoro molto più di quanto avrei potuto fare senza. Il risultato finale si è rivelato meno estremo e più vicino a un lavoro teatrale tradizionale, ma direi che funziona bene.
FG: Il tuo penultimo album “Sacred Fury” è pubblicato dalla Fin de Siècle Media. Come hai iniziato a collaborare con Magnus Sundström? Ho anche l’EP “AZ50HD”, dove tu remixi des Esseintes (side project di Sundström) e Magnus remixa E.P.A. (uno dei tuoi tanti progetti): cosa pensi del suo lavoro come The Protagonist e come des Esseintes?
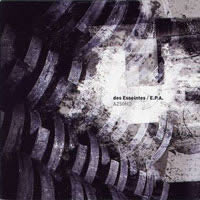 DV: Lavorare con Magnus è grandioso (che sia collaborare artisticamente o con l’etichetta). Quando mi è stato offerto di lavorare all’università, è diventato chiaro che un aspetto della mia vita sarebbe diventato preponderante. Siccome non volevo dare le mie composizioni per il teatro, la danza e i giochi per computer, Dorobo (etichetta personale di Darrin, ndr) è saltata fuori nello stesso tempo al momento giusto e a quello sbagliato. Senza una mia etichetta come canale per le mie uscite, la Fin de Siècle Media mi è sembrata una scelta logica. Magnus ha un senso dell’umorismo simile al mio, una passione simile alla mia per la cultura alta e la cultura bassa, ed ha gusti vicini ai miei per quanto riguarda la musica. Era estremamente sensato pubblicare il mio materiale attraverso qualcuno per il quale avevo così tanto rispetto. Il fatto che si trovasse in Svezia era solo un bonus!
DV: Lavorare con Magnus è grandioso (che sia collaborare artisticamente o con l’etichetta). Quando mi è stato offerto di lavorare all’università, è diventato chiaro che un aspetto della mia vita sarebbe diventato preponderante. Siccome non volevo dare le mie composizioni per il teatro, la danza e i giochi per computer, Dorobo (etichetta personale di Darrin, ndr) è saltata fuori nello stesso tempo al momento giusto e a quello sbagliato. Senza una mia etichetta come canale per le mie uscite, la Fin de Siècle Media mi è sembrata una scelta logica. Magnus ha un senso dell’umorismo simile al mio, una passione simile alla mia per la cultura alta e la cultura bassa, ed ha gusti vicini ai miei per quanto riguarda la musica. Era estremamente sensato pubblicare il mio materiale attraverso qualcuno per il quale avevo così tanto rispetto. Il fatto che si trovasse in Svezia era solo un bonus!
FG: “The Witch Hammer” e “Sacred Fury” sono colonne sonore dell’irrazionalità umana. Cose come superstizione e guerra (forse è meglio dire “la battaglia”) sono strumenti perfetti utilizzati dai governanti di ogni tempo per mantenere tutto com’è. Ti interessa anche rappresentare questo aspetto politico?
DV: Sono di certo molto interessato alla politica, ma tendo ad usarla come un qualcosa di ottuso più che didattico. Mi piace molto l’idea aristotelica di purificare l’anima attraverso la bellezza e il terrore. È interessante chiedersi se questo sia affinare un prospettiva politica (attraverso il registrare la brutalizzazione dell’innocenza da parte del potere) o sia semplicemente attivare un circuito neurologico mediante un’antifona (qualcosa di seducente che ti coinvolge, qualcosa di cattivo che “tasta il tuo polso”).
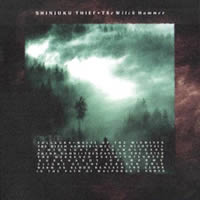 FG: Immagina che io sia uno studente e tu debba darmi dischi — anziché libri — nel tentativo di farmi capire cosa sia la musica elettronica: per favore nomina alcuni “classici immortali”… Non voglio essere bocciato.
FG: Immagina che io sia uno studente e tu debba darmi dischi — anziché libri — nel tentativo di farmi capire cosa sia la musica elettronica: per favore nomina alcuni “classici immortali”… Non voglio essere bocciato.
DV: Potenzialmente questa lista di dischi è più indicativa di alcuni aspetti dell’elettronica, di riassunti di storie, di suoni interessanti nel panorama piuttosto che di una di album che reggerebbero un attento scrutinio ai giorni nostri (sebbene alcuni di questi qui sotto certo lo reggerebbero!)
Depeche Mode — Violator (la quintessenza del pop elettronico)
John Oswald — Plunderphonics
Klaus Schulze — Mirage (elettronica europea classica)
Jean Michel Jarre — Oxygene (vedi sopra)
Brian Eno — Thursday afternoon (l’uso dello studio come strumento)
Ryoji Ikeda — +/-
Bernhard Gunter — Un peu de neige salie
Autechre — Tri repetae
Bernard Parmegiani — De natura sonorum
Michel Chion — Requiem
Giles Gobeil — Les Mechaniques Du Ruptures (strutture elettroacustiche con una gamma sonora industrial)
FM Einheit — Steinzeit (sampling orchestrale)
Line Tjornhoj-Thomsen — Triff (elaborazione elettronica della voce)


