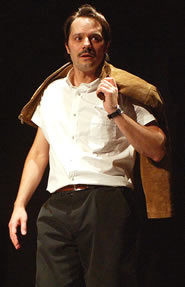 Giorgia Gelsi (GG): Siamo con Sergio Romano, interprete in questi giorni alla Sala Bartoli del Politeama Rossetti di Trieste di uno spettacolo che ha un titolo interessante, A different language. Ce lo racconti in breve citando anche il regista? Il testo è scritto da Renato Gabrielli…
Giorgia Gelsi (GG): Siamo con Sergio Romano, interprete in questi giorni alla Sala Bartoli del Politeama Rossetti di Trieste di uno spettacolo che ha un titolo interessante, A different language. Ce lo racconti in breve citando anche il regista? Il testo è scritto da Renato Gabrielli…
Sergio Romano (SR): La regia è di Graham Eatough, in scena ci siamo io e Selina Boyack, che ora è scappata. Ve lo racconto: un uomo e una donna, solissimi, timidissimi, cercano entrambi l’anima gemella e si rivolgono a un’agenzia per trovarla: vediamo quello che ne viene fuori!
GG: Proprio stringato! Paradossalmente, nell’era di grandissima comunicazione — di cui anche noi siamo qui esempio: questa intervista sarà presente su internet in formato audio, video e testuale — c’è una reale difficoltà di rapportarsi tra esseri umani in carne ed ossa. Questo aspetto emerge chiaramente nel testo.
SR: Riuscire ad entrare in contatto, mettersi in comunicazione, creare armonia: cosa vuol dire comunicazione? La risposta è complessa, credo si tratti più che altro di riuscire ad entrare in armonia con l’ambiente, con quello che ci circonda, con noi stessi… Molto new age! (ride, ndr) Nello spettacolo due persone si rivolgono ad un’agenzia, ad un intermediario, per trovare l’anima gemella attraverso quei siti in cui si può inserire il proprio profilo e quello della persona che si vorrebbe incontrare. Quando ci si relaziona con le altre persone — e anche questa tematica non è nuova, basti pensare a Pirandello — come ci si rappresenta? Quando ci relazioniamo all’ambiente spesso abbiamo difficoltà a farlo in modo totalmente libero (cosa vuol dire poi libero?) manifestando la nostra natura. In questo caso si tratta di un uomo e una donna che cercano l’amore, l’anima gemella o solo del sesso. E da questo emergono delle provocazioni: quanto ci si rappresenta secondo quello che vorremmo essere o quanto secondo quello che un’altra persona desidera? Quanto c’è di reale? Penso che lo spettacolo abbia la pretesa — enorme! — di rappresentare tutto questo, però si ride anche molto…
GG: Ci sono diversi livelli di interpretazione del testo: c’è uno più superficiale e uno più profondo, ma è sicuro che, accanto al lato divertente, c’è anche un lato che fa pensare. Lo spettacolo lascia un finale aperto… Dal tuo punto di vista, è positivo o negativo? Lascia speranza o un grande senso di isolamento?
SR: Non lo so, proprio perché lo spettacolo è realmente aperto, dipende un po’ dai punti di vista. Può essere una speranza, perché questi due ricominciano a parlarsi. Può essere un senso di isolamento, perché continuano nel loro primo approccio fortemente virtuale, cioè mascherandosi il più possibile. Ma non penso debba esserci per forza un giudizio. Quello che penso “freghi” il più delle volte nella vita è la paura: se si riesce a guardare obiettivamente una realtà, proprio questo atteggiamento può permetterci di avere un poca di più apertura e di capire quello che accade. I due protagonisti sono un po’ balordi, e ci si chiede come andrà a finire. Questo è bello perché tira fuori un po’di malinconia, anche in noi stessi… Ma ora non va bene, perché sto raccontando lo spettacolo!

GG: Infatti, fermiamoci e parliamo invece dell’operazione culturale che questo spettacolo rappresenta: una coproduzione tra il teatro di Glasgow “Suspect culture” e il teatro regionale del Friuli Venezia Giulia, il Politeama Rossetti. Com’è stato recepito lo spettacolo a Glasgow e come qui a Trieste, quali differenze hai notato tra il pubblico, considerando anche lo spazio che, come in questo caso della sala Bartoli, è molto ristretto…
SR: Lo spettacolo è stato accolto molto bene, abbiamo debuttato a Glasgow e poi siamo andati a Edimburgo e a Manchester. Così ho notato delle differenze: è normale, come accade qui da noi, si cambia regione e si notano delle variazioni di sensibilità. Loro hanno un’altra abitudine al teatro: cioè fanno molta attenzione ai respiri, perché hanno una tradizione di recitazione diversa. Dipende dal loro modo di essere: non manifestano ciò che pensano e hanno un forte spirito d’osservazione e, anche nei confronti della recitazione, sono più attenti alle sfumature. Noi siamo abituati a recitare nei teatri d’opera e finché ci fai l’opera va bene, ma poi se devi recitare… ti tocca “cantare” lo stesso! Lo spettacolo è stato accolto molto bene anche a Trieste; è presto ancora per dirlo, ma ho una sensazione: le persone qui riescono ad apprezzare anche di più un tipo di scrittura più reale e grottesca. La scrittura di Renato (Gabrielli, l’autore del testo, ndr) è fatta in questo modo: rende da un lato la comicità assurda della vita, ma sottolinea allo stesso tempo una condizione drammatica della realtà. Non ne sono sicuro, ma credo che il pubblico italiano possa apprezzare un poco di più questo aspetto. Gli inglesi lo vivono come “sense of humor”, avendo un senso più cinico della realtà. Comunque il pubblico partecipa molto e ognuno coglie l’aspetto che più lo colpisce.
GG: Sicuramente è uno spettacolo che si basa molto sul ritmo, sia ritmo fisico — come testimonia questa scenografia alle spalle, quasi un vortice — sia ritmo delle parole, cadenzate, tra italiano e inglese. Torniamo invece al tuo percorso personale di attore. Tu sei stato diretto da grandi registi e ti sei “scontrato” anche con importanti opere shakespeariane, l’Otello, tanto per citarne una. Questa esperienza con la drammaturgia contemporanea che cosa ti porta, quali sono le tue aspettative, visto anche il tuo background con i grandi classici?
SR: Posto così il discorso potrebbe apparire un po’ accademico… Il teatro è contemporaneo, è l’adesso: questo può avere mille significati. Il teatro cioè è un gioco: così come ci si diverte a vedere ventidue uomini che corrono dietro a un pallone, perché non si sa dove quel pallone andrà. Anche il teatro deve avere la stessa suspence, deve essere “qui e adesso”. Rispetto alla drammaturgia, io adoro Shakespeare, è meraviglioso e bisogna continuare a recitarlo. Credo però che la nostra cultura sia un po’ troppo accademica, in altre parole poco pragmatica. Il teatro non è un’accademia, ma un posto dove “si fa teatro”. Non lo si fa solo per divertirsi e che cosa sia non si sa: ma secondo me, se lo vedi, lo riconosci. Ci vuole un po’ d’abitudine, consuetudine, bisogna affinare il palato, ma poi puoi dire: “Questo è il teatro”. Io voglio il più possibile recitare drammaturgia contemporanea perché ho bisogno di raccontare il mio tempo, di lavorare coi ragazzi della mia età, anzi più giovani di me! Purtroppo in Italia si è usato per anni questa scusa: “Ma chi è che scrive bene?”. Invece di autori validi ce ne sono, ma a forza di dar loro botte in testa, si sono rivolti da altre parti, hanno scritto per altri settori… C’è stato un atteggiamento culturale sbagliato, intendendo per culturale nulla di “intelligente”, ma di “pratica culturale”, vale a dire il trattare del cosa si fa la mattina! Tra la gente che viene a vedere il nostro spettacolo ci sono molti anziani, persone che non rispecchiano forse l’età dei protagonisti, degli autori, ma che lo apprezzano moltissimo. Tornando alla drammaturgia, è fondamentale capire che il teatro è il presente: lo stesso Shakespeare, recitato in modo noioso, può non trasmetter né vibrazione né partecipazione con la realtà che ci circonda. Da attore, posso pur pronunciare le parole di Shakespeare, ma devo anche riflettere su ciò che accade, a me e anche a chi mi sta intorno; in tal modo riesco a trasmettere qualcosa ai miei simili…
 GG: Andate in tournée dopo questa avventura triestina?
GG: Andate in tournée dopo questa avventura triestina?
SR: Andiamo sicuramente a Firenze il 15 e 16 giugno, al Teatro della Limonaia per l’Intercity Festival… Dopodiché il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il Teatro di Glasgow Suspect Culture si occuperanno di promuovere lo spettacolo per una ripresa autunnale a ottobre e novembre. Speriamo di riuscire a farlo!

