Del degrado culturale, civile e politico italiano Napoli continua ad essere una sorta d’imparziale osservatorio, un inquietante specimen all’ennesima potenza dei mali che affliggono il Paese: ed è per questo che crediamo opportuno scegliere questa città come punto d’avvio per una cursoria analisi della ‘decadenza italiana’ e dei suoi fenomeni tipici — clientelismo, corporativismo, corruzione, politicismo — a partire dal volume di Francesco Barbagallo Napoli fine Novecento. Politici camorristi imprenditori.

«Uno storico, consigliere comunale a Napoli tra il 1987 e il 1993, decide di applicare all’osservatorio civico di cui è testimone diretto gli strumenti della sua professione. E si accorge che gli argomenti della sua indagine disciplinare — gli scandali di fine Ottocento e dei primi del Novecento — scoloriscono drammaticamente di fronte al degrado morale e alle forme abnormi della corruzione contemporanea. Barbagallo rimonta pazientemente una notevole massa documentaria e ne fa scaturire un quadro impressionante: degli oltre 50.000 miliardi erogati al Sud per la ricostruzione dopo il terremoto del 1980, la gran parte è stata dissipata in opere che poco o niente avevano a che fare con le aree terremotate, incrementando piuttosto il giro d’affari di imprese legate alla camorra o agli stessi potenti gruppi economici del Nord (dalla Fiat alle Cooperative), mentre i senzatetto risultavano ancora, alla fine del “decennio d’oro”, il 15 per cento. Questo libro chiama in causa la gran parte del ceto politico napoletano, dai Gava agli Scotti, ai Cirino Pomicino e ai molti altri implicati, facendone emergere le responsabilità e mostrando con precisione di dettagli, come nessun altro libro aveva fatto finora, gli intrecci perversi e le illecite connivenze che hanno stravolto il profilo nobile del meridionalismo di un tempo in un sudismo accattone e deteriore.»
Il libro dello storiografo salernitano rappresenta una disamina lucida e crudele del declino verticale della più grande città del Sud, che, nonostante i vaneggiamenti contemporanei di un fantomatico «Rinascimento napoletano» (ma ‘rina-scimento’ di cosa: camorra? servizî da terzo mondo? criminalità padrona del territorio?…) e sapienti, politicistiche, demagogiche operazioni d’immagine, prosegue inarrestabile: non c’è bisogno dell’oracolo delfico per preconizzare il malinconico, ulteriore allontanamento di Napoli (da sempre e tuttora assestata, per citare gli indici statistici, agli ultimi posti della classifica relativa alla qualità della vita nelle città italiane annualmente stilata dal “Sole-24 ore”) dalle grandi metropoli europee e la sua assimilazione sempre più radicale alle grandi città africane e del Sud del mondo.

La ‘capitale del Mezzogiorno’ appare in effetti sempre più totalmente in mano alla grande criminalità organizzata, mentre lo Stato — polizia e carabinieri in primis — si ritira imbelle di fronte all’aggressività dei clan camorristici, che di tanto in tanto — moderno ‘selvaggio West’ — esplode cospargendo di cadaveri la città, divenuta suo indisturbato campo di battaglia: «È qui il record europeo. […] Illegalità diffusa, tasso di corruzione ancora altissimo. […] Il distretto di corte d’appello napoletano si conferma il più aggredito dalla criminalità organizzata. Sono ben cento i clan camorristici nella provincia di Napoli, ventotto solo nel capoluogo. [..] Cifre da sbalordire, cifre con il pesante fardello di un omicidio al giorno: 365 i morti uccisi nell’anno che si chiude. […] Dice il procuratore generale: “La diffusa illegalità che pervade l’intero territorio, non solo quello metropolitano, il nefasto intreccio tra malaffare e politica durato per troppi anni, il preoccupante tasso di corruzione che ancora inquina tutte le pubbliche amministrazioni, nessuna esclusa e compresa quella giudiziaria, costituiscono un freno per lo sviluppo ordinato della società civile e potrebbero ricevere ben altro contrasto dell’intervento della Giustizia se questo fosse più rapido e funzionale”. Un allarme, che si fa forte delle recenti analisi dell’Istat sulla criminalità in Italia negli ultimi due anni. Si legge in quel documento: “Da un esame dei dati nelle tre regioni a rischio mafioso, si vede che, dietro la crescita del dato nazionale di omicidi compiuti in Italia, c’è solo la Campania, con un clamoroso più 73,8 per cento”.»
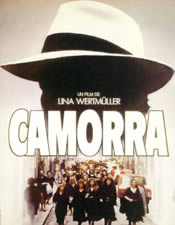 Come ha detto il Procuratore capo di Napoli Agostino Cordova in un’intervista, «Lo Stato, non avendo rimediato all’abbassamento del livello di legalità, ne prende atto e lo formalizza. […] A parte le pallottole vaganti, le rapine, le estorsioni, i taglieggiamenti di varia natura, il dilagare della droga, dell’usura, e senza considerare i folcloristici reati “minori” (e dei minori), pare che solo in un mese, dal 15 dicembre 1996 al 14 gennaio 1997, a titolo esemplificativo, nei territori di Napoli e Caserta siano state uccise 31 persone, ed altre 26 siano state ferite, quasi tutte per fatti di presumibile natura camorristica. Siete proprio voi giornalisti ad enumerare giornalmente gli omicidi che si susseguono, e che avvengono sulle pubbliche vie, tra la folla ed addirittura davanti alle scuole, talché taluno ha paradossalmente suggerito ai cittadini l’uso di giubbotti antiproiettili. […] Quanto al campo della mia attività, sono del parere che risponda ai comuni principi che tanto più grave e diffuso è un fenomeno criminoso, tanto più rigorose debbano essere le leggi e tanto più tempestivi ed efficaci i mecca-nismi per applicarle. Invece, accade esattamente il contrario, della qual cosa saranno soddisfatti coloro che delinquono, o che vivono ai margini od all’ombra dell’illegalità, non certo la maggioranza dei cittadini onesti, a Napoli e nel Paese.»
Come ha detto il Procuratore capo di Napoli Agostino Cordova in un’intervista, «Lo Stato, non avendo rimediato all’abbassamento del livello di legalità, ne prende atto e lo formalizza. […] A parte le pallottole vaganti, le rapine, le estorsioni, i taglieggiamenti di varia natura, il dilagare della droga, dell’usura, e senza considerare i folcloristici reati “minori” (e dei minori), pare che solo in un mese, dal 15 dicembre 1996 al 14 gennaio 1997, a titolo esemplificativo, nei territori di Napoli e Caserta siano state uccise 31 persone, ed altre 26 siano state ferite, quasi tutte per fatti di presumibile natura camorristica. Siete proprio voi giornalisti ad enumerare giornalmente gli omicidi che si susseguono, e che avvengono sulle pubbliche vie, tra la folla ed addirittura davanti alle scuole, talché taluno ha paradossalmente suggerito ai cittadini l’uso di giubbotti antiproiettili. […] Quanto al campo della mia attività, sono del parere che risponda ai comuni principi che tanto più grave e diffuso è un fenomeno criminoso, tanto più rigorose debbano essere le leggi e tanto più tempestivi ed efficaci i mecca-nismi per applicarle. Invece, accade esattamente il contrario, della qual cosa saranno soddisfatti coloro che delinquono, o che vivono ai margini od all’ombra dell’illegalità, non certo la maggioranza dei cittadini onesti, a Napoli e nel Paese.»
Ma è in effetti l’intero Sud in mano al malaffare ed alla grande criminalità organizzata, le cui ramificazioni si estendono in tutto il Paese ed operano in stretto contatto ed intreccio — diretto od indiretto che sia — con la classe dirigente, contentendone, occupandone o proprio espropriandone, non di rado, i luoghi del potere: «Il patrimonio della criminalità organizzata in Italia è di almeno 350mila miliardi; il 30% del commercio può essere ricondotto alle organizazioni mafiose; un quarto dei movimenti bancari hanno origini oscure. Sono le cifre-choc del rapporto ‘96-’97 della Confcommercio sull’invasione criminale dell’economia presentato a Roma dal presidente dell’associazione Billé. Nessuna regione d’Italia è immune: nel Nord-est “sono apparse società venute fuori dal niente”, in Toscana ed Emilia “le aziende agricole stanno passando alla mafia russa e ucraina”.»
Insomma, come diceva, col consueto antitaliano italicum acetum Giuseppe Prezzolini, «Non è vero che l’Italia sia un paese disorganizzato. Bisogna intendersi: in Italia la forma naturale di organizzazione è la camorra».


