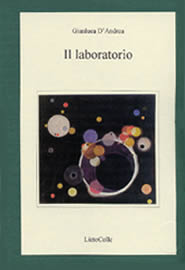 Gianluca D’Andrea dedica a “Un vecchio profeta” la prima sezione de Il laboratorio (Lietocollelibri, Co), ma non è chiaro a chi si riferisca. Indizi, come quel “giocare” assieme di bambini e di frammenti, conducono ad Eraclito e più in generale alla filosofia occidentale, poiché anche qualche “diverso pensiero” o aforisma di Wittgenstein potrebbe far parte del bagaglio dell’autore.
Gianluca D’Andrea dedica a “Un vecchio profeta” la prima sezione de Il laboratorio (Lietocollelibri, Co), ma non è chiaro a chi si riferisca. Indizi, come quel “giocare” assieme di bambini e di frammenti, conducono ad Eraclito e più in generale alla filosofia occidentale, poiché anche qualche “diverso pensiero” o aforisma di Wittgenstein potrebbe far parte del bagaglio dell’autore.
La disponibilità a trattare alcune tematiche parallelamente, quali l’adattamento di un organismo in un contesto mutevole e la scrittura come possibilità di una riproduzione guidata della realtà, porta la poesia a incontrare forma e contenuto con l’ausilio di un “sistema” collaudato che l’artista orienta e da cui si fa orientare essendo fonte di conoscenza e di ascolto ulteriore.
La modalità che l’artista adopera — il suo effetto visibile è quello di farci pensare attraverso una serie di fatti i cui referenti accadono durante l’esecuzione del testo — carezza paradossi e immagini, ma ciò avviene solo nel tentativo di toccare e repentinamente fuggire dalla portata concettuale dei referenti stessi, come ad esempio nel terzo testo che l’autore ha sistemato nella seconda sezione del libro, “Il prigioniero”: “Provando a modellare con l’aiuto/della penna una riga dopo l’altra,/ne sgorga l’illusione di un bisogno;/ma l’origine del filo d’inchiostro/è la sua fine istantanea.[…]”).
In pratica nel fuggire, prendere le distanze dall’opera che il poeta si è prefigurato, questo “tentativo di scrittura” crea conoscenza e significato (o autoconoscenza) all’interno del sistema di versi.
È da sottolineare anche l’uso di terminologie rubate in ambiti scientifici (esosfera, fotosfera, rifrazione[…]) e a scienze “positive” come la psicologia (psicometrici, soglia[…]) che trascina il lettore in cornici dipinte da una poesia mediata da visioni “antropologiche” e “evoluzionistiche”:
Fillotassi
ai piedi delle catene i bambini masticando
estraggono residui psicometrici.
Fiori rossi cingevano cataste sconfinate
reperti e filigrane
nell’espansione del cosmo
colmo di rami
* * *
la libertà è dei bambini sulla pelle
nell’odore dei loro brevi sudori
* * *
i genitori si sono persi
nel vuoto degli avi
i figli sono semi immensi introiettati
e il vuoto è un pericolo eterno.
I figli dei figli sono mostri a sei facce
asciutti esaedri nominali
i dissettori proiettati
* * *
i figli osservano i capelli delle
donne, distese inesplorate avvolti
flutti. Non temono, chiedono la
carezza; alcuni affondano altri sono
inebriati
* * *
mille vite ci separano
micrometriche distanze ha spalancato
l’esperienza. Il contatto rabbrividisce
e comunica distanze siderali
aggrappandosi le copre
* * *
i ragazzi schiantano frugando rughe
le labbra spalancate, le morbide.
Fluttuano le curve.
Nei servi recessi recludono lo sperma
e le ragazze violano i fondali
mentre l’ombra reboante
la salamandra cosparge
di fuscelli
* * *
ad ogni passo una striscia
il nero capovolto
* * *
i ragni ammortizzano il vuoto
delle giovani case
“Questo cosmo, lo stesso per tutti, né un dio né un uomo lo fece; era sempre, è, sarà fuoco eterno che a misura divampa e a misura si estingue”: così osservava Eraclito (I frammenti, fr. 30).
“Il corpo multiforme s’adattava/piuma di fenice/alle onde del cosmo ” dice D’Andrea, e il cosmo non può non aderire ad una realtà che fu, è, sempre sarà nella trasformazione.
Inoltre “L’evo di vita è un bimbo che gioca, che mette qua e là le pedine, il potere sovrano del bimbo” (Eraclito, I frammenti, fr. 52).

Il poeta è conscio di alcune permute di questo gioco di vita e di scrittura nel tempo in cui scorre la finzione, indipendentemente dagli elementi del linguaggio che usa, foglie di una specie d’albero i cui i significati in linea di massima avrebbero già una disposizione. Difatti i testi presentano una formatività riconoscibile e l’autore è in grado di creare differenze in relazione all’impronta globale che si aspetta dall’opera compiuta, quasi scindendosi tra il passato, il presente e il futuro dell’opera stessa per poi raccoglierne lo spirito.
Inoltre, conservando la possibilità di ridefinire le figure e i corpi animati tra le poesie della raccolta, organizza la prima sezione “Un vecchio profeta” e, allo stesso tempo, predispone da artigiano quella vernice di frammenti evocativi che riutilizzerà successivamente nella seconda sezione “Il Prigioniero” sullo sfondo di una nitida narrazione: qui sono le descrizioni di azioni quali “Manoscrivere e miniare lo spirito/ricopiare attraverso una scrittura ” a farsi finzione e a fungere da carcere o da guardia carceraria, o impronta riconoscibile, della scrittura:
Provando a modellare con l’aiuto
della penna una riga dopo l’altra,
ne sgorga l’illusione di un bisogno;
ma l’origine del filo d’inchiostro
è la sua fine istantanea. Raccolta
nella penombra della stanza, vita
di una mano, di una penna e di un foglio…
e l’inchiostro che adesso è questo punto.
Il punto è che ai primordi, cioè nelle bozze, la raccolta del poeta messinese si chiamava Il laboratorio del piccolo artigiano (testi scritti in compagnia di alcune persone che bazzicarono la stanzetta). La seconda sezione era accompagnata da indicazioni rivolte al lettore (“9 poesie di uno scrittore recluso che finge di aver accettato la stessa reclusione e invece progetta l’evasione[…] ”) eliminate dopo l’editing (“Dalle poesie che seguono si avverte che lo scrittore è libero, anche se si porta dietro lo stile utilizzato in prigione, la sua gabbia formale. ”) o sostituite da più laconici “Il prigioniero è libero anche nei difetti della gabbia formale ”.
In principio, la terza sezione “Il bambino geometrico e le citazioni” invitava i lettori a leggere un “cartello” in tutto e per tutto indispensabile per la comprensione della più sperimentale tra le parti del libro: “Alcune poesie meccaniche di un bambino geometrico che non ne può più della sua stessa geometria. All’artigiano spiegò di aver inserito delle citazioni dal senso completamente opposto rispetto ai testi proposti. Proprio queste citazioni rappresentano il vero messaggio delle poesie; tutto ciò a dimostrazione dell’impossibilità manifestata dal bambino di uscire dalla propria mappatura mentale”. Qui la discussione filosofica, cioè che “la realtà sia un’idea valicabile ”, fa pensare al fatto che, ad esempio, ci muoviamo banalmente in uno spazio tridimensionale e per un dato tempo; ma questa è solamente un’idea di realtà — ve ne sono altre di alta fattura, a dire il vero — che possiamo attraversare e superare. Perché? Perché è un’idea di realtà.
 Prendendo spunto da Jünger in una delle citazioni proposte, questa materia o idea di realtà che ci costruiamo ha a che fare con l’ineffabile appunto perché si afferra nei limiti della nostra percezione, perché continuamente, e senza il nostro aiuto, si fa oltre la finzione del concetto che abbiamo creato, si fa oltre ciò che assumiamo come limite o come legge da altri.
Prendendo spunto da Jünger in una delle citazioni proposte, questa materia o idea di realtà che ci costruiamo ha a che fare con l’ineffabile appunto perché si afferra nei limiti della nostra percezione, perché continuamente, e senza il nostro aiuto, si fa oltre la finzione del concetto che abbiamo creato, si fa oltre ciò che assumiamo come limite o come legge da altri.
Ai limiti del nostro percorso di conoscenza possiamo osservare solo delle indicazioni: il percorso è da fare.
Oltre, la terra selvaggia dentro di noi, è l’amore.
Vengono sottratte indicazioni nella quarta sezione “Il padre separato e suo figlio” (“3 poesie che un papà, separato dalla moglie, dedica al figlio di sette anni. ”) e nella quinta, che riprende con “manualità” sensuale i temi precedenti anche grazie al titolo trasgressivo “L’amante e l’hard-core”: “Un ragazzo, che ama l’hard-core, dedica queste poesie alla sua ragazza (tranne la prima, mi dice, che invece rappresenta una riflessione sul paesaggio urbano contemporaneo).”
Anche la sesta e ultima sezione “Il poemetto di un uomo di mezza età” presentava un’indicazione — eliminata; ed è stato abbandonato nelle bozze il “Breve poemetto eroticomico in endecasillabi sciolti” che si discostava dall’atmosfera delle altre sezioni per il suo contenuto pornografico-comico che irrideva “il verso della nostra tradizione ”…
Nella “Prefazione” Giovanna Frene afferma: “La singolarità di questo libro di poesie, che lo avvicina nello spirito a certe sperimentazioni della prosa italiana, è patente fin dal titolo: il lettore viene portato dentro un mondo reale, quello poetico (che riproduce il reale), dove di fatto ogni finzione è concessa — è di laboratorio che si parla […] ”.
Mi piacerebbe ci spingessimo, per un attimo, oltre il limite del laboratorio e lo facessimo in modo chiaro: le indicazioni, elementi che avrebbero aiutato un “ipotetico ma quasi mai assente” lettore ad entrare nella sperimentazione e nei personaggi di questo strano “CERN” o “SINCROTRONE” di scrittura, sono state sottratte.
Il fatto è che non si è creato qualcosa di meglio o di peggio — i testi sono quelli -, si è solo voluta erodere la possibilità di interpretare la sperimentazione.
Anche se “Uccidere la morte non comporta/la rottura del cerchio ”, uccidere la cornice in cui si iscrivono alcune teorie — e la stessa formatività dell’artista — comporta delle responsabilità, ma nei confronti di chi?
Innanzitutto il lettore di poesia non è rappresentabile con un diagramma, e le sue preferenze spaziano, sono differenziate. Se potessi utilizzare la carta velina per rappresentare il rapporto tra lettore e poeti, la taglierei a fili sottili e la farei ondeggiare, osservando il movimento delle differenze tra questi fili di poesia tra noi e gli artisti, come un tappeto dove il “contatto è una carezza ” e i venti sulla bocca sono tanti.
L’impressione è che questo modo di procedere nell’editing, nel contemporaneo della nostra produzione poetica, svuoti la poesia dell’intenzionalità, del vento e dell’ideologia dell’artista.
Che sia un difetto dell’ambiente italiano, incapace di re-inventare la nozione di poesia perché aderente ad una mentalità obsoleta, chiusa, retrograda, impaurita e inefficace nella comunicazione con il pubblico, è evidente.
Sottrarre il supporto ad un’opera senza alcuna motivazione, ridurre la possibilità di interpretazione corretta di un fare, questo impaurire delle eccedenze di senso, incanala i tentativi dei poeti sui binari dell’oblio.
I risultati di questa ricerca scientifica, di questa recensione?
Forse li potrà conoscere l’autore, chi ne ha curato la prefazione, il recensore, e qualche altro addetto, poeta.
Le alternative per una comunicazione, per innovare l’opera?
Una prosa-collante preparatoria ai testi e tra i testi, una discussione filosofica e una ricostruzione ulteriore dell’opera dall’analisi dei suoi “veicoli” o referenti, una quadratura sulle aperture di significato, sugli intrecci, sui nodi che scioglierà il lettore, questi sono in prospettiva elementi per la nuova poesia.
D’Andrea avrebbe potuto riprodurre il “sistema che sfugge al sistema” a diversi livelli, ed era quello che stava tentando di fare nelle cornici introduttive alle sezioni, la geometria che non ne può più della geometria, ma tutto questo è stato cancellato.
Abbiamo assistito all’oscuramento nell’editing di quella contaminazione tra prosa e poesia che solo ampliata — fatica che a mio dire si sarebbe concessa pure qualche anno — avrebbe creato possibilità interpretative, apertura e comunicazione e sperimentazione interessantissima.
Questo perché una buona teoria “editoriale” dovrebbe anche prepararsi ad accettare le eccedenze di senso, vagliando la possibilità che “dati” o “fatti” non rientrino più nelle modalità di queste sclerotiche operazioni editoriali di oggi.
Chi bazzica i laboratori dovrebbe saperlo.

