 Tiziana Carpinelli (TC): In occasione di Sguardo meticcio, la prima edizione del Festival di Letteratura della Migrazione organizzato a Monfalcone, ci troviamo a tu per tu con Clementina Sandra Ammendola, poetessa, scrittrice e sociologa. Quale aspetto di questa manifestazione le è parso particolarmente rilevante?
Tiziana Carpinelli (TC): In occasione di Sguardo meticcio, la prima edizione del Festival di Letteratura della Migrazione organizzato a Monfalcone, ci troviamo a tu per tu con Clementina Sandra Ammendola, poetessa, scrittrice e sociologa. Quale aspetto di questa manifestazione le è parso particolarmente rilevante?
Clementina Sandra Ammendola (CSA): Senza dubbio la riflessione sul tema della contaminazione. Si parla spesso di costumi, linguaggi, realtà contaminate e altrettanto spesso se ne parla in maniera superficiale, raffrontando immagini dell’altro che sono in realtà frutto di stereotipi e luoghi comuni. Il dibattito di stasera, in questo senso, rappresenta un’importante apertura nei confronti di un mondo che è parallelo alla vita di chi migrante non è.
TC: Quali cose, per sua esperienza, ha reperito lungo la strada della migrazione?
CSA: Cosa c’è lungo le vie della migrazione? Forse un confine non sempre chiaro tra il qui, il noi e il voi. Il migrante si sposta dal suo centro esistenziale verso l’ignoto, l’esterno, rimanendo tuttavia sempre legato da un sottile ma tenace raggio al proprio centro.
Ha senso, qui, oggi, chiederci: quali sono i legami che non si spezzano mai? Quali quelli che guidano i fili della narrazione? Chi è l’altro, ma soprattutto, dove si colloca?
Lungo la via della migrazione ci sono molte storie. La mia è quella di un’immigrata di ritorno: sono nata in Argentina da padre italiano e sono dovuta venire qui per la difficile situazione in cui versava il mio paese d’origine. In Italia ho vissuto una sorta di clandestinità: pur avendo tutti i documenti in regola (non sufficienti però ad ottenere il riconoscimento dei titoli di studio o della patente), quando andavo a rinnovare la carta d’identità mi sentivo dire che probabilmente mi sbagliavo e che dovevo richiedere il permesso di soggiorno, per il mio marcato accento argentino.
Questo è un episodio tra i tanti, un episodio che tuttavia acuisce ancor più l’inevitabile senso di sradicamento che tutti noi migranti patiamo nel momento in cui partiamo verso l’ignoto.
Cosa siamo? Siamo forzati a tornare alle nostre origini per le contingenze della realtà. La memoria è il punto fermo nel paese d’arrivo e la speranza è sempre quella del ritorno.
Per chi resta, invece, l’auspicio è di partecipare ad uno spazio pubblico in cui nessuno abbia privilegi o esclusività. Non tutti sono così fortunati.
TC: So che proprio in Italia, a Venezia, lei ha conseguito il master sull’immigrazione: in quanto esperta sull’argomento, quali sono i meccanismi che dovrebbero essere messi in atto in Italia per sanare una situazione, quella della migrazione appunto, che pare sempre più aver perso il controllo?
CSA: Innanzitutto è una situazione che si deve affrontare concretamente. Non solo: è una situazione che si deve affrontare globalmente.
In Italia si registra una forte presenza migratoria, e per questo non si può ignorare il fenomeno. Di ricette miracolose non ve ne sono: bisogna fare attenzione a certe politiche, come a quelle degli italiani di ritorno. Ho citato prima le difficoltà che ho avuto per affermare i miei diritti legali, ma va tenuto conto che si trattava comunque di una situazione “privilegiata” perché mio padre era italiano — ad esser precisi, un italiano del sud — e pertanto le pratiche burocratiche risultavano relativamente agevolate. Esistono però altre realtà.
Chi sceglie di abbandonare l’Argentina, ad esempio, il Brasile o il Venezuela, non decide di venire in Italia per un’affinità con le proprie origini, sceglie questa destinazione perché costretto; e questa è l’unica possibilità che ha a sua disposizione. Si è tentati da un avvenire migliore, da progetti che promettono di tutto, dal lavoro all’abitazione: quando si arriva qui, ci si accorge che non è proprio così.
Intanto, nonostante i propri titoli di studio (una o due lauree), si trovano impieghi presso fabbriche isolate in mezzo alla campagna, e non compiti in grandi città con opportunità diverse e adatte alle proprie specialità. Le persone che sono in procinto di andarsene dal proprio paese d’origine dovrebbero essere avvisate sulla realtà d’arrivo e dovrebbero esserci degli accorgimenti maggiori. Invece qui si trovano a dover cominciare da capo tutto e soprattutto dal niente, con un lavoro che soddisfa solo la disperazione del primo momento.

La frustrazione rimane e questo può implicare più problematiche: accade che si lasci quel lavoro per entrare nel mercato non riconosciuto, ovvero il lavoro nero, con tutti gli aspetti tragici che esso comporta. Qui deve necessariamente intervenire il legislatore, per arginare la piaga del lavoro nero con l’indispensabile riconoscimento dell’istruzione conseguita nel paese di origine e impedendo così l’accettazione di lavori illegali o sottopagati.
TC: Quindi, un’attenzione particolare alla documentazione e all’attestazione di status legittimi è il punto di partenza?
CSA: Sì, ci deve essere una particolare attenzione per la documentazione: nel mio caso, con una parentela di primo grado, ho avuto una facilità relativa a reperire l’infinito numero di atti e dichiarazioni ch’erano necessarie, ma ora, per le nuove generazioni, si parla di reperire documenti di nonni o bisavoli, il che non è altrettanto fattibile.
TC: Le riciclo una domanda che lei stessa, in un suo saggio, ha rivolto provocatoriamente ai lettori: interculturalità della lingua o lingua interculturale?
CSA: Quel testo lì era effettivamente molto provocatorio perché si ponevano una serie di domande emblematiche. Credo che l’interculturalità sia un concetto — e poi magari saranno gli studiosi di linguistica ad analizzare il fenomeno meglio di me — molto più ampio rispetto a quello di multiculturalità.
La multiculturalità prevede un centro, mentre l’interculturalità, per come la vedo io, è più un flusso, uno spostamento continuo di esperienze, culture e lingue; soprattutto lingue che si contaminano. E questo lo posso dire proprio in quanto argentina, perché la mia stessa lingua d’origine è mutuata dallo spagnolo e si è modificata all’arrivo dagli italiani, verso i primi anni del novecento.
L’interculturalità è l’apertura della lingua e dell’esperienza ed è una sfida positiva che deve essere affrontata.
Non basta promuovere corsi di italiano per stranieri, quando questi — gestiti da certi enti piuttosto che da altri — raccolgono in realtà persone che hanno radici linguistiche totalmente difformi l’una dall’altra: voglio dire, un cinese non ha le stesse difficoltà ad imparare l’italiano rispetto ad un russo o ad un senegalese.
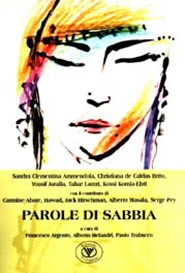 TC: Un’ultima domanda: oltre ad essere sociologa e scrittrice, lei è anche poetessa, quale lingua parla la sua poesia?
TC: Un’ultima domanda: oltre ad essere sociologa e scrittrice, lei è anche poetessa, quale lingua parla la sua poesia?
CSA: La mia poesia esercita il linguaggio della ribellione: i testi nascono da momenti di rabbia civile.
Anche la poesia con cui ho ottenuto riconoscimenti ad un concorso, nasce in realtà dopo l’ennesima sanatoria che era stata fatta in Italia. Io non ne ero direttamente interessata o coinvolta, appunto perché in possesso dei documenti, ma il bisogno di esternare il mio pensiero in merito ha fatto nascere quella poesia; un’altra è nata dopo aver sentito che un ragazzo di Mestre, nel 2000, si era suicidato perché colto in compagnia di una prostituta, non so se ti ricordi di quel fatto e di tutto il dibattito normativo che ne era scaturito…
In definitiva, la mia è una poesia che appartiene a molte culture, ma soprattutto è una poesia che appartiene alla cultura della giustizia.



