Tutti noi abbiamo sotto gli occhi le vicende di questi mesi, che, trattandosi ufficialmente di “guerriglia”, possiamo definire mediamente belliche. Spero vivamente, invece, che non vi sia stata da parte vostra l’urgenza di soddisfare la curiosità di assistere in video all’agonia del povero Nick Berg; so – ne ho sentito e ne ho letto – di qualcuno che se ne è pentito.
È qui che vorrei iniziare la mia riflessione, che non vuole collocarsi sull’onda emotiva del fatto né sollecitare riflessioni politiche di sorta, se non circostanziate a quanto può implicitamente emergere da alcuni spunti: nella mediatizzazione del conflitto, in una vicenda che ripercorre la continuità del suo apice spettacolare dell’11 settembre, e che forse trova le proprie origini televisive nella prima guerra del Golfo, quando la CNN divenne emittente di primo piano e le scie luminose degli SCUD (sempre le stesse, e lo sapevamo, ma era bello far finta di nulla) ci mandavano, noi piccoli ipocriti, all’assalto dei supermercati.

Da una parte la spettacolarizzazione, ove non – spero si colga la sfumatura – la ricerca della spettacolarità; dall’altra la crudezza della diretta, delle condizioni di ripresa precarie, della devastazione, dell’ambiente spoglio. Elementi che si compenetrano a sfumarne i confini, e a suscitare quesiti che nella circostanza i più avranno lasciato insoluti rinunciando a cercare la decapitazione filmata. Interrogativi che tuttavia ritengo connaturati ad un contesto mediatico che è punto di riferimento e insieme filtro, interpretazione e fonte di sospetto, già in quanto linguaggio prima ancora che eventuale esplicita manipolazione.
Alla fine cosa chiediamo? A mio avviso, o questa se non altro è stata la mia domanda sotto gli strati più superficiali di morbosità, fino a che punto siamo in grado non già di distinguere la realtà dal plagio e dalla ricostruzione (è una vita umana troncata in modo barbaro, non un ponte bombardato “per errore”), ma quanto abbiamo codificato i nostri tabù visivi. In quale misura, cioè, l’assuefazione alla crudezza di un’immagine è correlata ad uno spostamento del confine del visibile, in termini normativi oltre che di possibilità. Quasi avessimo scordato il disagio di fronte ad immagini di dolore, quasi temessimo di non essere più in grado di provare sconcerto, vogliamo andare a scoprire se, al contrario, il primitivo, universale limite di sopportazione è ancora al suo posto, o se i codici della simulazione (o, con maggior gradualità, della mediazione) visiva li hanno relegati all’ambito dell’ordinario, del possibile, del “già visto”. Ed è una domanda che fa paura.
Faccio mia una riflessione a mio avviso molto lucida sulla portata storica di ciò che stiamo vivendo sul piano mediatico; non proviene da testi accademici o di approfondimento né da tribune televisive, bensì da una lettera ad Aldo Grasso sul Corriere:
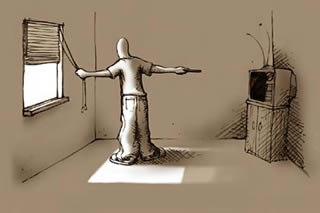
“Forse è proprio il superamento di questo “tabù visivo” il tratto più sconcertante dell’intera vicenda.
Prima di Internet però, o meglio, prima della sinergia digitale fra TV-Internet e Giornali la rappresentazione di questi atti di violenza ha sempre posseduto – o almeno così mi è sembrato – una connotazione lombrosiana e un contesto scenografico che la rendesse “umananamente accettabile”. Chi eseguiva l’atto, chi faceva del male era inequivocabilmente e visivamente cattivo.
[…]
E quello che vediamo è un volto semplice, pulito, quotidiano di una ragazzina [la soldatessa di Abu Grahib, ndr] che, con la massima naturalezza e senza drammaticità, compie un’azione immonda.
Mi chiedo – fra l’altro – se questo significhi la fine di un’epoca: quella in cui l’uomo, usando i mezzi di comunicazione a sua disposizione, poteva permettersi di proiettare sulla Storia un’immagine “narrativa” (e mitologica), degli eventi e per esteso, di sè.”
Riflessione lucida, ribadisco, che afferra una parte del problema: Internet come nuovo “grado zero” della scrittura visiva. La novità della riflessione (la tematica della libertà della Rete è normalmente stata affrontata in altri termini, mentre qui si va oltre, sebbene non al di fuori, l’implicazione ideologica della libertà d’informazione) è tale da apprezzare lo spunto, e contemporaneamente di porsi il problema in altri termini: Internet utilizzata per mostrare la decapitazione di Berg è dirompente poiché aggira il circuito narrativo-scenografico del sistema televisivo così come lo conosciamo, ma in realtà diviene parte – sperimentale, assolutamente nuova, ma non per questo di utilizzo privo di perizia e di calcolo – di un sistema altro, alternativo, che non è proprio del medium ma della volontà di controllo, perché tale è, infine, l’intenzionale spontaneità della diffusione. Proprio perché il mezzo è il meno controllabile per definizione l’onda d’urto è di tale portata; lo sanno gli autori del filmato, lo sa d’altra parte chi utilizza la Rete come terreno di varie forme di attivismo o di situazionismo. Aumentano proporzionalmente i fenomeni realmente spontanei (nascita di comunità, di tendenze, di forme di scrittura, di interazione), ma dall’altra parte c’è chi ne sa sfruttare il sensazionalismo, i meccanismi, le forme anch’esse narrative di attesa, le aspettative.
 Certo è che il dito è puntato sul comune denominatore delle fotografie delle torture e delle testimonianze dell’estremismo islamico: il fatto che, al di là dell’organizzazione (pose, tempi, ritmi, sorridi, ferma che viene mossa), c’è un elemento estraneo, fuori posto, la ragazzina sorridente da una parte, la morte documentata dall’altra. A dimostrarci che sappiamo ancora riflettere, inorridire, prendere coscienza di ciò che ci accade intorno; ma, spero di poter dire, indipendentemente dal fatto che i nostri tabù visivi e in ultima istanza conoscitivi vengano infranti fino in fondo.
Certo è che il dito è puntato sul comune denominatore delle fotografie delle torture e delle testimonianze dell’estremismo islamico: il fatto che, al di là dell’organizzazione (pose, tempi, ritmi, sorridi, ferma che viene mossa), c’è un elemento estraneo, fuori posto, la ragazzina sorridente da una parte, la morte documentata dall’altra. A dimostrarci che sappiamo ancora riflettere, inorridire, prendere coscienza di ciò che ci accade intorno; ma, spero di poter dire, indipendentemente dal fatto che i nostri tabù visivi e in ultima istanza conoscitivi vengano infranti fino in fondo.
Il riserbo che in linea di massima i media si sono autoimposti relativamente all’assassinio di Berg si dovrebbe collocare a mio avviso in questa scia; si può dibattere e giungere a determinate conclusioni al di là del fatto che una testa mozzata venga mostrata per par condicio o che l’urlo sia reso udibile. Vorrei astenermi da considerazioni di merito, ma alla fine la polemica coinvolge Feltri, Ferrara e il TG5. Con patetiche rivendicazioni (Ferrara a “Batti e ribatti”, Feltri a “Porta a porta”) relative al dovere di mostrare, perché chi non mostra si renderebbe implicitamente colpevole di una certa condiscendenza nei confronti dell’estremismo arabo.
Chi era chiamato a rispondere non si è francamente rivelato all’altezza: incalzato da Feltri, il presidente dell’Ordine dei giornalisti lombardo Franco Abruzzo sulla definizione di immagini raccapriccianti, e un rappresentante del centro-sinistra, in evidente imbarazzo, che tenta di cavarsela con il già sentito “non mi piace fare la conta dell’orrore”. Che in teoria è vero, ma non sposta il problema: perché nessuno ha detto ai due direttori che è diversa la funzione delle immagini incriminate, che è differente il loro uso. Se mi dici che i miliziani hanno decapitato un uomo e ne hanno tratto un filmato ci credo, e trovo la cosa abominevole; il contenuto informativo non cambia, ciò che so è sufficiente, vedere oltre non è necessario. Ma sfido qualunque occidentale, per quanto ormai lo scontro di ideologie contrapposte sia fortissimo in seno alla nostra società, a prendere per vera al primo colpo senza vedere le foto la notizia di torture nelle carceri irachene senza che si insinui il dubbio della propaganda destabilizzatrice; vorrei capire a quanti, prima delle dimissioni del direttore del Daily Mirror, sia bastata la controffensiva di Tony Blair sulla falsità delle foto. A più d’uno, ne sono convinto. È il nostro modo di condurre una parte delle operazioni, è la serie di implicazioni sulle motivazioni stesse del nostro agire, è la funzione testimoniale, è il richiamo alle coscienze a costituire il significato ultimo di quelle fotografie, al di là del ritratto di soldati e detenuti. Il finale di un’esecuzione è solo sadismo. Ed è questo quello che un giornalista di mestiere dovrebbe capire.
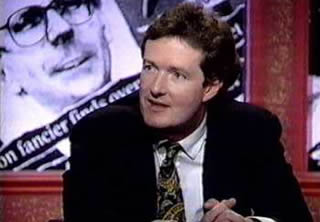
Perché la domanda comune – cosa dobbiamo attenderci da questi nuovi codici visivi, e quindi come utilizzarli, dal punto di vista di chi crea informazione – proviene da presupposti diametralmente differenti, da percezioni opposte dell’interpretazione e dei limiti del visibile.


