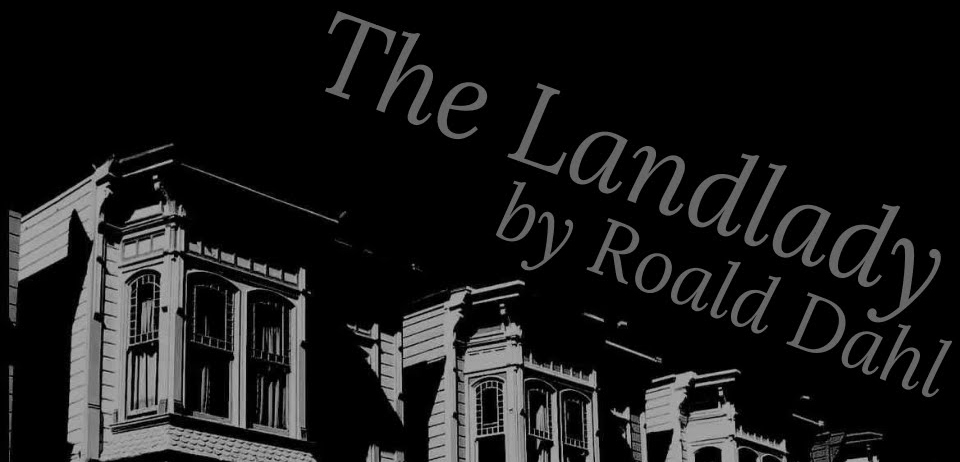La formatività della poesia di Pietro Pancamo si scopre a partire dalla riflessione filosofica dell’autore, che pare si motivi costantemente nella possibilità, che ha ogni uomo, di riconoscere e di riconoscersi in un pensiero “altro” da quello prettamente soggettivo.
La formatività della poesia di Pietro Pancamo si scopre a partire dalla riflessione filosofica dell’autore, che pare si motivi costantemente nella possibilità, che ha ogni uomo, di riconoscere e di riconoscersi in un pensiero “altro” da quello prettamente soggettivo.
Infatti Pancamo forma l’opera avanzando nell’altro da sé, con un profondissimo distacco da qualsiasi credo, pure quello privato che come individuo potrebbe astrarre dalla propria esistenza. Questo atteggiamento è tanto radicato che dà vita a due diverse e parallele produzioni: la prima verte sull’analisi dei sentimenti umani, privilegiando un contesto di immagini e di rimandi sensuali; la seconda invece rischia l’immaginazione attraversando toni sarcastici, espediente che risulta efficace quando il poeta inserisce, come se dovesse trattare gli argomenti in un saggio, contesti di oggetti, pensieri, comportamenti o sentimenti, confondendoli e sospendendoli tra realtà e finzione scenica, come nella poesia “Trattatello” (qui il poeta inietta il virus dell’irrazionalità in un contesto “scientifico”: sempre prendendo in esame la vita nella sua interezza, l’autore ricerca i fatti, l’altro da sé, la verità oggettiva, trasformando i versi per quella che pare essere una critica feroce al materialismo e al positivismo — a dire il vero con una certa austerità e con poca ironia già nel 1700, periodo in cui si tendeva ad accogliere nell’ambito dell’esercizio poetico argomenti scientifici o pseudoscientifici, poeti come un Francesco Algarotti, che intrecciava cultura e metodo scientifico, o un Giuseppe Colpani, che voleva rendere accessibili le tesi del Beccaria e del Verri ad un pubblico femminile, avevano tentato con esiti differenti di dare vita ad una poesia “scientifica”).
Oltre le linee rintracciate tra i testi, in generale il fare di Pietro Pancamo è responsabile, durante l’esecuzione dell’opera o se vogliamo semplicemente durante la lettura, di uno spostamento sull’asse della nostra interpretazione e analisi, cioè guida il lettore e ne calibra l’ottica grazie a versi che, parallelamente alla comunicazione di concetti, proiettano ombre, luci, forme e colori su uno sfondo, che è la ricerca di senso, la ricerca di un nesso con l’esistenza estesa a mondo nel prima, nel qui e ora, nel dopo il nostro esserci materialmente.
Leggendo infatti, si ha la sensazione dell’esistenza di un “oltre” di emozioni che hanno esistenza per noi in un mondo “ulteriore” o di pensieri che presto accadranno nel conscio.
Anche i versi giocano sul contrasto tra ciò che possiamo vedere e ciò che possiamo percepire di un “oltre-io” che preme per farsi ascoltare.
Il poeta, alla ricerca della verità e alla ricerca di un concetto che possa esserne mezzo, scruta la realtà e la vive a livello di sistemi diversi, a partire dalle relazioni che l’uomo intreccia con la natura delle cose, con la natura dei propri sentimenti, quindi con il complesso, intenso ed interconnesso vivere della comunità umana. Si giunge all’immagine di un individuo che vive nella società e si relaziona a questo concetto ad un altro livello, quasi reagendo con essa, come se si trovasse al cospetto del gendarme di un confine che difficilmente si potrebbe valicare; ma questo individuo grazie all’ispirazione invece, tra i frammenti di senso, passa la linea scavalcandola, elevando il concetto stesso della poesia a possibilità e speranza.
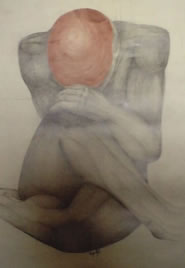 La fase di preparazione e di raccoglimento prima e durante la creazione forniscono gli indizi grazie ai quali l’artista poi giungerà all’opera compiuta, operando sulle relazioni che i concetti trovati attivano nello scrivere, formando alle volte una rete perfetta, che si fa dolce grazie a versi capaci di comunicare esattamente il pensiero, le meditazioni.
La fase di preparazione e di raccoglimento prima e durante la creazione forniscono gli indizi grazie ai quali l’artista poi giungerà all’opera compiuta, operando sulle relazioni che i concetti trovati attivano nello scrivere, formando alle volte una rete perfetta, che si fa dolce grazie a versi capaci di comunicare esattamente il pensiero, le meditazioni.
Così, cercando di intercettare l’intenzionalità, l’autore fa la propria scrittura drammatica o sarcastica sotto la costante incudine della finitezza dell’esistenza umana, l’oscuro vuoto di senso “finale”, che si presenta come muro e necessità di squarcio, di crepa.
La finitezza ed il vuoto di senso si ritrovano nei minimi gesti descritti dal poeta, che poi sono mani che affondano con leggerezza nel mistero, nel non conoscibile, nell’incompiuto e nell’ancora da farsi, e fanno la poesia; si ritrovano anche nella dura analisi in versi di quel concetto “caro” al poeta, cioè il silenzio, vissuto a tratti come malattia sociale, isolamento in cui pare cadere l’individuo, come se altri lo costringessero ad operarsi da solo, ad adoperarsi nella propria follia, e fare poesia.
Nel vivere gli aspetti di questa riflessione che ci porta a meditare dentro e fuori di noi, facendoci scoprire nuovi limiti e contesti per lo più visionari od inconsci (in una poesia — Delusione — il sogno viene descritto come un conservante, un additivo, che rimoderna speranze ed ambizioni), Pietro Pancamo materializza il verso attraverso accadimenti surreali (“E quando l’incubo arriva/il nulla esce dal suo fuori”); lavorando quindi sulle relazioni intrecciate precedentemente, il contesto iniziale e gli accadimenti portano, spesso nel finale, al concetto a cui il poeta è giunto.
O almeno a noi è parso di giungere a ciò che era stato preparato.
Filosofia
Parole e frasi sono gli intercalari del silenzio
che smette, ogni tanto,
di pronunciare il vuoto.
Allora qualche indizio di materia
deforma l’aria,
descrivendo le pause del nulla
prima che il silenzio
si richiuda.
(Le mani s’infrangono
contro un gesto incompiuto)

Danzai
Danzai nelle viscere di un sentimento
all’ombra de’ tuoi occhi.
Poi l’amore s’irradiò in rivoli di tempo.
“Che sia la vita!” — urlava il nostro dio
(o soltanto noi).
Ma si sbagliò (o soltanto noi sbagliammo
perché non c’era
null’altro da fare) e
fu il tempo
(o continuò…)
Occhi e geometria
Diametri di pioggia
attraversano il mio sogno.
Il silenzio
è un pergolato di nubi
che stringe a sé lo sguardo.
Sguardo innamorato del sole,
vorresti che quel bulbo giallognolo
fosse un occhio, forse il tuo!
Invece è solo
una geometria di fuoco…
Sequenza
Per il nonno, si sa,
la giornata è divisa
nel crepuscolo della sera
(la notte)
nel crepuscolo del mattino
(il pomeriggio)
e nel crepuscolo della notte
(l’alba).
Uno: si stiracchia
azzuffandosi con l’aria
e s’afferra a quella luce
che sbrodola tra le persiane;
Due: lo sguardo cascante
e i capelli sgangherati dal sonno,
striscia qualche passo
fino allo specchio;
Tre: guarda la sua immagine
che trafigge il vetro
e da questo momento
vive le sue ore
come un riflesso bendato di carne;
Quattro: mi saluta con parole vitree;
Cinque: sradica i passi
fino alla sedia,
spiegazza il corpo sullo schienale
gualcendo le ginocchia
contro il muro.
Posa le mani, come due tele di ragno,
sul davanzale
e sta vicino alla finestra,
tanto vicino, quasi annusasse il vetro.

Trattatello
PREFAZIONE:
le parole seguenti
sono un fango di cellule nervose,
tenute insieme dal silenzio.
Il silenzio è un’isteria di solitudine
che genera e accumula:
prodotti temporali,
energie cinetiche,
reazioni di gesti a catena.
I sogni, inseriti nella rassegnazione
come in un programma di noia pianificata,
sono gli arti di questo silenzio;
o, se preferiamo,
gli organuli ciechi del silenzio
che lavorano a tastoni
dentro il suo liquido citoplasmico.
Il silenzio può anche essere
la cellula monocorde
di un sentimento spaventato,
di un amore rappreso,
di un guanto scucito:
in tal caso
trasforma la solitudine
nella raggiera cerimoniosa
d’una nausea che procede,
maestosa,
con moto uniformemente accelerato.
(Si registra un’accelerazione a sbalzi
solo quando
un’effervescente disperazione
s’intromette con scatti sismici
a deviare il corso
dell’accelerazione stessa).
Per concludere,
l’evoluzione della nausea
può secernere un vuoto,
avente più o meno
le caratteristiche della morte;
o germogliare per gemmazione
quella strana forma di vita
identificata col nome di indifferenza,
la quale risulta essere (da approfondite supposizioni)
il chiasmo di paura e odio.
POSTFAZIONE:
le parole precedenti
sono un fango di cellule nervose,
tenute insieme dal silenzio.
Ogni allusione
a sentimenti e/o fatti reali
è voluta
silenziosamente.