 Matteo Danieli: Nelle tue poesie affronti il tema delle relazioni; in tutti i sensi, relazioni le esperienze delle persone, le esperienze nel mondo. Come possiamo amare? Come ama Milo De Angelis?
Matteo Danieli: Nelle tue poesie affronti il tema delle relazioni; in tutti i sensi, relazioni le esperienze delle persone, le esperienze nel mondo. Come possiamo amare? Come ama Milo De Angelis?
Milo De Angelis: Amare è continuare il discorso dell’altro, saperlo riprendere nel punto dove finisce, farlo proprio, rilanciarlo, rilanciarlo ancora. Nell’amore si è sempre in tre: tu, io e l’altro, quindi occorre attingere dall’altro per dare a chi ci sta di fronte. Se fosse un rapporto diretto si esaurirebbe subito, se invece c’è un pozzo da cui attingere, l’amore diventa inesauribile.
MD: Entrando dentro la tua scrittura, ci ritroviamo avvolti da elementi simbolici che scopri, evolvi, con un linguaggio semplice ed intenso. Attendi che i simboli si compiano, o li vuoi solamente liberare, far fuggire?
MDA: Attendo che si compiano. Ogni idea di liberazione mi è lontana, mi è estranea, attendo che escano dalla loro oscurità e giungano ad una evidenza nei fatti.
MD: Hai letto Jung?
MDA: Sì, Jung è uno dei miei autori preferiti. Jung e adesso Hillman che sto scoprendo, seppur in ritardo.
MD: E cosa hai letto di Hillman?
MDA: Un saggio su Pan.
MD: Io ho letto l’Anima.
MDA: Sì, sull’anima, sulla vecchiaia, la senectute.
MD: Sembra però che Hillman abbia poi ritrattato il suo pensiero, sia andato in Oriente — metafora del viaggio mistico — e abbia colto tutte le infrastrutture del pensiero che ci portano ad una maturazione razionale troppo elevata, come a dire “forse le cose sono più semplici di quelle che sono”.
MDA: Era forse inevitabile l’incontro di Hillman con Krishnamurti, con Aurobindo, con Nasargatta, i grandi maestri del silenzio.
MD: Ritornando alla tua poesia, come può un lettore sprovveduto accedere a questi simboli? Se la parola è un nodo nel tessuto della poesia, quali possibilità ha di evocare?
MDA: Un lettore deve essere sprovveduto. Per leggere poesia la condizione necessaria, benché non sufficiente, è imparare a disimparare le comodità del contesto, a coglierlo nella sua urgenza, nella sua necessità, a coglierlo senza difese, senza filtri, dimenticando quanto si è imparato. Quello che si è imparato ci deve essere, ma nello sfondo.
MD: Rinasci alla poesia e alla vita attraverso la morte, attraverso l’attimo. Cosa c’è di miracoloso nell’uomo? La sua forza, nel bene e nel male?
MDA: È una domanda poetica che andrebbe proprio ascoltata e lasciata così, sospesa, senza riempirla di risposte affrettate. Il tema della rinascita mi è molto caro, penso che ogni libro sia una rinascita, perché quando un autore scrive un libro deve essere compiuta, ed essere morta, deve essere finita, un’esperienza stilistica ed esistenziale, cioè bisogna vivere un silenzio non tra due note ma di entrambe le note. Il primo libro è lontano, alle spalle, morto, il secondo libro ancora non appare, si rimane lì, col silenzio assoluto.
MD: Siamo a Parco Poesia, manifestazione che ospita molti poeti “giovani”. Cosa vorresti sentire nella poesia e in particolare in quella dei giovani? Cosa ti aspetti?
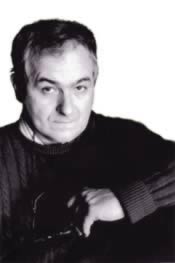 MDA: Sento già qualcosa d’importante, rispetto ai nostri tempi, gli anni ’70. Noi eravamo così chiaramente nemici, pieni di spigoli, di ombre, di antagonismi e di odi per la vita. Da una parte c’è qualcosa di più solitario; il rapporto sembra non essere con i contemporanei ma con i grandi maestri del passato, e dall’altra più fraterno, con questo reticolo di clan, di amicizie. In più ci sono alcuni poeti, citerei Isabella Leardini per prima, ma anche Mencarelli. Voci originali. Le loro poesie mi hanno colpito.
MDA: Sento già qualcosa d’importante, rispetto ai nostri tempi, gli anni ’70. Noi eravamo così chiaramente nemici, pieni di spigoli, di ombre, di antagonismi e di odi per la vita. Da una parte c’è qualcosa di più solitario; il rapporto sembra non essere con i contemporanei ma con i grandi maestri del passato, e dall’altra più fraterno, con questo reticolo di clan, di amicizie. In più ci sono alcuni poeti, citerei Isabella Leardini per prima, ma anche Mencarelli. Voci originali. Le loro poesie mi hanno colpito.
MD: Ho portato una tua poesia, divisa in due parti. Hai voglia di leggerla per Fucine?
MDA: Certo.
T.S.
Ognuno di voi avrà sentito
il morbido sonno, il vortice dolcissimo
che si adagia sul letto
e poi l’albero, la scorza, l’alga
gli occhi non resistono
e i flaconi non sono più minacciosi
nella luce chiaroscura del pomeriggio
mentre mille animali
circondano la lettiga, frenano gli infermieri
il disastro del respiro sempre più assopito
nei vetri zigrinati
dell’autoambulanza, appare
il davanzale di un piano, il tempo
che sprigiona i vivi
e li fa correre con la corrente nelle pupille,
l’attimo dell’offerta, per scintillarle.
E improvvisa, la quiete
della vigna e del pozzo, con la pietra levigata
dividendo la carne
una calma sprofondata dentro il grano
mentre la donna sul prato partorisce
sempre più lentamente,
finché il figlio ritorna nella fecondazione
e prima ancora, nel bacio e nel chiarore
di una camera, il grande specchio,
il desiderio che nasce, il gesto.
La poesia finisce sulla prima parte, perché la seconda l’avevo tolta.
MD: E dov’è rimasta? Su Internet?
MDA: Sì, perché forse questa è la copia di una prima edizione. La seconda volevo concluderla proprio con questo senso di rinascita, della donna fecondata.
MD: Tant’è vero che ci aveva tratto in inganno e avevamo pensato che quello in atto fosse un parto, e non un tentato suicidio. Non eravamo riusciti a decifrare il T.S.
MDA: Ci sono entrambe le cose, c’è un tentativo di suicidio, un rapporto di vicinanza con la morte che poi si capovolge in un rapporto con la vita.
MD: Allora lasciamolo come documento e leggiamo anche la seconda parte.
MDA: Leggiamo anche la seconda, però poi dimenticatela.
E poi avrete sentito, almeno una volta
quando il liquido, delicatissimo,
esce dalla bocca, scorre giallo nel lavandino
e la sonda e le sirene sempre più lontane.
Il respiro si affanna, finisce, riprende
quanta pace nella spiaggia gelata dal temporale:
una canoa va verso l’isola corallina
e sotto l’oceano si accoppiano le cellule sessuali
non ci sono eventi irreparabili
ma solo le spugne cicliche,
gli insetti che hanno coperto l’aria:
ecco un colore di madreperla, una roccia nella sabbia,
l’accappatoio che toglie con un solo gesto
solennità della luce, la meraviglia, la prima
e la femmina del pellicano
chiama la nidiata sparsa nella tempesta
e forse vede qualcosa, tra gli scogli,
qualcosa che si muove
domani correrà con i suoi bambini
mescolata, per respirare
nel turchese profondo della marea
che sale in superficie, sta rinascendo adesso
e trova una terra diversa, un’altra voce.

