 Riccardo Visintin (RV): Abbiamo il piacere di incontrare Roberto Herlitzka, un grande attore che non ha bisogno di presentazioni. Uno di quegli attori intensi, profondi, che danno delle grandi emozioni.
Riccardo Visintin (RV): Abbiamo il piacere di incontrare Roberto Herlitzka, un grande attore che non ha bisogno di presentazioni. Uno di quegli attori intensi, profondi, che danno delle grandi emozioni.
Siamo proprio a ridosso del debutto dello spettacolo “La Mostra”, e quindi chiediamo — generalmente noi lo facciamo alla fine degli spettacoli, in questo caso lo facciamo prima — una sua impressione su questo suo “quasi debutto”.
Roberto Herlitzka (RH): Mah, i debutti sono sempre dei misteri, quindi averne un’impressione prima è difficile, in genere si ha quando lo si è già fatto. Però posso dire che il lavoro che stiamo facendo e che abbiamo fatto mi piace molto.
Mi piace molto il testo, il modo in cui il regista lo ha messo in scena, e anche il personaggio che interpreto (Vito Timmel, pittore triestino,1886-1946, ndr). È vero che non basta che le cose piacciano, bisogna anche farle piacere agli altri: però mi sembra che ci siano molti elementi perché il pubblico possa veramente essere coinvolto da questo spettacolo.
RV: Lei è un attore particolare: mi vengono in mente dei ricordi legati a certi film di Lina Wertmuller oppure ad un bellissimo spettacolo, che purtroppo credo sia stato l’ultimo, con Vittorio Gassman, che era il “Dante”.
E proprio Gassman, che ho avuto la fortuna di conoscere, mi disse: “Non avrei potuto fare questo spettacolo se non ci fosse stato accanto un attore della generosità di Roberto Herlitzka”. E l’attenzione poi al dramma nel senso più ampio del termine, quindi contemporaneo e no.
Lei si sente in qualche modo un attore che anche gli altri poi recepiscono come particolare, come al di fuori del grande alveo, come sempre un po’ alla ricerca della sua identità?
 RH: Senza dubbio io non posso che sentirmi un attore un po’ anomalo, dato che me lo dicono tutte le volte… e poi in effetti credo che ciò dipenda molto dalle scelte che io compio, le quali, per quanto riguarda il teatro naturalmente, partono sempre da testi che hanno un assoluto valore anche letterario.
RH: Senza dubbio io non posso che sentirmi un attore un po’ anomalo, dato che me lo dicono tutte le volte… e poi in effetti credo che ciò dipenda molto dalle scelte che io compio, le quali, per quanto riguarda il teatro naturalmente, partono sempre da testi che hanno un assoluto valore anche letterario.
Il che naturalmente viene spesso frainteso, perché gli autori moderni ai quali dico che non li voglio interpretare, si offendono e affermano che io voglio un linguaggio barocco… Io faccio loro delle critiche dicendo che il linguaggio deve essere la materia, e non un veicolo per raccontare delle cose. Il teatro nasce per il linguaggio, ma alcuni di questi autori non lo capiscono.
Per cui, non è che io scelga solo testi classici: naturalmente sui testi classici si va sicuri altrimenti non sarebbero tali, però anche nei testi moderni scelgo, quando posso, quelli in cui per l’appunto il linguaggio è privilegiato; il linguaggio può essere anche un dialettaccio, può essere anche il gergo di un coatto.
Purché l’autore abbia sentito il bisogno di esprimersi prima di tutto attraverso la parola, altrimenti la parola diventa soltanto un carretto per esibire altre cose, e questo non mi interessa.
RV: Le faccio una domanda, che è un po’ un “tormentone“, nel senso che la facciamo spesso agli attori che hanno una certa esperienza alle spalle (e tanti impegni davanti, altrimenti diventa una domanda un po’ mefitica, funerea, no?): un attore di una certa età afferma, forse con un po’ di supponenza, di appartenere ad una generazione di attori e di interpreti che hanno sudato moltissimo sui testi, che hanno fatto tanta esperienza e che si sentono disorientati di fronte ad una generazione di attori giovani — parlo sempre di attori di teatro — che fanno uno spettacolo, poi fanno una fiction e poi si perdono e si disperdono un po’.
Lei crede che per questi giovani ci sia una palestra un po’ meno faticosa rispetto a quella che è toccata a voi?
 RH: Io ho avuto la fortuna, come molti della mia generazione ed anche delle generazioni precedenti e seguenti alla mia, di avere un grande maestro che era Orazio Costa, il quale certamente mi ha dato una forma di chiarezza e di base su ciò che è il teatro. Per cui non corro il rischio di farlo intenzionalmente in modo sbagliato: poi io posso sbagliare il risultato, ma l’intenzione giusta ce l’ha fatta capire Costa. Naturalmente altri attori hanno avuto altri maestri, che oggi in effetti ci saranno pure, ma che io non conosco.
RH: Io ho avuto la fortuna, come molti della mia generazione ed anche delle generazioni precedenti e seguenti alla mia, di avere un grande maestro che era Orazio Costa, il quale certamente mi ha dato una forma di chiarezza e di base su ciò che è il teatro. Per cui non corro il rischio di farlo intenzionalmente in modo sbagliato: poi io posso sbagliare il risultato, ma l’intenzione giusta ce l’ha fatta capire Costa. Naturalmente altri attori hanno avuto altri maestri, che oggi in effetti ci saranno pure, ma che io non conosco.
I giovani hanno, è vero, varie possibilità, il che per me non è un male, anzi, è una bella fortuna. Il loro rischio e pericolo è proprio quello di trovarsi a lavorare con dei registi che non sono in grado di far recitare quelli che non sanno recitare, o di lasciar recitare quelli che sanno recitare.
Tanto è vero che quando si ascolta in televisione una di queste fiction — io non lo faccio, ma a volte mi capita di caderci dentro — si sente parlare in un modo che non esiste in natura; è una falsa naturalezza che consiste nel non dire le parole.
Nella vita, se uno sentisse un altro che parla in questo modo gli chiederebbe: “come hai detto?”, allora se si facesse così anche nelle fiction la cosa avrebbe un senso, perché anche lo spettatore non capisce, non credo che possa capire.
Il loro difetto è nei maestri, loro non fanno niente di male, poverini….
RV: Voi, come risorsa, avevate gli sceneggiati. Forse anche lei ne ha fatti alcuni. Era un altro tipo di “teatro in scatola”, come veniva chiamato, che forse non ha alcuna relazione con la fiction…
RH: Devo dire che non ho mai fatto sceneggiati, non mi hanno mai fatto lavorare… Sì, ho fatto un giallo a puntate con Leonardo Cortese che ha avuto un grande successo: facevo un regista. In effetti era un’altra cosa, ma una volta, più che gli sceneggiati, che poi in fondo non erano un granché di diverso rispetto alla fiction – anche se erano fatti con più cura – si faceva il teatro in televisione; adesso lo danno ancora…
RV: Ad ore impossibili…
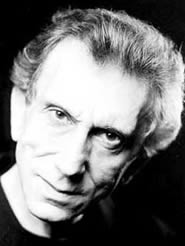 RH: Ad ore impossibili, ma indubbiamente era una cosa molto giusta, perché la gente veniva a conoscenza di testi che altrimenti non avrebbe conosciuto. Certo, il teatro in televisione non è il vero teatro, questo è solamente quello che si fa tra persone vive, tra spettatori ed attori. Però i testi e gli attori, perché quelli erano comunque attori di teatro, oggi non te li fanno più vedere.
RH: Ad ore impossibili, ma indubbiamente era una cosa molto giusta, perché la gente veniva a conoscenza di testi che altrimenti non avrebbe conosciuto. Certo, il teatro in televisione non è il vero teatro, questo è solamente quello che si fa tra persone vive, tra spettatori ed attori. Però i testi e gli attori, perché quelli erano comunque attori di teatro, oggi non te li fanno più vedere.
Bisogna dire che il cinema ha portato dei notevoli cambiamenti anche nel teatro e negli attori che hanno un’educazione ed una base totalmente teatrale: in qualche modo, se non sono “sordi”, il cinema cambia il loro modo di recitare. Inoltre, c’è di mezzo la piaga del doppiaggio, che in Italia è fatto benissimo, certamente, ma che abitua lo spettatore ad un modo di recitare che non appartiene alla natura, ma solo al doppiaggio; gli spettatori si abituano e se sentono recitare o parlare veramente non capiscono; non è che non capiscono le parole, ma non accettano il modo di esprimerle.


