Sono sul 714, autobus che mi porterà alla Fiera di Roma, per assistere ad una tavola rotonda sul fumetto a tematica omosessuale: sono vagamente trepidante, in fondo i nomi che leggo sul programma sono altisonanti e attendo, fiduciosa, di ascoltare degli stupendi interventi su quello che da qualche tempo a questa parte è divenuto uno dei miei chiodi fissi culturali. Arrivo, pago, entro nella sala riservataci (a me come agli altri appassionati e/o studiosi e/o curiosi), e mi accomodo presa da un senso d’anglosassone anticipation. Riassunto della conferenza: il fumetto gay forse c’è, forse non si sa cos’è, forse non esiste.
Sono confusa: che mi sia sbagliata? Che io sia una lettrice di un genere che non esiste? Ma se il genere non esiste, esisto io come lettrice? IO NON ESISTO? AIIIEEEEEE!!!!!

Mi riprendo, due vigorosi battiti di ciglia bastano. Rimetto in ordine i dati. Li analizzo. Risultato: sì, il fumetto gay esiste, ovunque, davvero ovunque, ma non in questa sala. Infatti, ne viene fatta in questa occasione una trattazione piuttosto improvvisata, talvolta incompleta, quando non imperdonabilmente fuorviante. Per carità, qualcuno dei conferenzieri si è fortemente impegnato per rendere l’approccio alla questione meno banale, o almeno si è sforzato di fare il punto della situazione in modo ragionato. Tuttavia, se il pubblico non fosse intervenuto con osservazioni estremamente stimolanti, la conferenza in toto sarebbe rimasta quanto meno campata in aria e sarebbe mancato un dibattito degno di tale nome. Di questo il mio rincrescimento è profondo: le occasioni di approfondimento sulla gaya cultura sono così infrequenti, se non rarissime, e in maggior parte concentrate nel brevissimo periodo dei Pride, che la tavola rotonda odierna avrebbe seriamente potuto essere quello “spazio di confronto che non c’è”, da tempo reclamato dalla comunità gay (se se ne condivide l’esistenza, cosa non scontata), e dal lettore omosessuale in generale. Perché, è ovvio, parlare di fumetto ad un pubblico così caratteristico, sociologicamente parlando, in un luogo deputato non al, pur meritevole, sviscerarsi dei vari gay issues, ma ad una comiconvention, in presenza quindi di un pubblico vario, multiforme e profondamente affezionato al medium fumettistico, avrebbe potuto divenire una grandissima occasione: di visibilità per chi pubblica o produce fumetti a tematica e per chi li legge, ma anche di crescita per chi omosessuale non è o alla cultura cosiddetta gay si avvicina con occhio non bigotto. Vogliamo cercare una causa? Una responsabilità? In realtà il più macroscopico dei problemi ha riguardato proprio l’organizzazione dell’evento: troppa gente chiamata a parlare, troppo poco tempo perché si riuscisse a trattare in modo soddisfacente l’argomento, evidentemente troppo vasto e articolato per le due ore concesseci. Sintomatico è stato il sostanzioso “sforamento” verificatosi (circa quaranta minuti), accompagnato da un senso di frustrazione e insoddisfazione da parte di tutti. Un dato positivo: tutti gli interventi sono stati infarciti di succosa aneddotica, se così non fosse stato, un incontro a tratti irritante si sarebbe trasformato in una noia alienante.

Ha aperto la conferenza Massimiliano De Giovanni, kappa boy co-autore di un fumo pubblicato per i tipi di Kappa Edizioni, accusato di contenere scene e contenuti spinti, qui presentatoci come un albetto per educande. In realtà, la parte veramente più godibile dell’intervento di De Giovanni è stata proprio quella incentrata sulle ragioni di una scelta editoriale come la pubblicazione di “Kizuna”, uno dei più celebri titoli di manga boys’ love made in Japan. Onore al merito della Kappa per essere stata in grado di coniugare profitti (“In fondo quello del fumetto shonen ai è per l’Italia un mercato in espansione”) e ideologia (“Abbiamo ritenuto giusto pubblicare comunque in libreria opere che in edicola non avrebbero potuto essere proposte”). Meno definibile per ratio e motivazioni, è stato l’intervento di Pasquale Ruggiero, editore per la Magic Press della versione nostrana di “The Authority”, comic in puro stile supereroistico al centro di un vespaio di polemiche per l’omosessualità dei protagonisti Apollo e Midnighter (versione post-moderna di Superman e Bat-Man). Ruggiero si prodiga nell’illustrarci la natura del fumetto in esame, il cui principale scopo narrativo è proprio quello di estremizzare i topoi dell’hero comic made in USA e fare di tali estremizzazioni topoi a loro volta. “The Authority” ci viene presentato come un comic in cui “vedi volà ‘na testa staccata” e in cui, in teoria, un bacio tra i protagonisti posto in un particolare di uno sfondo di una vignetta non dovrebbe destare scalpore. Non ci viene ricordato che in una società come quella americana un bacio tra uomini può fare molto più sensazione di un fumetto pieno zeppo di ripugnante violenza, ma questo è, o dovrebbe, essere noto a tutti.
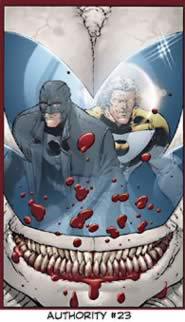 Peccato per un altro appuntamento mancato dell’intervento, errore questo imperdonabile: ci viene detto che tale opera è pubblicata dalla DC Comics, e che l’editrice è parte integrante del gruppo Time Warner. Un colosso dell’entertainment americano non poteva tenere in parco testate un fumetto “coi froci” senza suscitare un tornado di reclami da parte dei Concerned Parents di turno, ed è per questo che l’autore, per farsi pubblicità, ha cavalcato l’onda facendo addirittura sposare i due protagonisti per vendere di più. Quello che non ci viene detto è perché tali polemiche siano sorte (per altro dopo essere state amplificate da tutti i giornali del mondo). Ci viene spiegato che la DC ha in parco testate altre opere più o meno a tematica (sebbene Ruggiero dimentichi l’esistenza della linea Vertigo, mai citata durante tutto l’incontro), ma che solo questa ha fatto scalpore perché è un fumetto di super eroi. Dal suo discorso è possibile concludere che la “colpa” di “The Authority” è di essere un titolo da news-stand, cioè esposto al ludibrio di ognuno, mentre altre pubblicazioni, essendo presenti solo in fumetteria, sono indirizzate ad un pubblico più ristretto. In realtà dire questo non è sufficiente: Ruggiero avrebbe dovuto dirci che la differenza sostanziale non è un mero fatto di collocazione espositiva, ma è più profonda e riguarda proprio il target di un fumetto supereroistico. Ci parla della visibilità maggiore di un hero comic, giustamente, ma non ci dice che tale maggiore visibilità è presso il pubblico dei giovanissimi, particolare questo davvero rilevantissimo e capace di alimentare un saporito dibattito sul tema dell’approccio al fumetto da parte del lettore più giovane. Peccato, un’occasione perduta. L’intervento più vacuo e superfluo, mi duole dirlo, è stato quello della giornalista de L’Unità, Delia Vaccarello, autrice di un sondaggio sul fumetto a tematica gay, che si limita a leggerci (horribile dictu) i risultati, peraltro scontati, della sua ricerca. Uno sforzo personale unito ad un maggiore slancio intellettuale sarebbe stato auspicabile, da parte di chi, coraggiosamente, conduce una intera rubrica dedicata proprio alla visibilità gay su uno dei quotidiani più letti in Italia.
Peccato per un altro appuntamento mancato dell’intervento, errore questo imperdonabile: ci viene detto che tale opera è pubblicata dalla DC Comics, e che l’editrice è parte integrante del gruppo Time Warner. Un colosso dell’entertainment americano non poteva tenere in parco testate un fumetto “coi froci” senza suscitare un tornado di reclami da parte dei Concerned Parents di turno, ed è per questo che l’autore, per farsi pubblicità, ha cavalcato l’onda facendo addirittura sposare i due protagonisti per vendere di più. Quello che non ci viene detto è perché tali polemiche siano sorte (per altro dopo essere state amplificate da tutti i giornali del mondo). Ci viene spiegato che la DC ha in parco testate altre opere più o meno a tematica (sebbene Ruggiero dimentichi l’esistenza della linea Vertigo, mai citata durante tutto l’incontro), ma che solo questa ha fatto scalpore perché è un fumetto di super eroi. Dal suo discorso è possibile concludere che la “colpa” di “The Authority” è di essere un titolo da news-stand, cioè esposto al ludibrio di ognuno, mentre altre pubblicazioni, essendo presenti solo in fumetteria, sono indirizzate ad un pubblico più ristretto. In realtà dire questo non è sufficiente: Ruggiero avrebbe dovuto dirci che la differenza sostanziale non è un mero fatto di collocazione espositiva, ma è più profonda e riguarda proprio il target di un fumetto supereroistico. Ci parla della visibilità maggiore di un hero comic, giustamente, ma non ci dice che tale maggiore visibilità è presso il pubblico dei giovanissimi, particolare questo davvero rilevantissimo e capace di alimentare un saporito dibattito sul tema dell’approccio al fumetto da parte del lettore più giovane. Peccato, un’occasione perduta. L’intervento più vacuo e superfluo, mi duole dirlo, è stato quello della giornalista de L’Unità, Delia Vaccarello, autrice di un sondaggio sul fumetto a tematica gay, che si limita a leggerci (horribile dictu) i risultati, peraltro scontati, della sua ricerca. Uno sforzo personale unito ad un maggiore slancio intellettuale sarebbe stato auspicabile, da parte di chi, coraggiosamente, conduce una intera rubrica dedicata proprio alla visibilità gay su uno dei quotidiani più letti in Italia.

In fondo, non avevamo certo bisogno di sapere da una giornalista che il lettore di fumetti omosessuale vorrebbe vedersi descritto in modo sincero, senza strumentalizzazioni né pornografia becera, libero da pregiudizi e luoghi comuni. Avrei voluto porle quesiti fondamentali riguardanti il modo di porsi del lettore nei confronti del mercato fumettistico, le abitudini letterarie di chi rispondeva al sondaggio, il peso culturale che il gayo lettore dà alla visibilità del fumetto a tematica presso le nuove generazioni, e altro ancora, ma la Vaccarello se l’è squagliata subito dopo il suo intervento. Unica nota positiva, per ragioni personali: la frase più amata dalle lettrici lesbiche è proprio la mia citazione preferita da “Strangers in Paradise”, in amore non siamo che estranei in paradiso. La stessa Vaccarello ci presenta come unico, primo e solo supereroe gay Frocik, nato su un foglio diretto negli anni ’70 da Massimo Consoli. Potete trovarlo sul sito www.larivistina.com (attualmente sospeso a titolo cautelare, ndr) A parte la tristezza dell’inutilità della citazione (la Vaccarello conosce la differenza tra albo a fumetti e striscia satirica?) è piuttosto seccante che nessuno di chi interviene tiri in ballo Northstar, celeberrimo protagonista di un coming out da omosessuale e malato d’AIDS sulle pagine di “Alpha Flight”, notissimo comic supereroistico. Di questo personaggio si sarebbe dovuto discutere, anche solo per mettere in luce il legame tra pregiudizio e morale alla luce di un fumetto che finge di parlar bene dei gay in realtà cade, come molti altri suoi pari, nel più odioso degli stereotipi. Si sarebbe potuto parlare, anche se per poco, del rapporto tra comicdom americano e cultura del politically correct. Non è stato fatto: ancora una volta, peccato. A risollevare le sorti di quello che si avviava ad essere un patetico teatrino, è intervenuto il prof. Sergio Brancato.

Lucidissimo il suo discorso, puntiglioso nel definire le categorie culturali in cui il fumetto come medium va, o andrebbe, inserito, risolutiva la sua analisi della tematica della sessualità (e di riflesso dell’omosessualità) nel comic americano, cui in fondo molto dobbiamo in termini di moduli espressivi e scelte contenutistiche (anche se, è ovvio, nessuno oserebbe parificare Lazarus Ledd all’Uomo Ragno). L’idea chiave di tutto il suo dire è stupefacente nella sua assoluta elementarità: il fumetto crea miti. E il mito, da sempre, non è che uno spioncino affacciato sul mondo del sub-conscio. Chiave di volta per l’analisi della struttura mediatica fumettistica è la considerazione in base alla quale il fumetto s’incardina in un sistema in cui l’adolescente, lettore iniziale, alla ricerca di un’auto-definizione, costruisce la propria mitologia inserendo in essa le sue angosce, le sue conclusioni sul mondo, ma anche qualcosa di più profondo: la propria identità in formazione. Chiarissima l’indagine sul tema del “monstruo” fumettistico: il mostro visto con gli occhi di un soggetto nel bel mezzo di una evoluzione altro non è se non l’alter-ego onirico, la forza della materia che si oppone alle leggi morali, civili e religiose. Il mostro è la libertà, è lo strumento con cui rapportarsi per trovare una mediazione tra individualità e costrizioni sociali. In un fumetto eroistico, alla perfezione fisica dell’eroe si associa la deformità del villain, ancora una volta eidolon del desiderio erotico represso o nascosto a se stessi. Brancato, tuttavia, critica e supera certe impostazioni genitalistiche di taluni accademici (talvolta riprese anche da autori italiani, come l’Eco di “Apocalittici e Integrati”), sostenendo che tutto ciò che è oscuro è nel fumetto, così come tutto ciò che è luminoso: il personaggio altro non è se non un contenitore vuoto, che il lettore riempirà in funzione delle proprie zone d’ombra, siano queste relative al rapporto con la propria sessualità, sia legate ad una più ampia problematica d’inserimento nel proprio contesto sociale.
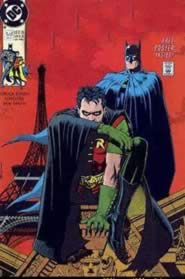 E’ tirata in ballo la coppia Bat-Man/Robin: secondo Brancato, in tale duo possiamo sì leggere un sottotesto d’omosessualità latente, ma anche un contesto di luce ed ombra, introspezione ed estroversione, paranoia e disimpegno, insomma una congerie di tematiche concatenantesi che insieme dipingono una quadro ben più esteso del mero rapporto gay velato, ossia ribellione ed uniformazione, asocialità ed accettazione delle norme sociali, uno schema valido per un adolescente, così come per ogni adulto dotato di sufficiente capacità di analisi e sintesi tra le istanze interiori e il mondo che lo circonda. A questo punto, trattate le problematiche connesse al fumetto americano e suoi derivati, avrebbe fatto da perfetto coronamento una indagine sul fumetto a tematica gay giapponese, ed, in effetti, era questo che l’obiettivo che si è posta Veruska Sabucco, si può supporre, quando ha esordito sostenendo che, proprio per la sua capacità di creare un immaginario erotico collettivo il manga june o shonen ai o parificabile, va visto come ottima cavia per esperimenti sulla psicologia delle donne nipponiche (che tale genere hanno creato a loro uso e consumo) e l’approccio che invece ha il lettore occidentale, gay o meno, a tali generi narrativi. Peccato che il suo intervento sia stato interrotto proprio sul più bello, da una stucchevole quanto insignificante diatriba con Angie della associazione YSAL, sui motivi della cui partecipazione ancora m’interrogo, giacché nulla di rilevante è stato detto proprio da colei che avrebbe dovuto illustrarci compiutamente il mondo delle fanzine, proprio perché attiva da anni nel sottobosco dell’autoproduzione. L’eccessivo tecnicismo, la volatilità dello scontro accesosi in sala, suscitato dall’interruzione ai danni della Sabucco, ha purtroppo fatto perdere al pubblico la possibilità di schiarirsi le idee sul manga a tematica e ha finito per far perdere di rilevanza alla frase conclusiva del suo intervento: l’omosessualità di taluni fumetti in realtà sottintende una inconscia volontà di “eterizzazione” dei rapporti, una sorta di paura di volare frutto delle costrizioni sociali che impongono regole anche in campi, come la sessualità o l’emotività, in cui regole, per ragioni ontologiche, non possono esistere. In sostanza, la visione della Sabucco vorrebbe spiegare nella fuga in un ideale (e per questo irreale) mondo apparentemente gay, che utilizza però archetipi propri di una sub-cultura eterosessuale, un desiderio di reductio ad normalitatem dei moti dell’animo, inconciliabile con la realtà delle emozioni.
E’ tirata in ballo la coppia Bat-Man/Robin: secondo Brancato, in tale duo possiamo sì leggere un sottotesto d’omosessualità latente, ma anche un contesto di luce ed ombra, introspezione ed estroversione, paranoia e disimpegno, insomma una congerie di tematiche concatenantesi che insieme dipingono una quadro ben più esteso del mero rapporto gay velato, ossia ribellione ed uniformazione, asocialità ed accettazione delle norme sociali, uno schema valido per un adolescente, così come per ogni adulto dotato di sufficiente capacità di analisi e sintesi tra le istanze interiori e il mondo che lo circonda. A questo punto, trattate le problematiche connesse al fumetto americano e suoi derivati, avrebbe fatto da perfetto coronamento una indagine sul fumetto a tematica gay giapponese, ed, in effetti, era questo che l’obiettivo che si è posta Veruska Sabucco, si può supporre, quando ha esordito sostenendo che, proprio per la sua capacità di creare un immaginario erotico collettivo il manga june o shonen ai o parificabile, va visto come ottima cavia per esperimenti sulla psicologia delle donne nipponiche (che tale genere hanno creato a loro uso e consumo) e l’approccio che invece ha il lettore occidentale, gay o meno, a tali generi narrativi. Peccato che il suo intervento sia stato interrotto proprio sul più bello, da una stucchevole quanto insignificante diatriba con Angie della associazione YSAL, sui motivi della cui partecipazione ancora m’interrogo, giacché nulla di rilevante è stato detto proprio da colei che avrebbe dovuto illustrarci compiutamente il mondo delle fanzine, proprio perché attiva da anni nel sottobosco dell’autoproduzione. L’eccessivo tecnicismo, la volatilità dello scontro accesosi in sala, suscitato dall’interruzione ai danni della Sabucco, ha purtroppo fatto perdere al pubblico la possibilità di schiarirsi le idee sul manga a tematica e ha finito per far perdere di rilevanza alla frase conclusiva del suo intervento: l’omosessualità di taluni fumetti in realtà sottintende una inconscia volontà di “eterizzazione” dei rapporti, una sorta di paura di volare frutto delle costrizioni sociali che impongono regole anche in campi, come la sessualità o l’emotività, in cui regole, per ragioni ontologiche, non possono esistere. In sostanza, la visione della Sabucco vorrebbe spiegare nella fuga in un ideale (e per questo irreale) mondo apparentemente gay, che utilizza però archetipi propri di una sub-cultura eterosessuale, un desiderio di reductio ad normalitatem dei moti dell’animo, inconciliabile con la realtà delle emozioni.

Abile è stato Mauro Cioffari nel cogliere la palla al balzo e innestare su questa considerazione il suo discorso, imperniato sul valore della militanza contro un sistema culturale creatore di miti che mortificano l’omosessuale. Forse un po’ troppo manierato e pedagogico, il suo intervento può riassumersi nell’esortazione al lettore gay affinché esca dall’indifferenza e lavori sul proprio rapporto con i mass media, alla ricerca di una auspicata “banalizzazione” del tema e un suo pieno inserimento nella liberazione sentimental-sessuale del fumetto. Ultimo, travolto dalla fretta di chiudere una conferenza fiume, è intervenuto Valeriano Elfodiluce, autore di un fumetto pubblicato online su www.gay.it . Sicuramente utile è stato il suo discorso, per aver toccato la problematica relativa alla diffusione via internet del fumetto, e alle caratteristiche della rete come mezzo di comunicazione diverso dal comic book, le cui peculiarità lo rendono flessibile, adatto alla diffusione amplissima di un messaggio attraverso il fumetto, ma limitato nella sua incapacità di creare una vera cultura del comic come mezzo espressivo oltre che di comunicazione.
Pressati dalla confusione creatasi per il ritardato inizio della conferenza Marvel Italia, ci riversiamo negli stand della mostra mercato. Ascolto i commenti dei miei compagni d’avventura: contrastanti, com’era prevedibile. Rimane il rammarico per tutte le attese tradite e per gli appuntamenti mancati. Una tavola rotonda che avrebbe potuto essere un primo sasso nello stagno, e che, tuttavia, non ha mai spiccato il volo, mantenendosi solo a tratti al di sopra di una deprimente mediocrità. Si poteva fare di meglio.

