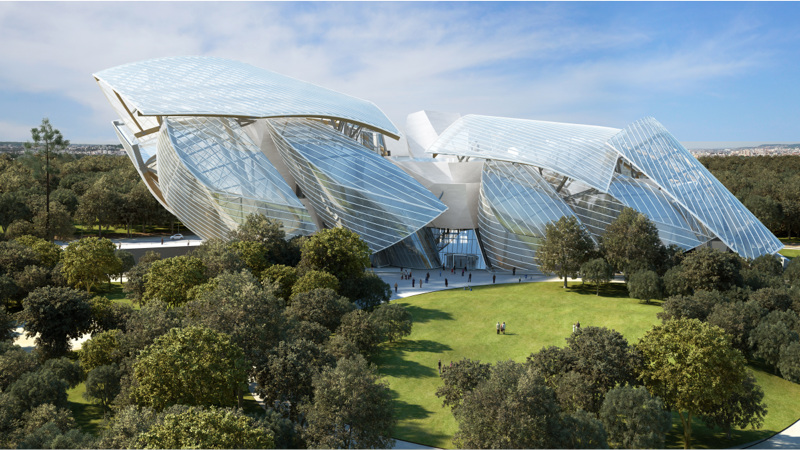Mario Menegazzi (MM): In occasione dell’esposizione “Mosaico / Nuove Contaminazioni. Architettura , Arte, Design” promossa dal Comune di Udine nel 1997, la Galleria d’Arte Moderna organizzò uno stage, rivolto specificatamente agli architetti, artisti, designer ed appassionati del mosaico, al cui interno prese luogo un laboratorio sperimentale al quale lei si unì, aperto alla libera partecipazione di artisti impegnati ad elaborare progetti e prove di mosaico. Qual è stata in quell’occasione l’esperienza di un Giovanni Cavassori mosaicista, oltre che intelligente e poliedrico manipolatore materico, e qual è tuttora il suo rapporto con l’antichissima arte musiva?
Mario Menegazzi (MM): In occasione dell’esposizione “Mosaico / Nuove Contaminazioni. Architettura , Arte, Design” promossa dal Comune di Udine nel 1997, la Galleria d’Arte Moderna organizzò uno stage, rivolto specificatamente agli architetti, artisti, designer ed appassionati del mosaico, al cui interno prese luogo un laboratorio sperimentale al quale lei si unì, aperto alla libera partecipazione di artisti impegnati ad elaborare progetti e prove di mosaico. Qual è stata in quell’occasione l’esperienza di un Giovanni Cavassori mosaicista, oltre che intelligente e poliedrico manipolatore materico, e qual è tuttora il suo rapporto con l’antichissima arte musiva?
Giovanni Cavassori (GC): Il contesto in cui l’operazione era cominciata era molto bello, perché lo spazio era situato da Federico Santini, che ha un laboratorio all’inizio di via Gemona (a Udine, ndr). Ci si trovava molto bene tutti assieme, ma io personalmente mi sono trovato male con le due persone che hanno preso in mano il mio lavoro, perché anche se era un divertimento, un gioco, a me piace fare le cose con professionalità, con qualità quantomeno, invece lì c’era una certa sufficienza. Il risultato in effetti era appena sufficiente, mi dispiace perché era un’occasione interessante per provare dei materiali che io non conoscevo e lavorare con dei ragazzi che li conoscevano, per cui c’era un interscambio interessante, mi dispiace per questo.
MM: Dopo aver frequentato il Liceo Artistico ed il corso di scenografia all’Accademia di Belle Arti di Venezia, prima di avvicinarsi alla scultura, lei intraprende sia l’attività d’illustratore, firmando peraltro nel 1979 l’immagine ufficiale della Biennale d’Arte di Venezia, sia l’attività di toy designer a livello internazionale. Partendo da questa sua attività qual è, secondo lei, il rapporto di un bambino con l’arte visiva anche nella sua esperienza di designer di giocattoli?
GC: Io ho fatto e faccio tuttora l’illustratore di pubblicità. Per le case editrici ho anche avuto a che fare con il mondo delle favole come da vent’anni con il mondo dei giocattoli, ma non riesco a far interagire il mondo dei giocattoli e dei bambini con il mio lavoro artistico. Ci metto una netta barriera che probabilmente non permette a loro di entrare, però mi mette nella condizione, quando faccio l’illustratore o il designer di giocattoli, di separarmi mentalmente dal discorso artistico — e credo di farlo con una certa qualità — seguendo tutte le norme tecniche che ci sono per creare giocattoli, per mettere in mano ai ragazzi qualcosa che sia giocabile. Però le due cose non interagiscono tra di loro.
MM: Nel 1994, a Bologna, hanno avuto luogo due sue mostre espositive, “Erotica” e “Sado” quest’ultima allestita presso la galleria “Il Campo delle Fragole”. Il critico Maja Taianovic ha parlato di “paradigma concettuale di un occultamento — rivelazione” che lei avrebbe escogitato, cercando di manipolare con irriverenza la gravità, il tempo, lo spazio e la massa insiti nella forma scultorea. Può dirci qualcosa in merito a tale interpretazione?

GC: Questi critici spesso si riempiono la bocca di parole che poi, come vedi non hanno senso, io mi ricordo una cosa molto particolare a “II campo delle fragole” e poi anche ad “Erotica” in cui ero stato invitato: i miei lavori, non so se li hai mai visti, hanno sempre una tendina, non certo quelli di fotografia dove l’immagine è dichiaratamente evidente: negli altri c’è una confezione che ti permette di avvicinarti al lavoro, di guardarlo esternamente e poi di scostare per fare un doppio gioco: quello del guardone, dello spione… Io mi ricordo che a Bologna, in questa favolosa città dove tutto dovrebbe essere libero dal punto di vista dei costumi, ho avuto dei seri problemi con i galleristi e anche ad “Erotica” è arrivato il prefetto e ha fatto spostare i miei lavori dall’ingresso in una zona riservata ai maggiori di diciotto anni; a “Il campo delle fragole”, mi ricordo che siamo andati a mangiare e mi hanno chiesto: “Ma come fai a fare queste cose?”. E io ho risposto: “Come faccio a fare queste cose? Abbiate pazienza, voi che siete una manica di pervertiti perché mi venite a fare queste domande?”.
Di quello che ha scritto il critico, di tutte queste cose, di questo viluppo di parole, non me ne frega niente.
MM: Tra le altre cose lei ha firmato c’è la copertina del volume “Terrore via cavo” (Panic Station, 1996) di Stephen Bowkett, edito nella collana “Fantascienza” della Giunti Ragazzi Universale. Qual è il suo rapporto con la Science Fiction e quali ritiene siano le suggestioni più profonde tra questo mondo letterario e quello dell’arte figurativa? Può in qualche modo interpretare alla luce della sua esperienza l’atticità di Karel Thole quale illustratore pluridecennale di copertine “Urania” Mondadori?
 GC: Nell’ultima parte hai menzionato Karel Thole: io ero stato chiamato dalla Mondadori perché Karel Thole aveva avuto dei problemi alla vista, per cui ad un certo punto non riusciva più a dipingere e allora avevano fatto un concorso, ma per pochi intimi, per fare le copertine di Urania ed ero stato selezionato, infatti ne avevo fatte due o tre, poi lui ha riacquistato improvvisamente e giustamente la vista, quindi ha ricominciato a lavorare. Con la Giunti ho avuto questa esperienza, l’unico problema con loro era un fatto economico, ma per il resto a me piaceva molto perché ti permette di giocare e poi di sviscerare dentro di te questi meccanismi della fantascienza costruire delle cose, sei liberissimo di fare quello che vuoi, compatibilmente con quello che il testo ti suggerisce, però è molto divertente, mi è sempre piaciuto, ma ho avuto poche occasioni di farlo, purtroppo.
GC: Nell’ultima parte hai menzionato Karel Thole: io ero stato chiamato dalla Mondadori perché Karel Thole aveva avuto dei problemi alla vista, per cui ad un certo punto non riusciva più a dipingere e allora avevano fatto un concorso, ma per pochi intimi, per fare le copertine di Urania ed ero stato selezionato, infatti ne avevo fatte due o tre, poi lui ha riacquistato improvvisamente e giustamente la vista, quindi ha ricominciato a lavorare. Con la Giunti ho avuto questa esperienza, l’unico problema con loro era un fatto economico, ma per il resto a me piaceva molto perché ti permette di giocare e poi di sviscerare dentro di te questi meccanismi della fantascienza costruire delle cose, sei liberissimo di fare quello che vuoi, compatibilmente con quello che il testo ti suggerisce, però è molto divertente, mi è sempre piaciuto, ma ho avuto poche occasioni di farlo, purtroppo.
MM: Tra i materiali da lei abitualmente impiegati non figurano solo le tecniche tradizionali di olii e tempere… anzi, al loro posto ne accosta altri che sono di segno opposto, come le stoffe cucite e il poliuretano espanso, che possono facilmente rinviare a un percorso plastico dell’immagine ben lontano da certa accademia classica. Quali sono le ragioni di questa sua scelta di un procedere sperimentale che tenta di privare radicalmente la rappresentazione della sua retorica espressionista più evidente?
GC: Io ho cominciato a fare queste cose d’arte dopo aver fatto per più di vent’anni l’illustratore. Ero talmente stufo di tenere il pennello in mano e di dipingere che ho ricercato qualcos’altro, poi con il fatto di dipingere produci sempre qualcosa di bidimensionale, di illusorio. In questo caso invece io posso toccare, palpare le mie sculture, accarezzarle, e da lì è nata la necessità di ricercare nuovi materiali e la curiosità ti porta poi a provare queste cose che sono pittura multimediale, sono dei supporti diversi, ad esempio fotografici incrociati con altre cose. È un fatto di curiosità, so però che è una cosa che crea moltissimi problemi, perché più vai a cercare materiali nuovi, oltre a crearne per te, li crei anche al gallerista: oggi qui non c’è un lavoro che ha una parte della figura che sborda all’esterno della forma regolare, e non c’è perché ha dei problemi a immagazzinarlo. Ecco, vedi come certe volte vengono frustrate determinate idee o necessità che hai in funzione di un problema banalissimo come quello di immagazzinare. Inoltre il fatto di metterci sopra, come in questo caso, le calze a rete o altre cose, è un gioco che mi piace. “Lei” aveva bisogno di cambiare identità, per cui ci ho messo le calze a rete.

MM: Boris Brollo, curatore della sua mostra tenuta presso lo “Spazio Juliet” di Treviso e conclusasi da poco meno di un mese, l’ha definita un “Dalì redivivo”. Si riconosce in questa definizione? E comunque, a prescindere dall’associazione, in che modo il surrealismo spagnolo ha influenzato la sua ricerca estetica?
GC: Non lo so, no so nemmeno perché lui mi abbia definito così, ma so che mi ha detto che sono un pervertito, che se continuo a fare quei lavori lì non vendiamo un accidente di niente, per cui è meglio che cominci a fare delle cose un po’ più glamour e meno evidenti. Forse è legato al surrealismo spagnolo questo ambiente, ovvero la gioia, la giovialità, il piacere che trasudano certi lavori di pittura spagnola, soprattutto surrealista, a differenza magari di un surrealista come Max Tedesco dove le atmosfere erano ben diverse, perché corpi nudi assieme a lardo di colonnata o prosciutto cotto escono dalle cornici o non sono cose consuete quanto meno.
MM: Sempre a proposito di Surrealismo. André Breton, padre del movimento artistico letterario nato ufficialmente in Francia nel 1924 con la pubblicazione del “Manifeste surréaliste”, condannò la ricerca calcolata della felicità limitata e quella realtà prudente e senza sorprese che rinuncia al sogno e al desiderio. Solo nel sogno, secondo Breton, l’uomo è completamente libero e tutto è possibile. Si riconosce, come artista e intellettuale, in quest’uomo sognante, oppure, per citare il titolo di una sua mostra tenuta a Trieste presso il Teatro Miela, “Pinocchio siamo noi”? Noi uomini mentitori e di legno, piuttosto che liberi e coscienti?
GC: Io ho bisogno di sognare ad occhi aperti e di veder concreto quello che sogno perché ho questo aspetto onirico, sognante. Non me le vedo di notte, me le vedo di giorno e ho bisogno di toccarle, mi invento delle cose straordinarie e le voglio rendere concrete, per cui non mi pare di essere così vago… Ho bisogno di vedere, di toccare anche le cose più esasperate che faccio, dunque sono d’accordo per quanto riguarda questo aspetto, ma sul resto non mi ci riconosco molto.

MM: La ringrazio.
GC: è stato un piacere.