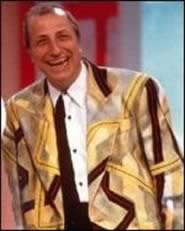 Giorgia Gelsi (GG): Pippo Franco è qui a Trieste ospite de “La Contrada” con lo spettacolo “Il fantastico Walter”, che è un testo di impatto comico, ma che nasconde anche poi uno spessore umano e psicologico molto profondo e che parla anche delle paranoie e dei problemi dell’uomo d’oggi. Come mai la scelta di un personaggio così, visto che è stato lei anche a tradurre il testo del drammaturgo Churchill?
Giorgia Gelsi (GG): Pippo Franco è qui a Trieste ospite de “La Contrada” con lo spettacolo “Il fantastico Walter”, che è un testo di impatto comico, ma che nasconde anche poi uno spessore umano e psicologico molto profondo e che parla anche delle paranoie e dei problemi dell’uomo d’oggi. Come mai la scelta di un personaggio così, visto che è stato lei anche a tradurre il testo del drammaturgo Churchill?
Pippo Franco (PF): Il teso originale non è così, è soltanto una farsa, cioè soltanto il meccanismo e io ho riadattato questo meccanismo riscrivendolo quasi interamente, dandogli anzi tutti quei contenuti di cui ha parlato, perché si prestava ad un racconto di questo tipo. Personalmente non amo un teatro semplicemente divertente anche perché ritengo che sotto il divertimento ci sia sempre qualche cosa di più profondo, basta considerare che l’ironia, l’allegria è una forma di spiritualità: tutti i grandi santi erano ironici a partire da S. Francesco per finire con Padre Pio, ma anche ad andare avanti, mi auguro, quindi sotto questo meccanismo c’è molto di più. Soprattutto io amo quel teatro in cui si spiega al pubblico perché avvengono quelle cose: dietro al tradimento di una moglie nei confronti del marito e viceversa, c’è sempre qualcosa di più profondo, un disagio che noi cerchiamo di analizzare e di spiegare, senza dare per scontato il tradimento come fa tutto il teatro. Ci sono tante altre cose, tanti altri arricchimenti. La scelta è stata motivata dal fatto che questo meccanismo poteva raccontare molto di più.
GG: In questo testo ciò che succede a Walter è di esorcizzare i propri problemi attraverso il teatro: il teatro diventa in qualche modo terapeutico; Secondo lei il teatro è veramente terapeutico?
 PF: Se non è terapeutico non è teatro. I greci andavano a teatro per cercare di capire come si dovesse svolgere la vita, quali erano le diritture, qual’era l’etica, qual’era la morale e che cosa accadeva a pensare in un certo modo o a pensare in un altro, a non accettare il dolore come espressione della vita. Addirittura c’è una commedia di Aristofane che si chiama Pluto, nella quale la dea Fortuna viene catturata da un individuo che la usa razionalmente, cioè non la fa agire a caso, ma con una certa logica e accade che tutti gli uomini diventano fortunati e gli dei sono disoccupati e comincia un altro tipo di disagio. Noi con il nostro teatro vogliamo non solo indicare e raccontare i disagi dell’uomo di oggi, ma vogliamo anche offrire le soluzioni e lo facciamo in chiave ironica. Mi pare che, visto il successo del secondo anno, malgrado alcune critiche velenose, che fanno parte del lato oscuro della forza, abbiamo decisamente ragione noi, sia perché i teatri sono affollati sia perché il pubblico non è stupido come questi critici — pochi per la verità — vogliono far credere.
PF: Se non è terapeutico non è teatro. I greci andavano a teatro per cercare di capire come si dovesse svolgere la vita, quali erano le diritture, qual’era l’etica, qual’era la morale e che cosa accadeva a pensare in un certo modo o a pensare in un altro, a non accettare il dolore come espressione della vita. Addirittura c’è una commedia di Aristofane che si chiama Pluto, nella quale la dea Fortuna viene catturata da un individuo che la usa razionalmente, cioè non la fa agire a caso, ma con una certa logica e accade che tutti gli uomini diventano fortunati e gli dei sono disoccupati e comincia un altro tipo di disagio. Noi con il nostro teatro vogliamo non solo indicare e raccontare i disagi dell’uomo di oggi, ma vogliamo anche offrire le soluzioni e lo facciamo in chiave ironica. Mi pare che, visto il successo del secondo anno, malgrado alcune critiche velenose, che fanno parte del lato oscuro della forza, abbiamo decisamente ragione noi, sia perché i teatri sono affollati sia perché il pubblico non è stupido come questi critici — pochi per la verità — vogliono far credere.
GG: Ma è solamente il teatro che ha questo effetto o è anche la televisione, visto che ne ha fatta e ne fa?
PF: No, la televisione ha una funzione diversa, non può andare in profondità su certi argomenti perché è fatta di numeri diversi. Qui noi ci rivolgiamo comunque ad un pubblico d’elite, un pubblico che viene in teatro, che è decisamente un pubblico minoritario rispetto a quello della televisione. Se noi volessimo avere nove milioni di persone in teatro, chissà quanti anni dovremmo lavorare. Quindi in televisione il discorso è molto più superficiale, addirittura tutto un altro: un discorso di caricatura, di canzonatura, mentre in teatro andiamo ad indagare nella profondità di noi stessi per quanto possibile, sempre in chiave comica; è quanto so fare io…
GG: E nel panorama italiano, lei ha lavorato negli anni passati con Garinei e Giovannini, ci sono altre realtà comiche potenti, forti secondo lei?
PF: No, secondo me no, io ritengo che gli spettacoli comici che vedo non si pongono mai di fronte al contenuto, cioè sono tutti quanti spettacoli semplicemente comici; è raro trovare uno spettacolo comico in cui si dice di più, si spiega di più, in cui si cerca di capire noi stessi, in cui si affronta il problema della vita rispetto alla vita, per lo meno oggi non lo si fa più. Lo si faceva prima, ma in passato, con il teatro di Eduardo o con altri grandi teatri, ad esempio Dario Fo fa un altro straordinario lavoro, ma certamente in un altro senso insomma. Io so fare questo, non mi pare di vedere spettacoli in cui si racconta di più, se lei ne sa qualcuno me lo dica, perché così mi contraddice…
GG: Prima lei parlava di ironia appunto nel teatro, ma è possibile applicare l’ironia a tutte le situazioni della vita, è un’arma sempre vincente?
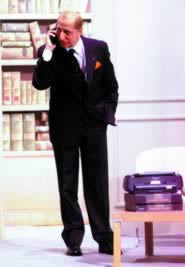 PF: Bisogna — se si conosce il buddismo zen o il buddismo di per sé, se si conosce bene anche il cristianesimo – si rendersi conto che anche la religione predica l’ironia. Senza l’ironia noi ci identifichiamo nel problema, nel senso ch,e se abbiamo un dolore, noi diventiamo quel problema. Per vedere quel dolore, per capire come ci si esce, bisogna usare l’arma dell’ironia, che vuol dire uscire fuori da se stessi: è una altissima forma di spiritualità. Proprio per questo, ragionare con lo spirito e non con il problema contigente, non con la nostra testa, o semplicemente con la nostra testa. L’ironia è l’unico mezzo certo che conosco per vedere la verità, per vedere il problema al di fuori di noi stessi.
PF: Bisogna — se si conosce il buddismo zen o il buddismo di per sé, se si conosce bene anche il cristianesimo – si rendersi conto che anche la religione predica l’ironia. Senza l’ironia noi ci identifichiamo nel problema, nel senso ch,e se abbiamo un dolore, noi diventiamo quel problema. Per vedere quel dolore, per capire come ci si esce, bisogna usare l’arma dell’ironia, che vuol dire uscire fuori da se stessi: è una altissima forma di spiritualità. Proprio per questo, ragionare con lo spirito e non con il problema contigente, non con la nostra testa, o semplicemente con la nostra testa. L’ironia è l’unico mezzo certo che conosco per vedere la verità, per vedere il problema al di fuori di noi stessi.
GG: Parliamo un attimo di cinema, lei ha lavorato con registi importanti, mi viene in mente il suo sodalizio con Pingitore, come sta secondo lei il cinema italiano?
PF: Si dice sempre che è moribondo e io credo che lo sia sostanzialmente, a parte quei pochi grandi artisti che riescono ad affermarsi, non si capisce come e vincono anche premi internazionali. Però oltre quello non c’è nulla perché il cinema italiano, come sostanzialmente anche il teatro, non ha identità. Ciò che accade in televisione, in quella del degrado, in un certo senso “la televisione deficiente” come dice la moglie di Ciampi, è una tragica verità, ma così anche in teatro si continuano a riproporre cose vecchie, trame che già conosciute. Il pubblico è disabituato alle novità, a interpretare il nostro tempo, non è il pubblico della Grecia del IV secolo prima di Cristo.Questo fatto non accade in verità in America, in Germania, in Inghilterra o in Francia, soltanto da noi il teatro non ha identità, o meglio non ha più identità, non si sa più che cosa sia, perché torno a dire, si ripetono sempre gli stessi titoli e il pubblico che è attratto — sostanzialmente glii abbonati — è sempre lo stesso pubblico che ama il teatro. Non si sa che cosa sia il teatro italiano, che si ferma sostanzialmente a Pirandello. Poi c’è stata qualche altra stella sporadica, ma autori non ce ne sono, identità non c’è mentre se parliamo del teatro tedesco anche oggi sappiamo di ciò di cui parliamo, come nel caso francese o inglese, se vogliamo americano. Così è nel cinema: il cinema italiano non solo non produce più quello che produceva una volta, ma sembra ripiegato su se stesso, nessuno osa fare film originali e non ha più identità. Questo è il problema di oggi, forse anche il mio, ma credo anche di tutti.
GG: Per riuscire anche ad andare verso l’innovazione, la sperimentazione, la strada è secondo lei nel teatro, nel cinema o nella televisione? O in nessuna delle tre?
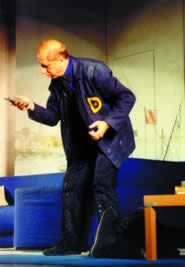 PF: In tutte e tre, soltanto che gli esercenti non hanno coraggio e non capiscono che un’industria senza sperimentare muore, per cui il teatro è costretto ad essere in qualche modo classico e non viene incoraggiato il teatro in sé. Il teatro viene combattuto in qualche modo, i gestori di un teatro dovrebbero in qualche modo venire aiutati, finanziati, viceversa ci sono gravami, tasse, ostilità di tutti i tipi che impediscono di lavorare serenamente. Chi gestisce un teatro oggi, non dico che è alla fame, ma rischia di arrivarci, e questo è consequenziale al fatto che lo stato non si occupa degli artisti e dell’identità dell’arte italiana, in questo caso dell’arte teatrale e cinematografica, e lasciamo quella televisiva ai dirigenti che comunque avranno questo problema, nel senso prima o poi dovranno porsi il problema della qualità in qualche modo. Ecco quindi che la nostra industria artistica in questo senso langue, non parliamo poi della pittura o delle arti figurative che sono allo sfascio: gli artisti italiani non sono più tali, fanno una fatica enorme ad esprimersi e trovano più spazio all’estero, ma non sono certo aiutati e l’arte italiana che ha una grandissima storia non si sa nemmeno più che cosa sia.
PF: In tutte e tre, soltanto che gli esercenti non hanno coraggio e non capiscono che un’industria senza sperimentare muore, per cui il teatro è costretto ad essere in qualche modo classico e non viene incoraggiato il teatro in sé. Il teatro viene combattuto in qualche modo, i gestori di un teatro dovrebbero in qualche modo venire aiutati, finanziati, viceversa ci sono gravami, tasse, ostilità di tutti i tipi che impediscono di lavorare serenamente. Chi gestisce un teatro oggi, non dico che è alla fame, ma rischia di arrivarci, e questo è consequenziale al fatto che lo stato non si occupa degli artisti e dell’identità dell’arte italiana, in questo caso dell’arte teatrale e cinematografica, e lasciamo quella televisiva ai dirigenti che comunque avranno questo problema, nel senso prima o poi dovranno porsi il problema della qualità in qualche modo. Ecco quindi che la nostra industria artistica in questo senso langue, non parliamo poi della pittura o delle arti figurative che sono allo sfascio: gli artisti italiani non sono più tali, fanno una fatica enorme ad esprimersi e trovano più spazio all’estero, ma non sono certo aiutati e l’arte italiana che ha una grandissima storia non si sa nemmeno più che cosa sia.
GG: Lei ha tirato fuori la pittura perché è stato ed è pittore anche…
PF: Perché la conosco, la amo, conosco le arti figurative tutte, e credo che non si possa parlare di teatro senza conoscere la storia dell’arte o senza conoscere la letteratura.
GG: La compagnia del Bagaglino come sta?
 PF: Sta benissimo, è una compagnia che si forma solamente in quel periodo durante il quale facciamo questi programmi, che — ribadisco — hanno un compito completamente diverso da quello del teatro e quindi è un’altra sfaccettatura, un altro modo di essere. È uno spettacolo che va avanti da quindici anni — ora ci apprestiamo al sedicesimo — quindi anche noi cominciamo a diventare un po’ vecchietti, però il compito di quello spettacolo è fare una sorta di caricatura, di sberleffo della realtà, sostanzialmente di prendersela con chi governa. Uno spettacolo che ripetiamo da quaranta anni e speriamo di poter ripetere ancora, ma è un altro lato del mio modo di essere, io sono anche un essere umano pensante, il quale crede innanzitutto nella propria esistenza e poi nel lavoro, il lavoro è espressione dell’esistenza, non è viceversa; molti di noi vivono in un mondo in cui si crede nel lavoro e poi nella vita, il nome Pippo Baudo forse basta per tutti
PF: Sta benissimo, è una compagnia che si forma solamente in quel periodo durante il quale facciamo questi programmi, che — ribadisco — hanno un compito completamente diverso da quello del teatro e quindi è un’altra sfaccettatura, un altro modo di essere. È uno spettacolo che va avanti da quindici anni — ora ci apprestiamo al sedicesimo — quindi anche noi cominciamo a diventare un po’ vecchietti, però il compito di quello spettacolo è fare una sorta di caricatura, di sberleffo della realtà, sostanzialmente di prendersela con chi governa. Uno spettacolo che ripetiamo da quaranta anni e speriamo di poter ripetere ancora, ma è un altro lato del mio modo di essere, io sono anche un essere umano pensante, il quale crede innanzitutto nella propria esistenza e poi nel lavoro, il lavoro è espressione dell’esistenza, non è viceversa; molti di noi vivono in un mondo in cui si crede nel lavoro e poi nella vita, il nome Pippo Baudo forse basta per tutti
GG: Per il prossimo anno ha già in mente uno spettacolo teatrale da portare in giro?
PF: Si, ho in mente una commedia mia, a questo punto conviene scriverla direttamente, in cui si parla della difficoltà di amarsi. È una commedia abbastanza simile a “Il fantastico Walter”, però più articolata, con maggiori colpi di scena e — mi auguro di poterli contrabbandare — maggiori contenuti.
GG: Grazie mille e in bocca al lupo.

