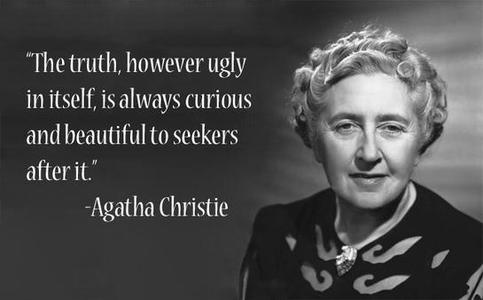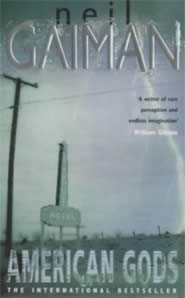 È certamente curioso parlare di American Gods all’indomani dell’annuncio, da parte de La Repubblica, dell’uscita di un libro a più mani (Quando un dio muore. Morti e assenze divine nelle antiche tradizioni mediterranee, a cura di Paolo Xella, Verona, Essedue) che indaga sulle modalità con cui, nelle religioni e mitologie pre-cristiane, sono stati affrontati episodi di morte e risurrezione delle relative divinità; talvolta con analogie più che fondate con ciò che erroneamente si ritiene l’unica occorrenza di tale situazione, fatto salvo l’atto di fede che eventualmente vi conferisce il dovuto rilievo. Da Osiride a Dioniso — dimostrazione, quest’ultimo, del processo di integrazione alla base del mai definitivo soppiantamento di una cultura al termine della propria parabola — la storia delle religioni presenta frequenti riferimenti di questo genere.
È certamente curioso parlare di American Gods all’indomani dell’annuncio, da parte de La Repubblica, dell’uscita di un libro a più mani (Quando un dio muore. Morti e assenze divine nelle antiche tradizioni mediterranee, a cura di Paolo Xella, Verona, Essedue) che indaga sulle modalità con cui, nelle religioni e mitologie pre-cristiane, sono stati affrontati episodi di morte e risurrezione delle relative divinità; talvolta con analogie più che fondate con ciò che erroneamente si ritiene l’unica occorrenza di tale situazione, fatto salvo l’atto di fede che eventualmente vi conferisce il dovuto rilievo. Da Osiride a Dioniso — dimostrazione, quest’ultimo, del processo di integrazione alla base del mai definitivo soppiantamento di una cultura al termine della propria parabola — la storia delle religioni presenta frequenti riferimenti di questo genere.
D’altronde, ritornando sulla letteratura non scientifica, chi a suo tempo ha letto Le nebbie di Avalon ricorda la rassegnazione di Morgana di fronte all’affermazione del culto di Maria, calzante metafora di una ciclica transizione già esemplificata a livello allegorico, per portare un esempio, dalle differenti versioni del mito di Cadmo. E non stupisce che, in questo strano sincretismo che tende a mantenere tuttavia una certa equidistanza, quasi a voler preservare l’integrità delle fonti, possiamo oggi accostare il rigore della ricerca accademica alla libertà espressiva del romanzo, la rivendicazione di uno sguardo secolare ad una nuova aspirazione al sacro. In altre parole, si mira ad individuare i due volti della moneta che, come in un gioco di prestigio, ci svela il lato a-logico e fortemente emotivo di una cultura in cui la tecnologia, come più di un osservatore ha fatto notare nel passato recente, non coincide necessariamente con la razionalità del pensiero scientifico. Il quale si trova anzi costretto alla rincorsa, con assunti teorici non sempre al passo delle lunghe falcate del progresso, così come la filologia — e tutta la cultura del postmoderno ne ha offerto la dimostrazione lampante — ha preso il sopravvento sulla storia, se non altro in termini di prospettive.
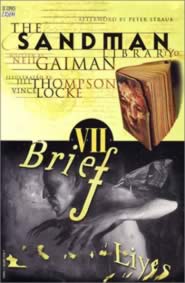 L’ultimo lavoro in prosa di Gaiman, in ordine di edizione italiana, affronta un tema caro all’autore già dai tempi di Sandman: la memoria del sacro, la dipendenza del dio dalla disponibilità alla venerazione, la rassegnazione a denti stretti della divinità dimenticata, in quella curva già percorribile in Season of Mists e culminata nell’ultima, gloriosa danza di Ishtar in Brief Lives.
L’ultimo lavoro in prosa di Gaiman, in ordine di edizione italiana, affronta un tema caro all’autore già dai tempi di Sandman: la memoria del sacro, la dipendenza del dio dalla disponibilità alla venerazione, la rassegnazione a denti stretti della divinità dimenticata, in quella curva già percorribile in Season of Mists e culminata nell’ultima, gloriosa danza di Ishtar in Brief Lives.
Una tempesta si sta per scatenare sugli Stati Uniti, terra di tutti e di nessuno dove gli dèi, dalle prime migrazioni vichinghe alle colonie europee, passando per il commercio degli schiavi, hanno seguito la memoria dei propri fedeli in un terreno che tuttavia non ha attecchito, inospitale come si è rivelato per gli antichi culti e le tradizioni lasciate al di là dell’Oceano, e poco a poco fertilizzato da nuove forme di venerazione per le divinità del progresso, della Rivoluzione Industriale, infine della globalizzazione. Nulla di sacro, almeno all’apparenza. Ma in questi luoghi di turismo, di ritrovo, di divertimento, per quanto in superficie, nella mancata consapevolezza di alimentare un processo fondamentalmente denso di sacralità, si celebrano l’intrattenimento e la carta di credito, il pc e il gioco d’azzardo, la fibra ottica e la televisione, soprattutto in un passo memorabile in cui il protagonista Shadow si ritrova a parlare e a confrontarsi con le soap-opera.
 Non è un segreto che la giovane nazione statunitense sia stata spesso tacciata, in Europa, della più sconfortante assenza di tradizioni, di miti e riti a costituirne l’ossatura, ovvero ciò che, con una certa dose di ipocrisia, si propende a ridurre a mero percorso storico, quasi a nascondere la fascinazione subita da un retroterra che tendiamo ad analizzare con finto distacco. Fattore che, in ultima analisi, non impedisce — anzi! — la ricerca talvolta forzata di radici alle quali appellarsi e che coincidono, almeno ai nostri occhi continentali, con anacronismi al limite della schizofrenia, e che solo un osservatore attento e sensibile quale Gaiman ha dimostrato di essere può restituire alla loro valenza più profonda, per quanto pacchiana nelle manifestazioni di superficie. Vedi la House on the Rock, da cui parte una sorta di onirico pellegrinaggio dalle giostre ad un drammatico raduno.
Non è un segreto che la giovane nazione statunitense sia stata spesso tacciata, in Europa, della più sconfortante assenza di tradizioni, di miti e riti a costituirne l’ossatura, ovvero ciò che, con una certa dose di ipocrisia, si propende a ridurre a mero percorso storico, quasi a nascondere la fascinazione subita da un retroterra che tendiamo ad analizzare con finto distacco. Fattore che, in ultima analisi, non impedisce — anzi! — la ricerca talvolta forzata di radici alle quali appellarsi e che coincidono, almeno ai nostri occhi continentali, con anacronismi al limite della schizofrenia, e che solo un osservatore attento e sensibile quale Gaiman ha dimostrato di essere può restituire alla loro valenza più profonda, per quanto pacchiana nelle manifestazioni di superficie. Vedi la House on the Rock, da cui parte una sorta di onirico pellegrinaggio dalle giostre ad un drammatico raduno.
Nel passato come nel presente, insomma, il denominatore comune, nonché limite che nessun progresso potrà mai valicare, è il bisogno del simbolo da caricare di aspettative e in cui traslare la prassi e la motivazione del nostro agire. “Il simbolo è la cosa”, comunque ed ovunque: e se lo dice Loki non possiamo che crederlo.
Alimentate dalla pratica rituale e condannate dall’ineluttabilità dell’evoluzione del pensiero, la mitopoiesi e la sua controparte degenerativa assumono, in American Gods, la veste di una battaglia tra le antiche tradizioni e le nuove leve del credo postindustriale, come se esistesse una via di fuga dal declino dell’immaginario arcaico, la stessa tentata dal pantheon nipponico in Season of Mists nel tentativo di annoverare tra le proprie fila le icone pop di Marylin Monroe e della statua della Libertà.
Ma se, ritornando al discorso a suo tempo approfondito da Gaiman, e parafrasando Nietzsche, è impossibile sostenere l’idea già morta senza ammetterne l’artificiosità, qual è lo scopo di una sfida altrimenti impari, priva di alcun senso?
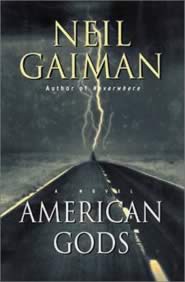 A questo non rispondiamo, invitando alla lettura del romanzo. Un romanzo pop, laddove la scrittura risponde alle esigenze care ai luoghi metafisici del fumetto contemporaneo; uno stile crudo, che ci mostra un Gaiman sorprendentemente maturo e disilluso, anche alla luce della maestria a più riprese sottolineata dalla critica anche ai tempi di Sandman; una prosa ricca, che alterna alla linearità dello svolgimento anacronie sviluppate con notevole perizia e, soprattutto, espressa in vere e proprie perle di intermezzo nella forma del racconto breve; un viaggio on the road, alla scoperta di un’America a modo suo carica di simbologie, pure nel riciclo e nella copia che ben poco denotano la dignità della reinterpretazione. E a questo punto, nella perplessità di scoprire una Il Cairo nell’Illinois insieme alle varie repliche di monumenti dalla grandiosità posticcia assimilabile ad una qualsiasi catena alimentare con qualche lustrino in più, riesce anche la satira, pungente quanto basta.
A questo non rispondiamo, invitando alla lettura del romanzo. Un romanzo pop, laddove la scrittura risponde alle esigenze care ai luoghi metafisici del fumetto contemporaneo; uno stile crudo, che ci mostra un Gaiman sorprendentemente maturo e disilluso, anche alla luce della maestria a più riprese sottolineata dalla critica anche ai tempi di Sandman; una prosa ricca, che alterna alla linearità dello svolgimento anacronie sviluppate con notevole perizia e, soprattutto, espressa in vere e proprie perle di intermezzo nella forma del racconto breve; un viaggio on the road, alla scoperta di un’America a modo suo carica di simbologie, pure nel riciclo e nella copia che ben poco denotano la dignità della reinterpretazione. E a questo punto, nella perplessità di scoprire una Il Cairo nell’Illinois insieme alle varie repliche di monumenti dalla grandiosità posticcia assimilabile ad una qualsiasi catena alimentare con qualche lustrino in più, riesce anche la satira, pungente quanto basta.
Gaiman si rivela, oltre che mitografo per passione, anche notevole antropologo nell’indagine sui nuovi miti e sulle ritualità sottese al nostro agire quotidiano, compiendo una ricerca sensibile ed approfondita che, come la maggior parte delle sue opere, oltrepassa i confini della fiction, pur salvaguardando l’equilibrio con la storia narrata. Da leggere tutto d’un fiato, se si accetta di sentirsi, alla fine, un po’ più permeabili alle suggestioni di un mondo forse meno pragmatico di quanto avessimo mai preventivato. Va detto che forse le chimere del consumo e dello spreco erano le prime avvisaglie di un fenomeno impulsivo che oggi abbiamo una volta di più l’occasione di approfondire. Resta il fatto che, se il recupero filologico delle nostre radici rappresenta un modo di ripercorrere la strada verso la riconquista di un’identità forte, il ritratto che ne esce è, al solito, indulgente, ma questa volta un po’ più amaro.
Peccato non averlo capito quando Neil faceva sparire le monete, qui a Trieste.
Neil Gaiman, American Gods, Mondadori, 523 pag.
€ 16, ISBN: 8804504668