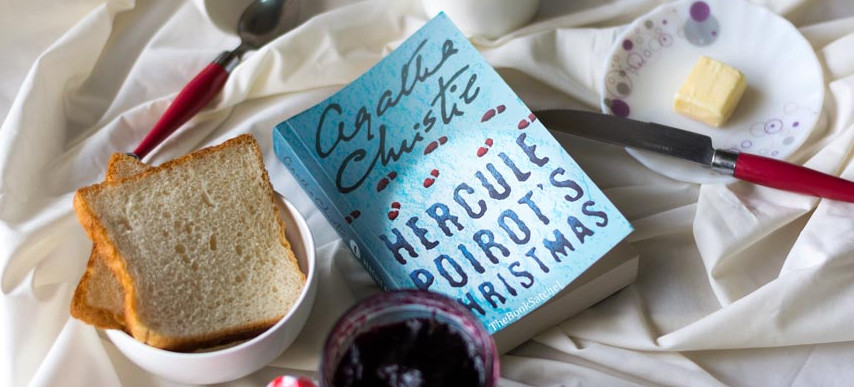Christian Sinicco (CS): Siamo a Gubbio per il Premio Montale con Andrea Gibellini, vincitore per la Sezione Poesia Edita. Andrea, di solito scrivi poesie poco montaliane, che comunque sono radicate nella tradizione della poesia italiana: ho individuato nella tua scrittura Sereni e Cardarelli. Cosa ne pensi della poesia e di ciò che in futuro si potrà ricercare come stile e contenuto?
Christian Sinicco (CS): Siamo a Gubbio per il Premio Montale con Andrea Gibellini, vincitore per la Sezione Poesia Edita. Andrea, di solito scrivi poesie poco montaliane, che comunque sono radicate nella tradizione della poesia italiana: ho individuato nella tua scrittura Sereni e Cardarelli. Cosa ne pensi della poesia e di ciò che in futuro si potrà ricercare come stile e contenuto?
Andrea Gibellini (AG): Intanto Montale è un grande magazzino che tutti possono in modo positivo saccheggiare, da “Ossi di seppia” fino alle ultime poesie ironico — parodiche di “Quaderno di quattro anni”. Bisogna esserne degni di aver vinto il Premio Montale: non è così facile. Montale è stato uno di quei poeti che mi hanno fatto iniziare a scrivere, uno di quei poeti talmente grandi, immensi, con cui si ha anche un rapporto conflittuale. D’altronde non potrebbe che essere così, lo è stato anche con Vittorio Sereni e Attilio Bertolucci, che con Montale sono stati i poeti a me più vicini. Montale ha cose bellissime ne “La bufera e altro”, che io riprendo; Bertolucci ha cose bellissime in “Viaggio d’inverno”; Sereni altrettante cose belle in “Gli strumenti umani”. È chiaro che noi abbiamo avuto un secolo di grande poesia e che ci sono questi tre poeti con cui è difficile confrontarsi, ma io credo che ognuno di questi possa dare qualcosa.
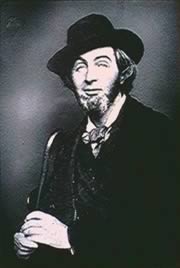 CS: Hai scritto questo libro, “La felicità improvvisa”, in una modalità vicina alla prosa. Ho notato una cosa partendo da una riflessione che ho fatto su Whitman, dalla prefazione di “Foglie d’erba”: la luminosità solare delle lettere è la semplicità. In questo tuo libro si percepisce questa luminosità delle lettere e i colori molto vividi che ne escono fuori. Cosa ne pensi appunto dello stile e delle emozioni e dell’espressioni che trovi per supportarlo?
CS: Hai scritto questo libro, “La felicità improvvisa”, in una modalità vicina alla prosa. Ho notato una cosa partendo da una riflessione che ho fatto su Whitman, dalla prefazione di “Foglie d’erba”: la luminosità solare delle lettere è la semplicità. In questo tuo libro si percepisce questa luminosità delle lettere e i colori molto vividi che ne escono fuori. Cosa ne pensi appunto dello stile e delle emozioni e dell’espressioni che trovi per supportarlo?
AG: Ci un fu un poeta dialettale, nato proprio dalle vostre parti, Biagio Marin, che disse che il segreto era pensare per immagini. Forse questo è quello che ho cercato di fare. Bisogna anche rendersi conto che un verso deve vivere di vita propria, e forse è quello che insegnano anche grandi poeti come Whitman. Per essere sincero l’impatto con Whitman non si è dato da subito ma attraverso la poesia di Cesare Pavese con “Lavorare Stanca”: il battito del verso lungo, lo scandire. E lo stesso avviene ricollegandomi a Bertolucci e nel campo della poesia emiliana con Bacchelli, coi suoi poemi lirici: parlo di un tipo di poesia che riesca a pensare per immagini e che abbia una tensione lirica lunga, un vero e proprio stile narrativo: probabilmente ci stanno dentro cose molto emiliane come Bacchelli e Bertolucci. Da questo punto di vista la tecnica di elaborazione dell’emotività passa attraverso alcuni canoni strettamente letterari. Tu prima facevi l’esempio di Cardarelli, che è un nome giusto: “Il sole a picco” e le prose degli anni Trenta sono state letture grandi. C’è molto Novecento, e riuscire a raccontare in versi una storia per me è la cosa importante.
CS: Tu fai molto questo lavoro, quello del comunicatore in poesia, cioè cerchi di trasmettere più emozioni possibili che sono date dalla sequenzialità delle parole. Così il lettore può emozionarsi ulteriormente. Ciò mi ricorda uno dei grandi poeti del Novecento, Rafael Alberti, che ha sentito la poesia come un cantare con forza.
 AG: Alberti mutua questa situazione poetica da Lorca, perché è Lorca che nella poesia spagnola dà una certa idea di poesia come vita ordinaria. Lorca diceva che la poesia era quella dell’uomo che cammina per la strada. Alberti mutua su questo registro le parole di Lorca; effettivamente questa idea mi è molto cara, il rendere le cose ordinarie straordinarie, che fa parte poi anche della poesia italiana. Ad esempio Montale in certe clausole si avvicina a una poesia legata all’ordinario per poi dire cose extra-ordinarie. Nel dire cose ordinarie in poesia, le parole devono essere legate a tutti: non solamente una cosa privata o aristocratica. C’è un poeta molto importante per me, l’inglese Larkin, uscito adesso per Einaudi con “Finestre alte”: qui c’è l’ordinario, ma dentro c’è sempre qualcosa di miacoloso, detto molto tra virgolette poiché io non sono religioso; è miracoloso ciò che avviene nella vita di tutti i giorni. In questo mi trovo perfettamente d’accordo con Alberti. Del resto la poesia non potrebbe essere che così.
AG: Alberti mutua questa situazione poetica da Lorca, perché è Lorca che nella poesia spagnola dà una certa idea di poesia come vita ordinaria. Lorca diceva che la poesia era quella dell’uomo che cammina per la strada. Alberti mutua su questo registro le parole di Lorca; effettivamente questa idea mi è molto cara, il rendere le cose ordinarie straordinarie, che fa parte poi anche della poesia italiana. Ad esempio Montale in certe clausole si avvicina a una poesia legata all’ordinario per poi dire cose extra-ordinarie. Nel dire cose ordinarie in poesia, le parole devono essere legate a tutti: non solamente una cosa privata o aristocratica. C’è un poeta molto importante per me, l’inglese Larkin, uscito adesso per Einaudi con “Finestre alte”: qui c’è l’ordinario, ma dentro c’è sempre qualcosa di miacoloso, detto molto tra virgolette poiché io non sono religioso; è miracoloso ciò che avviene nella vita di tutti i giorni. In questo mi trovo perfettamente d’accordo con Alberti. Del resto la poesia non potrebbe essere che così.
CS: Ho fatto delle ricerche su internet: hai partecipato ad una manifestazione in una birreria. A parte la birreria — cosa che potrebbe accomunare molti poeti — qual è l’importanza di una poesia letta in pubblico?
AG: Per me è molto difficile leggere le poesie in pubblico, come del resto fare le interviste: fa parte del carattere di una persona. Leggere in pubblico è davvero molto difficile. Certe serate possono funzionare bene e altre no. Comunque credo nella lettura in pubblico della poesia, perché può avvicinarla ad un pubblico più ampio, che non sia solo quello degli addetti ai lavori. Tondelli disse una grandissima cosa parlando del suo romanzo “Camere separate”:
“È un po’ come fare lo spogliarello”.
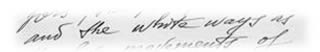
(Dopo la premiazione)
AG: Visto che siamo in Via del popolo, leggo una poesia che in un qualche modo parla di un viaggiatore, che è proprio quello della poesia, il quale sul treno fa delle considerazioni. La poesia si intitola “In treno”:
Per loro potrei essere chiunque.
Un medico, e con questa rivista
In mano verniciata di rosso
Potrei esserlo.
Oppure, così elegante –
Un completo grigio scuro
fumo di Londra,
con la camicia azzurra, e
un pullover grigio sopra –
un professore che insegni qualcosa di difficile
o astruso. O, ancora,
un venditore di piastrelle,
che oggi –
è settembre ma sembra autunno,
non è foschia al tramonto ma nebbia –
per strane circostanze,
ha scelto di viaggiare in treno.
Ma io non sono nessuno e nulla di tutto ciò.
A volte non sono neanche me stesso.
Sono solo uno che viaggia
da un luogo a un altro luogo.
(da La felicità improvvisa)