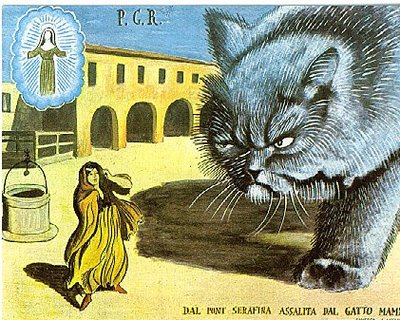Nell’ambito dello spettacolo teatrale “Di passaggio” rappresentato a Trieste presso il Teatro stabile de Friuli Venezia Giulia “Politeama Rossetti”, il giorno 9 dicembre 2001, in maniera molto informale, abbiamo fatto due chiacchiere con la regista Barbara Della Polla in merito allo spettacolo liberamente tratto da “Passaggio a Trieste” (di Fabrizia Ramondino, Ed. Einaudi), drammaturgia di Barbara Della Polla e Fabrizia Ramondino, regia di Barbara Della Polla (una produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione della Piccola Società Cooperativa Cassiopea).
Lo spettacolo ha rappresentato la tappa finale del progetto di formazione “Fare Teatro Di Passaggio”, finanziato da Commissione Europea — Fondo Sociale Europeo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Regionale alla Formazione Professionale.
Riccardo Visintin (RV): Domanda scontatissima: un bilancio…
Barbara Della Polla (BDP): Un bilancio? Benissimo, è andata benissimo, siamo contente, era sempre pieno, abbiamo iniziato a lavorare all’inizio di luglio, siamo rimaste tutte quante e quindi è andata benissimo.
 RV: Barbara, questa operazione — usando un brutto termine — teatrale, è appunto condotta in maniera coscienziosa, emotiva, seria, si potrebbero spendere un sacco di aggettivi… Partiamo da una riflessione mia, di spettatore, per sentire un po’ se tu sei d’accordo, per vedere anche di delineare come si è arrivati a questa avventura.
RV: Barbara, questa operazione — usando un brutto termine — teatrale, è appunto condotta in maniera coscienziosa, emotiva, seria, si potrebbero spendere un sacco di aggettivi… Partiamo da una riflessione mia, di spettatore, per sentire un po’ se tu sei d’accordo, per vedere anche di delineare come si è arrivati a questa avventura.
Io credo che uno dei lati luminescenti di questo spettacolo sia — ed è in qualche modo esemplificato anche nelle battute finali dello spettacolo — la visione del disagio, della sofferenza, nella maniera più ampia che si possa intendere, vista in questo spettacolo non sempre però attraverso i soli toni angosciosi, grigi, d’inquietudine, ma anche in una dimensione molto colorata… È giusta la mia impressione? C’è stata quest’intenzione?
BDP: È giustissima, credo che nel momento in cui dovevamo mettere in scena questo libro, ambientato in un “Centro Donna di Salute Mentale”, abbiamo iniziato una ricerca. Io personalmente sono rimasta colpita da una frase: “non esiste sofferenza senza gioia”.
Quindi devi avere per forza sperimentato la gioia… per arrivare alla sofferenza, e viceversa.
Prima di tutto siamo partite da questo, che era comunque costituire il gruppo, lavorare assieme. Lavorare assieme significa la conoscenza e il rispetto reciproco, indifferentemente dal tuo percorso di vita o di teatro. Un’altra cosa avevo chiara sin dall’inizio: quasi non volevo che ci fossero le parole… le parole sono arrivate proprio alla fine, gli ultimi venti giorni. Volevo lavorare molto sul corpo, anche sulla danza — se vuoi —, quella danza che diventa gesto quotidiano. Il lavoro sul corpo, per esempio, è molto importante, perché rappresenta il primo contatto che hai con “l’altro”.
RV: Penso che sia successo veramente così, non c’è appunto nessuna concessione al patetico…
Questo spettacolo è stato portato avanti, da te in prima istanza, e poi da un gruppo di lavoro affiatato al cui interno, tuttavia, le persone che si occupano attivamente di teatro e che lo esercitano come professione, sono in realtà poche.
A queste persone si unisce poi un gruppo di donne che ha avuto un approccio con il teatro senz’altro molto verginale, molto passionale, e che tuttavia del teatro non vive, non ne ha la conoscenza, gli strumenti…
Come vi siete organizzati, durante questi mesi di prove, tra professionisti e non professionisti?
 BDP: Ti spiego come è andata. La prima proposta di occuparmi di questo testo proviene da Antonio Calenda, direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Calenda era a conoscenza del testo di Fabrizia Ramondino. Me l’ha proposto perché io conosco Fabrizia, anzi una delle protagoniste del suo libro sono proprio io, che ho tenuto un laboratorio teatrale al Centro Donna mentre lei lavorava al suo testo.
BDP: Ti spiego come è andata. La prima proposta di occuparmi di questo testo proviene da Antonio Calenda, direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Calenda era a conoscenza del testo di Fabrizia Ramondino. Me l’ha proposto perché io conosco Fabrizia, anzi una delle protagoniste del suo libro sono proprio io, che ho tenuto un laboratorio teatrale al Centro Donna mentre lei lavorava al suo testo.
Mi è parso naturale, molto naturale visto che le protagoniste del libro sono queste donne, lavorare con queste persone.
A differenza di quello che si crede comunemente, io credo che nessuno è escluso dal percorso artistico, ognuno di noi è un artista, bisogna tirare fuori determinate cose, no? E quindi questo è stato. Ovviamente c’è stata una ricerca di finanziamenti, perché per un laboratorio lungo, come sai, c’è bisogno anche di soldi.
Siamo arrivati: la Regione, il Fondo Sociale Europeo ci ha finanziato due corsi, uno per allieve attrici e l’altro per sarte e costumiste, trenta donne… ti dico, studentesse universitarie, donne del Centro, donne più giovani, donne più vecchie, alte, magre, basse, eccetera, tutte coinvolte in percorso comune dal quale io stessa ho imparato molte cose.
Ci sono state altre professioniste che mi hanno affiancato, Marcela Serli, Sandra Cosato e Lydia Marjanko — che è una danzatrice —, infine una costumista. “Assieme” abbiamo cominciato a lavorare; io non avevo già un copione, non sapevo veramente cosa sarebbe stato il finale, abbiamo lavorato d’improvvisazione su alcuni temi e man mano si è costruito il canovaccio di uno spettacolo che, fino alla fine — lo puoi domandare a tutte —, non sapevamo come si sarebbe concluso. Il bello è stato proprio pensare a cosa potevamo metterci in mezzo… La costruzione di gruppo, magari anche sbagliando, l’equilibrio tra le persone: questa è la più grossa vittoria, secondo me.
RV: Il teatro può essere terapeutico dal tuo punto di vista, anche in considerazione di quest’ultima esperienza? Più in generale: da quando tu hai iniziato la carriera professionistica d’attrice, hai mai riscontrato questo tipo di valenza nel teatro. O si tratta di un’invenzione giornalistica?
BDP: Ti rispondo, ti rispondo… io non credo nel teatro-terapia, non sono una psichiatra, sono un’attrice. Credo che il teatro, se è vero — cioè, un “teatro vivente”, come dice Peter Brook —, sia la parte fondante dell’essere artista.
Quindi non è terapeutico, è l’esigenza di dire qualcosa. E questa è la cosa fondamentale in cui ognuna di queste persone si è riconosciuta.
Ma io non credo nel teatro terapia, credo che sia un mezzo per esprimersi, credo che bisogna avere un bagaglio che da mettere da parte ogni tanto per fare spazio ad altre cose che incontri.
 RV: Partendo dal presupposto volutamente provocatorio che le cose più interessanti ultimamente a teatro le fanno le donne, chiedo a Barbara Della Polla: ma siete davvero più brave dei maschietti? E in secondo luogo: c’è differenza tra l’approccio con il teatro da parte di una donna rispetto all’ottica maschile?
RV: Partendo dal presupposto volutamente provocatorio che le cose più interessanti ultimamente a teatro le fanno le donne, chiedo a Barbara Della Polla: ma siete davvero più brave dei maschietti? E in secondo luogo: c’è differenza tra l’approccio con il teatro da parte di una donna rispetto all’ottica maschile?
BDP: Non so se c’è una vera differenza, so semplicemente che sono una donna e quindi è chiaro che porto una mia esperienza “di genere”.
Non parto dal presupposto che voglio fare un teatro politico femminile, non mi interessa, sicuramente porto delle tematiche che sono femminili, che sono insite nel mio percorso di vita.
Se siamo più brave o meno brave questo non lo so, semplicemente so che ho delle cose da dire e le tiro fuori, e se posso, coinvolgendo sentimenti e stati d’animo che appartengono al comune sentire.