 Negli anni subito dopo il 1960, quando cominciavano ad affiancarsi alla tradizionale “Urania” anche edizioni come quelle della Tribuna, i lettori di fantascienza italiani avevano già a disposizione una certa quantità di materiale: circa mezzo migliaio di “pezzi”, tra libri e riviste. Se si calcola che erano stati pubblicati nel corso di una decina di anni, chi ne avesse acquistato uno la settimana avrebbe letto tutta la fantascienza pubblicata fino a quel momento e non gli sarebbe rimasta altra possibilità che aspettare fino all’”Urania” o al “Galaxy” successivo. Così, poco poco che un lettore superasse la sua dose settimanale, non c’era a disposizione abbastanza materiale da leggere.
Negli anni subito dopo il 1960, quando cominciavano ad affiancarsi alla tradizionale “Urania” anche edizioni come quelle della Tribuna, i lettori di fantascienza italiani avevano già a disposizione una certa quantità di materiale: circa mezzo migliaio di “pezzi”, tra libri e riviste. Se si calcola che erano stati pubblicati nel corso di una decina di anni, chi ne avesse acquistato uno la settimana avrebbe letto tutta la fantascienza pubblicata fino a quel momento e non gli sarebbe rimasta altra possibilità che aspettare fino all’”Urania” o al “Galaxy” successivo. Così, poco poco che un lettore superasse la sua dose settimanale, non c’era a disposizione abbastanza materiale da leggere.
Un certo soccorso, va detto, veniva dalle opere fuori collana, ma come essere sicuri che appartenessero davvero alla fantascienza? L’unica soluzione era la divisione del lavoro: trovare qualcun altro con cui scambiarsi elenchi e segnalazioni: quello che in America viene chiamato il “primo stadio del fandom” (dal secondo in su, si smette virtualmente di leggere per stampare riviste amatoriali).
Il modo canonico per riunire i lettori è quello di fare conoscenza attraverso le riviste, ma nessuna di quelle italiane era disponibile a questi contatti. Così, era più facile entrare in contatto con gli appassionati esteri che con gli altri fan italiani. In Francia, per esempio, usciva una fanzine abbastanza nota, “Le Jardin sideral” e ad essa collaboravano alcuni italiani, i quali l’avevano conosciuta attraverso le recensioni apparse sulla rivista francese “Fiction”.
Nonostante la difficoltà, comunque, erano già sorti i primi club locali di appassionati a Venezia e a Roma. Il gruppo veneto, Centro Cultori Science Fiction (CCSF), faceva perno attorno al giornalista Sandro Sandrelli e al pittore Missaglia, a Cossato, Missiaia e Bertoni, mentre a Roma la redazione della rivista “Oltre il Cielo” serviva da collegamento tra chi si occupava di narrativa fantastica o di astronautica. Nella Capitale, colui che teneva il maggior numero di contatti era Gianfranco de Turris. Il gruppo veneziano pubblicava un regolare bollettino e aveva anche prodotto uno dei primi cataloghi della fantascienza pubblicata in Italia.
Con l’inizio del Festival del Film di Trieste, i contatti tra appassionati divennero più facili e presto cominciarono ad apparire le prime fanzine ciclostilate. Tra i loro autori ricordiamo Riccardo Leveghi, Carlo Pagetti, Adalberto Cersosimo, e soprattutto Luigi Naviglio e Vittorio Curtoni, che senza dubbio erano i più prolifici: a memoria, si ha l’impressione che pubblicassero due fanzine di 150 pagine al mese.
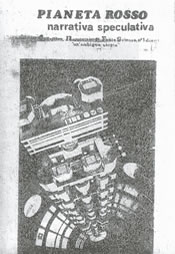 Un primo importante tentativo di riunire tra loro i piccoli gruppi cittadini venne compiuto nel 1965 dalla rivista “Futuro”, pubblicata a Roma da Lino Aldani e Massimo Lojacono. Questi lanciò l’idea di un gruppo di “Club Futuro”, uno per città, e mise in contatto tra loro coloro che avevano risposto positivamente all’iniziativa. Fu così che sorsero vari altri club e che si misero in contatto tra loro: tra quelli più attivi c’erano i gruppi di Rota a Bologna, Naviglio a Milano, Curtoni a Piacenza, e soprattutto di Riccardo Leveghi a Trento, che pubblicava una fanzine intitolata “L’aspidistra” con eleganti copertine op-art.
Un primo importante tentativo di riunire tra loro i piccoli gruppi cittadini venne compiuto nel 1965 dalla rivista “Futuro”, pubblicata a Roma da Lino Aldani e Massimo Lojacono. Questi lanciò l’idea di un gruppo di “Club Futuro”, uno per città, e mise in contatto tra loro coloro che avevano risposto positivamente all’iniziativa. Fu così che sorsero vari altri club e che si misero in contatto tra loro: tra quelli più attivi c’erano i gruppi di Rota a Bologna, Naviglio a Milano, Curtoni a Piacenza, e soprattutto di Riccardo Leveghi a Trento, che pubblicava una fanzine intitolata “L’aspidistra” con eleganti copertine op-art.
Il gruppo di Torino aveva una decina di appartenenti e si riuniva un paio di volte al mese. Inizialmente, l’attività si limitava alla ricerca di materiale fuori distribuzione: uno dei soci faceva le ordinazioni per gli altri e ciascuno teneva i contatti con qualche gruppo. Si tenevano anche rapporti con vari ambienti marginali, come gli ufologi della rivista “Clypeus”, il cui direttore Gianni Settimo organizzò alcuni incontri di comune interesse: una serata con lo scrittore di fantascienza Johannis, una riunione con Peter Kolosimo a cui parteciparono anche Cozzi, Rota e Curtoni, il quale portò con sé Gianni Montanari, allora al suo “debutto in società”.
Lo strano aspetto di questo primo fandom è che per alcuni anni fu molto attivo, poi cessò quasi del tutto l’attività. Il genere si pensa che si è estinto per lotte politiche interne. In realtà i contatti sono continuati, ma dopo alcuni anni di entusiasmo la produzione di fanzine si è diradata. Del resto, a parte Naviglio e Curtoni, gli altri gruppi non avevano prodotto molto: tanti numeri unici e poca regolarità. Qualche polemica, comunque, c’è sempre stata, per esempio l’eterno tormentone di de Turris contro il “comunismo” della Rambelli. Altre erano legate all’editoria: per esempio Filanci, che a quell’epoca dirigeva insieme a Luigi Cozzi la rivista “Proxima”, accusava La Tribuna di avere pubblicato un romanzo annunciato da lui. O alcuni autori italiani che polemizzavano contro la Rambelli, la quale non comprava più i loro racconti. Le fanzine entravano nel dibattito e poi litigavano tra loro. Un caso particolare, però, che destò parecchie critiche e spense molti entusiasmi, fu quello di Aurelio de Grassi che querelò Sandrelli per una sua recensione negativa. Il problema di quel primo fandom era il solito: farsi conoscere. Infatti, le iniziative partivano sempre da segnalazioni comparse sulle riviste. Dopo quella di “Futuro”, per vario tempo non ce ne furono, ma quando Curtoni e Montanari cominciarono a dare spazio su Galassia alle iniziative dei fan, tornarono ad apparire club come quelli di Ferrara e di Borgomanero, che negli anni seguenti avrebbero organizzato le prime convention a Ferrara e a Stresa.
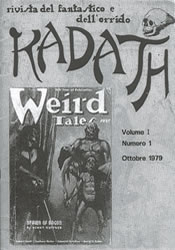 Un ultimo accenno all’attività torinese. Il club voleva fare un suo bollettino, “Sevagram”, e alla fine venne pubblicato da me e da Giacomo Amore, con l’aiuto di Franco Filanci, che ci diede vario materiale. La gestazione fu abbastanza lunga e alla fine pubblicammo una fanzine prevalentemente dedicata alla critica e alle recensioni, un po’ perché eravamo due bibliofili, un po’ anche perché gli scrittori del club, Staffilano, Giglio, Temporini, Gabutti, estenuati dall’attesa, avevano ormai pubblicato altrove i loro racconti migliori: in genere presso l’”Aspidistra” di Leveghi o i “Numeri Unici” di Curtoni.
Un ultimo accenno all’attività torinese. Il club voleva fare un suo bollettino, “Sevagram”, e alla fine venne pubblicato da me e da Giacomo Amore, con l’aiuto di Franco Filanci, che ci diede vario materiale. La gestazione fu abbastanza lunga e alla fine pubblicammo una fanzine prevalentemente dedicata alla critica e alle recensioni, un po’ perché eravamo due bibliofili, un po’ anche perché gli scrittori del club, Staffilano, Giglio, Temporini, Gabutti, estenuati dall’attesa, avevano ormai pubblicato altrove i loro racconti migliori: in genere presso l’”Aspidistra” di Leveghi o i “Numeri Unici” di Curtoni.

