 La nuova Potsdamer Platz, ricostruita su progetto dell’architetto italiano Renzo Piano, nel 2001 ha visto arricchire il suo edifìcio principale con il Museo del Cinema. Dove fino a un decennio fa si ergeva il famoso muro oggi trova posto uno spazio espositivo permanente che documenta la storia del cinema tedesco.
La nuova Potsdamer Platz, ricostruita su progetto dell’architetto italiano Renzo Piano, nel 2001 ha visto arricchire il suo edifìcio principale con il Museo del Cinema. Dove fino a un decennio fa si ergeva il famoso muro oggi trova posto uno spazio espositivo permanente che documenta la storia del cinema tedesco.
Il Filmmuseum Berlin infatti presenta, in modo simile al Museo Nazionale del Cinema di Torino ma con minor spessore e meno materiale, un percorso interessante di fotografie, video e memorabilia vari che spaziano dai primi film muti a capolavori degli anni Venti come “II gabinetto del dottor Caligari” di Robert Wiene (manifesto dell’espressionismo cinematografico) e “Metropolis” di Fritz Lang (primo esempio di megaproduzione dal sapore futuristico e profetico). I maestri della settima arte teutonica vengono ricordati tutti, da Lubitsch a Sternberg fino a Fassbinder e Wenders, come pure gli attori tra cui spiccano l’austriaca Romy Schneider, Hanna Schygulla, Otto Sander e Franka Potente, protagonista del recente “Loia corre”. Sezioni intere sono dedicate anche alla produzione della propaganda nazista e al notevole “Olympia” che la regista Leni Riefenstahi girò nel’3 6 in occasione delle Olimpiadi di Berlino con un montaggio elaborato, spettacolare e innovativo.
Ma la vera attrazione del museo è senz’altro costituita dalla collezione privata della leggendaria Marlene Dietrich. Una parte delle quindicimila foto, dei trecentomila documenti e lettere e dei tremila vestiti e oggetti personali conservati in vita dall’attrice sono esposti nelle stanze dedicate a Marlene. Il mito per eccellenza del cinema tedesco e hollywoodiano viene illustrato in tutte le sue molteplici sfaccettature.

Si comincia con un documento eccezionale, inserito nella sezione sulle pellicole prodotte dalla Repubblica di Weimar: il filmato dei provini e della lavorazione di “L’angelo azzurro” che Josefvon Sternberg girò nel 1930 e che decretò il successo per la Dietrich, Del film vennero subito realizzate due versioni, una in tedesco e l’altra in inglese, gli attori recitavano ogni scena due volte: così Sternberg e Marlene divennero popolari negli Stati Uniti e lì si trasferirono per dedicarsi ad altri sei film. Interessante al riguardo è il contratto della Paramount con l’attrice, in cui la casa cinematografica americana enumera dettagliatamente il tipo di automobile assegnato alla Dietrich e il numero di vestiti che le spetta. Al rapporto maestro-attrice è riservata una parte che comprende lettere e foto, dalle quali risulta chiaro il forte legame professionale e sentimentale tra i due che avevano lavorato insieme per la creazione di un mito.
Entrare nella sala principale che ospita il patrimonio di Marlene è oltremodo emozionante.
 Due grandi schermi proiettano le immagini maggiormente suggestive tratte dai suoi film (in tutto più di una trentina, girati tra il’30 e il’79) e in sottofondo risuonano canzoni mitiche come “Ich bin die fesche Loia” e “Illusions”. La stanza è circolare, tutt’intorno sono collocate le splendide fotografìe in bianco e nero, molte realizzate sotto la dirczione di Stemberg. Sei manichini, con le fattezze di Marlene, indossano gli abiti originali di altrettante storiche interpretazioni. C’è la divisa bianca della marina americana che la diva portava nel film “La taverna dei sette peccati” (1940), il vestito restaurato da Armani di “Montecarlo” (1957) unica coproduzione italo-americana nella carriera della Dietrich che recitò con Vittorio De Sica, nonché il famoso abito da scena che Marlene indossava durante i suoi concerti e che fece molto parlare perché sul palcoscenico dava l’impressione che il suo corpo fosse nudo, ricoperto solo da fili di diamanti.
Due grandi schermi proiettano le immagini maggiormente suggestive tratte dai suoi film (in tutto più di una trentina, girati tra il’30 e il’79) e in sottofondo risuonano canzoni mitiche come “Ich bin die fesche Loia” e “Illusions”. La stanza è circolare, tutt’intorno sono collocate le splendide fotografìe in bianco e nero, molte realizzate sotto la dirczione di Stemberg. Sei manichini, con le fattezze di Marlene, indossano gli abiti originali di altrettante storiche interpretazioni. C’è la divisa bianca della marina americana che la diva portava nel film “La taverna dei sette peccati” (1940), il vestito restaurato da Armani di “Montecarlo” (1957) unica coproduzione italo-americana nella carriera della Dietrich che recitò con Vittorio De Sica, nonché il famoso abito da scena che Marlene indossava durante i suoi concerti e che fece molto parlare perché sul palcoscenico dava l’impressione che il suo corpo fosse nudo, ricoperto solo da fili di diamanti.
Ripercorrere la vita di Marlene Dietrich è però anche attraversare la storia del Novecento. Ed ecco, nella sala successiva, comparire le testimonianze dell’attività militare dell’attrice. Convinta oppositrice di Hitler che avrebbe voluto farne una gloria del regime, divenne cittadina americana già negli anni Trenta e s’impegnò come pochi nel compito di supportare le truppe americane sul fronte euro-africano durante la II Guerra Mondiale. Tra il’44 e il’45 fu impegnata in più di cento concerti in Nord Africa, Italia, Inghilterra, Francia e Germania e non furono pochi gli episodi in cui la Dietrich si trovò a rischiare la vita. La medaglia al valore militare che si meritò è esposta nel museo insieme alle foto che ricordano quegli anni. In fondo alla sala uno schermo mostra Marlene che canta “Black market” dal film “Scandalo internazionale” (1948) di Billy Wilder, ambientato a Berlino nel secondo dopoguerra.
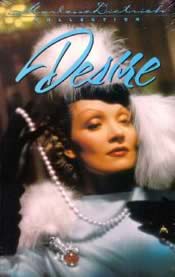 La Dietrich si muove tra le rovine della stessa città che oggi ospita la sua collezione. Ci è voluto però del tempo prima che i tedeschi si decidessero a omaggiare la loro più grande diva, su cui molti si ostinano a manifestare riserve, forse perché emblema di un ingombrante passato, forse per le accuse di doppio gioco mossele durante la guerra. Ma nel 2001 ricorrono i cento anni dalla sua nascita e questo evento non poteva passare inosservato.
La Dietrich si muove tra le rovine della stessa città che oggi ospita la sua collezione. Ci è voluto però del tempo prima che i tedeschi si decidessero a omaggiare la loro più grande diva, su cui molti si ostinano a manifestare riserve, forse perché emblema di un ingombrante passato, forse per le accuse di doppio gioco mossele durante la guerra. Ma nel 2001 ricorrono i cento anni dalla sua nascita e questo evento non poteva passare inosservato.
Le sale destinate a Marlene terminano con gli oggetti della sua seconda carriera, quella di cantante che, sotto la dirczione di Burt Bacharach, la portò in giro per i palcoscenici del mondo fino al’76. Si susseguono vetrine intere piene di effetti personali: portasigarette decorati, scarpe, cappelli, valigie, enormi scatole per il trucco. Non mancano poi le lettere e le fotografìe dei numerosi amici intimi e amanti della Dietrich, coi quali ebbe relazioni di cui è spesso impossibile conoscere la vera natura. Sternberg, Gary Cooper, Dolores Del Rio, Jean Gabin, Hemingway sono i più presenti, anche se formalmente l’attrice restò sposata al marito fino alla morte di lui. E alla famiglia, alla figlia, alla vita privata e,alle vacanze è dedicato un altro schermo su cui passano le immagini di video personali.
La donna che incarnò uno dei più forti sogni erotici di celluloide, simbolo di fascino, di bellezza algida e irraggiungibile, di ambiguità, mistero e ironia era una persona intelligente e coraggiosa. Lo provano le attività che ha svolto in vita e i diari su cui annotava tutto e commentava gli eventi. Con la stessa disciplina prussiana s’impegnò davanti alla macchina da presa esprimendo col volto, con l’espressione le emozioni richieste dai suoi registi e affrontò i disagi di una lunga trasferta in suolo bellico per sostenere una causa in cui credeva. Ha affascinato il pubblico di mezzo mondo con la sua voce profonda e la sua vita privata è paragonabile alla trama di un romanzo epico.

Quest’autunno a Berlino sono in programma le proiezioni dei suoi film e il ritomo in teatro del popolare musical “Marlene”, mentre la città le ha intitolato una piazza, poco lontano dal Museo del Cinema e da Potsdamer Platz e da quegli studi Ufa dove girò “L’angelo azzurro”.
E sempre a Berlino Marlene riposa dal’92. Dopo il suo ritiro dalle scene nel’76 a causa di una caduta dietro le quinte di un teatro di Sydney in cui  aveva riportato la rottura del femore, la Dietrich si rinchiuse in un appartamento di Parigi, la sua terza patria. Circondata dai cimeli di una vita eccezionale, manteneva i contatti col mondo e con gli amici per via telefonica. La morte la colse il 6 maggio 1992 nel momento giusto, come ultimo atto di uno show perfetto: in quei giorni le vie di Parigi erano tappezzate dai cartelloni del Festival del Cinema di Cannes che aveva scelto il suo volto giovanile come immagine per quell’edizione. La sua bara venne avvolta nella bandiera francese prima, in quella americana dopo e infine in quella tedesca. Marlene aveva espresso il desiderio di venir sepolta a Berlino vicino alla madre. Da quando era caduto il muro, accarezzava di nuovo l’idea di trasferirsi in quella che lei chiamava “la città oscura, che attraversavo senza paura con la mano stretta in quella di mia madre.”
aveva riportato la rottura del femore, la Dietrich si rinchiuse in un appartamento di Parigi, la sua terza patria. Circondata dai cimeli di una vita eccezionale, manteneva i contatti col mondo e con gli amici per via telefonica. La morte la colse il 6 maggio 1992 nel momento giusto, come ultimo atto di uno show perfetto: in quei giorni le vie di Parigi erano tappezzate dai cartelloni del Festival del Cinema di Cannes che aveva scelto il suo volto giovanile come immagine per quell’edizione. La sua bara venne avvolta nella bandiera francese prima, in quella americana dopo e infine in quella tedesca. Marlene aveva espresso il desiderio di venir sepolta a Berlino vicino alla madre. Da quando era caduto il muro, accarezzava di nuovo l’idea di trasferirsi in quella che lei chiamava “la città oscura, che attraversavo senza paura con la mano stretta in quella di mia madre.”

