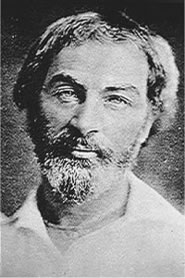 Nel diffidare di una certa sottocultura di massa che prende l’individualismo a regola senza approfondirlo, trovo nella poesia di Whitman risorse intellettuali enormi che ci permettono di oltrepassare ogni forma di generalizzazione o di banalizzazione dei contenuti dell’esistenza.
Nel diffidare di una certa sottocultura di massa che prende l’individualismo a regola senza approfondirlo, trovo nella poesia di Whitman risorse intellettuali enormi che ci permettono di oltrepassare ogni forma di generalizzazione o di banalizzazione dei contenuti dell’esistenza.
Innanzitutto una riflessione sulla velocità e immediatezza di questo verso: “Io celebro me stesso”. Chiunque abbia letto “Foglie d’erba” si è trovato di fronte un groviglio ininterrotto di pensieri, emozioni, suspence come se cadesse per lo stesso orlo di bellezza intuita dal poeta, come se stesse dirupando verso un essere la cui autoconoscenza è immediata e il cui cambiamento è in improvvisi stupori. Nella poesia di questo autore accade di immaginare i versi del grande poeta americano fino a farli divenire rete che ha nei particolarissimi nodi di parole i propri fori di significato, nodi che non sempre compongono una forma finita, ma quando lo fanno si comportano come uno sfondo infinito, uno sfondo di lontananze in cui lo sguardo cerca.
Mentre relazioniamo la poesia di Whitman all’epoca contemporanea, spesso serrata da muri ideali e reali, noi che ci identifichiamo in una generazione nata da metropoli o da città al margine di una grande corrente di trasformazioni che vorremmo percepire e che viene soffocata presto da qualche forma di disillusione, da qualche considerare utopia una piccola trasformazione per il nostro benessere, noi, generazione o generazione di massa, sperimentiamo attraverso il nostro fare, con sempre meno consapevolezza, il concetto che per capire o dimostrare che abbiamo capito si abbisogni di un’idea, pur banale, da verbalizzare.
Ritornando a Whitman e al suo passare un’intera vita elaborando ripensamenti su “Foglie d’erba” (penso che i lettori a lui contemporanei si siano anche stufati dei continui ampliamenti di quell’opera, per quanto ne fossero fortemente attratti), cercando di equilibrare la lente del mio scrutare attraverso la poetica dell’autore, mi domando perché il pensiero spesso sia così simile ad una immagine stereotipata, una immagine che mutiamo in maniera irrazionale senza accorgercene, ad esempio quando parliamo con gli altri al bar o nel metrò con una persona appena incontrata. Sforniamo generalizzazioni come se da queste dipendesse la vita e, nel nostro caso, la nostra individualità e il rapporto con gli altri. Alle volte, discorrendo del più e del meno, siamo convinti che l’immagine di noi stessi o i concetti che stiamo trattando siano stabili ed eterni, ed invece passano senza che ce ne accorgiamo o si trasformano.
Sono convinto che la mutevolezza di pensiero sia positiva, e che anche questo nostro cambiare maschera lo sia, a patto che lo si viva con ironia o divertiti: questo basterebbe per farne a meno, quando vogliamo. E questo significa riflettere e scegliere per noi stessi.
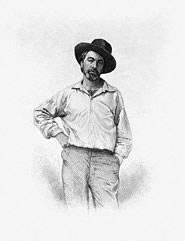 Ad esempio, si osservi la forte contraddizione nell’immagine stessa che la televisione dà dell’uomo postmoderno: da una parte una carica, una spinta sovrumana, mezzi e balocchi inimmaginabili; dall’altra parte stereotipi, culi e tette e canzonette per rimbambirci o addormentarci la sera, tornati a casa. “Sono anni che faccio questo mestiere”, ho sentito l’altro giorno in un film (penso di aver sentito questa frase circa una quarantina di volte nei film ed ora, alla quarantunesima, me ne sono accorto e ho cambiato canale). Ogni nostro relazionare al mondo esterno, di cui ci fidiamo e la cui tenuta in qualche momento vacilla, è da valutare come metafora e non come un dato di fatto: la vita è una continua metafora e se mi osservo nella relazione tra i miei vissuti e l’esterno comincerò a diventare selettivo grazie alla mia volontà, a cercare per me stesso la bellezza e il piacere, a trovare compiacimento nel dire no e nel dire sì, a celebrare le mie espressioni e le impressioni che ho.
Ad esempio, si osservi la forte contraddizione nell’immagine stessa che la televisione dà dell’uomo postmoderno: da una parte una carica, una spinta sovrumana, mezzi e balocchi inimmaginabili; dall’altra parte stereotipi, culi e tette e canzonette per rimbambirci o addormentarci la sera, tornati a casa. “Sono anni che faccio questo mestiere”, ho sentito l’altro giorno in un film (penso di aver sentito questa frase circa una quarantina di volte nei film ed ora, alla quarantunesima, me ne sono accorto e ho cambiato canale). Ogni nostro relazionare al mondo esterno, di cui ci fidiamo e la cui tenuta in qualche momento vacilla, è da valutare come metafora e non come un dato di fatto: la vita è una continua metafora e se mi osservo nella relazione tra i miei vissuti e l’esterno comincerò a diventare selettivo grazie alla mia volontà, a cercare per me stesso la bellezza e il piacere, a trovare compiacimento nel dire no e nel dire sì, a celebrare le mie espressioni e le impressioni che ho.
Non credo serva un grande ideale per vivere come un Whitman o come un Signor X postmoderno, ma credo servano molte relazioni da sviluppare e da osservare tra noi stessi e il mondo.
Questo è il compimento della poetica di “Foglie d’erba”, il comprendere le relazioni, che sono il corpo della nostra individualità.
Le persone si relazionano per i propri bisogni alla pubblicità, alla televisione, al cinema, a qualsiasi cosa. Gli elementi del mondo si presentano con immediatezza, prima che si possa sviluppare un pensiero complesso, ma ogni nostra prassi è un comprendere ed è poetico essere attratti sia dallo sfondo che dalla figura della rappresentazione che ci sta di fronte. I due mondi, la prassi e il pensiero, nella vita non sono separati, ci sono molte intersezioni tra di loro, ne è un esempio l’arte di questo autore che costruisce vita e il passo verso la metafora appare più breve.
Ma nessuno ci sta interrogando stavolta e possiamo anche meditare in silenzio. Anche fare gli indiani, s’intende: nessuno limiti le nostre contraddizioni, le nostre fissazioni, i nostri costumi e consumi quotidiani.
La vita necessita solo di avere allo sportello un esperto, un io pazzesco che colga le metafore con cui questa si presenta. Le ripetute assenze di quell’esperto producono disaffezioni varie, incurabili malattie infettive, una sottocultura e un incolto fogliame di banalizzazioni, che non soddisfa. Cosa faremo allora per debellare quella sottocultura? Utilizzeremo un defoliante? Cosa farà il poeta o lo scultore? Il pittore o il drammaturgo, l’impiegato o l’operaio, il saggio o il filosofo? E cosa posso fare io?
Whitman aiutò da infermiere i feriti nella Guerra Civile, poi morì. Per tutta la vita migliorò la stessa idea, la stessa lunghissima poesia. E sono sicuro che ci siamo innamorati di questo poeta.


ecceionale!!! difficile trovare un commento cosi poco scontato di Withman