Interprete del movimento. Un movimento continuo dentro e fuori la dimora dove sono costrette le donne musulmane, dalla tradizione e dall’Algeria.
Scrittrice dell’attraversamento. Un attraversamento in prosa degli spazi con biglietto di andata e ritorno e delle lingue, in quella che definisce una triangolazione linguistica segnata su una terra, quella maghrebina, attraversata da una pluralità di voci e di lingue, il cui sottofondo è scandito da quella berbera.
 Assia Djebar, cresciuta sotto la volta di studi classici, fin dalla sua prima esperienza letteraria a 21 anni ha elaborato una scrittura che indossa una grafia francese ma, come lei stessa ha precisato, non è necessariamente francofona. è la sua lingua, la lingua che ha cercato e che alla fine ha trovato. Una personale grafia che come un fiume la cui corrente trasporta rami e ciotoli, porta con sé la memoria ancestrale della sua cultura d’origine. E dove la lingua francese viene abitata in modo particolare. Il francese per lei, e non lo ha mai nascosto nelle sue interviste, rappresenta una lingua matrigna. Alla fine, il conflitto tra la proiezione che la spinge fuori dal patriarcato e la tradizione che la imprigionerebbe nella dimora, la porta a riflettere, a voltarsi indietro e come scrive lei stessa a “cercare di ascoltare il mormorio delle donne rimaste recluse”.
Assia Djebar, cresciuta sotto la volta di studi classici, fin dalla sua prima esperienza letteraria a 21 anni ha elaborato una scrittura che indossa una grafia francese ma, come lei stessa ha precisato, non è necessariamente francofona. è la sua lingua, la lingua che ha cercato e che alla fine ha trovato. Una personale grafia che come un fiume la cui corrente trasporta rami e ciotoli, porta con sé la memoria ancestrale della sua cultura d’origine. E dove la lingua francese viene abitata in modo particolare. Il francese per lei, e non lo ha mai nascosto nelle sue interviste, rappresenta una lingua matrigna. Alla fine, il conflitto tra la proiezione che la spinge fuori dal patriarcato e la tradizione che la imprigionerebbe nella dimora, la porta a riflettere, a voltarsi indietro e come scrive lei stessa a “cercare di ascoltare il mormorio delle donne rimaste recluse”.
Esiliata di lusso, Assia Djebar non si sente un’eroina o un simbolo, si definisce piuttosto come un’intellettuale, una poetessa, una scrittrice. Rimane comunque un personaggio eclettico difficile da collocare, che sfugge da qualsiasi etichetta, anche da quella di militante femminista.
L’abbiamo intervistata a Trieste a margine di un incontro svoltosi nell’ambito della rassegna S/paesati, organizzata da Bonawentura in collaborazione con il Teatro Stabile Sloveno e il Dipartimento di Storia e Storia dell’Arte dell’Università di Trieste.
Gianfranco Terzoli (GT): Madame, lei ha scritto in uno dei suoi romanzi che dai suoi libri esce il mormorio delle donne recluse…
Assia Djebar (AS): Uno dei temi e dei soggetti specifici dei miei libri è rappresentato dalla ricerca delle voci della memoria femminile. Gli anni della mia infanzia — erano gli Anni Quaranta e Cinquanta — li ho vissuti all’interno della società musulmana. Si trattava di una società molto tradizionale, ma che al tempo stesso lottava per la sua liberazione. Nella mia testa si incrociano voci di donne che erano recluse, non potevano parlare, che erano come soffocate, ma che al tempo stesso lottavano per affermarsi, ed erano dunque donne attive e dinamiche.
GT: Pensa di essere considerata un simbolo da molte donne che vivono in uno stato di sottomissione?
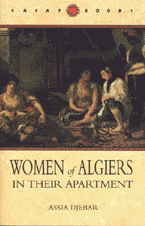 AS: Io non penso assolutamente di essere un simbolo, ma al contrario di essere una donna come tutte le altre. Penso solo di essere una donna scrittrice, interprete, intellettuale e quindi penso di riflettere le voci di quelle donne e di ritrasmetterle in qualche maniera attraverso il mio lavoro: è un tipo di solidarietà femminile.
AS: Io non penso assolutamente di essere un simbolo, ma al contrario di essere una donna come tutte le altre. Penso solo di essere una donna scrittrice, interprete, intellettuale e quindi penso di riflettere le voci di quelle donne e di ritrasmetterle in qualche maniera attraverso il mio lavoro: è un tipo di solidarietà femminile.
GT: Pensa che i suoi romanzi possano aver comunque influenzato dal punto di vista sociale la vita di molte donne?
AS: Sì, possono aver donato delle speranze. Penso di aver influenzato certamente qualche donna più giovane di me, ma quello che io vorrei è di influenzare le scrittrici, tutte le donne che fanno il mio stesso mestiere in tutti i Paesi, e sono molte. E spero di avere lo stesso tipo di forza di trasmissione e di fedeltà per tutte coloro che non hanno la fortuna di poter scrivere. Spero che possano diventare un po’ come me e mi auguro di riflettere le speranze anche di quelle donne che non hanno potuto esprimersi. Ci sono molte scrittrici oggi in Algeria, sia di lingua francese, sia araba.
Ma non le va proprio giù di essere dipinta come un’eroina.
Conclude scherzosamente: “non bisogna fare troppi complimenti agli scrittori”.

