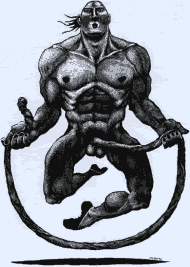 Il primo collegamento che viene naturale fare con qualche altro disegnatore di fumetti è sicuramente quello con Thomas Ott, su cui ci siamo già soffermati alcuni mesi fa. Anche la Colino si affida ad un incisivo e penetrante bianco e nero per raccontare le sue storie e gli esiti grafici sono molto simili a quelli del disegnatore zurighese, nonostante le tecniche impiegate dai due siano diverse. Maria Colino usa infatti una classica scratch board, una tavola precedentemente preparata da cui toglie con taglierino e raschietto l’inchiostro di cui è ricoperta per ricavare luce e profondità. Cambiano i referenti visivi (per Ott sono le copertine dei pulp magazines, per la Colino i Maestri incisori) ma il risultato complessivo è molto simile.
Il primo collegamento che viene naturale fare con qualche altro disegnatore di fumetti è sicuramente quello con Thomas Ott, su cui ci siamo già soffermati alcuni mesi fa. Anche la Colino si affida ad un incisivo e penetrante bianco e nero per raccontare le sue storie e gli esiti grafici sono molto simili a quelli del disegnatore zurighese, nonostante le tecniche impiegate dai due siano diverse. Maria Colino usa infatti una classica scratch board, una tavola precedentemente preparata da cui toglie con taglierino e raschietto l’inchiostro di cui è ricoperta per ricavare luce e profondità. Cambiano i referenti visivi (per Ott sono le copertine dei pulp magazines, per la Colino i Maestri incisori) ma il risultato complessivo è molto simile.
Ciò che cambia è il diverso approccio alle storie. Se per quelle di Thomas Ott avevamo parlato di “parabole noir” e di umorismo nero per Maria Colino è più corretto parlare (fatta salva comunque la presenza di una certa dose di humour nero) di brevi illuminazioni senza troppa intenzione di “fustigare i costumi” e di storie più articolate in cui prevale il gusto del fumetto in sé , la voglia di raccontare una storia per immagini nella maniera più incisiva possibile.
Queste due tendenze trovano perfettamente rispondenza nel volume Rabia Maxima, diviso quasi specularmente tra le storie di Fortuna, “Dea dell’azzardo infausto”, che vanno da pagina 6 a pagina 19 e cinque racconti brevi autoconclusivi distribuiti su ventiquattro pagine.
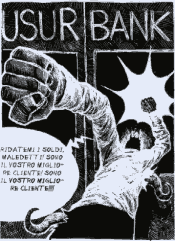 Fortuna è la narratrice/protagonista di undici storie fulminanti (la maggior parte si concludono in una sola tavola, solo tre durano il doppio) e nella cosmologia della Colino è colei che sceglie i successi o le sconfitte degli uomini, è insomma la personificazione in abiti vagamente sadomaso della sorte beffarda che muove gli esseri umani. Siamo comunque ben distanti dalle forti connotazioni drammatiche (e quindi moraliste) di Thomas Ott: il crollo fatale delle ambizioni e gli abissali insuccessi delle vittime di Fortuna sono dipinti con toni troppo sarcastici ed enfatici per voler essere presi sul serio più del dovuto. Si tratta di un trattamento tutto sommato ottimista di temi “difficili” quali l’handicap o il suicidio: la lunga serie di sconfitte e delusioni suscita un sorriso piuttosto che una meditazione sulle miserie umane.
Fortuna è la narratrice/protagonista di undici storie fulminanti (la maggior parte si concludono in una sola tavola, solo tre durano il doppio) e nella cosmologia della Colino è colei che sceglie i successi o le sconfitte degli uomini, è insomma la personificazione in abiti vagamente sadomaso della sorte beffarda che muove gli esseri umani. Siamo comunque ben distanti dalle forti connotazioni drammatiche (e quindi moraliste) di Thomas Ott: il crollo fatale delle ambizioni e gli abissali insuccessi delle vittime di Fortuna sono dipinti con toni troppo sarcastici ed enfatici per voler essere presi sul serio più del dovuto. Si tratta di un trattamento tutto sommato ottimista di temi “difficili” quali l’handicap o il suicidio: la lunga serie di sconfitte e delusioni suscita un sorriso piuttosto che una meditazione sulle miserie umane.
Graficamente queste storie sono caratterizzate da una certa immediatezza e semplicità compositiva. Le figure umane (soprattutto quella della stessa Fortuna) sono deformate ed esagerate in posizioni improbabili fino a diventare elementi decorativi. I tentativi di rifarsi ad una prospettiva di tipo classico sono pochi ed anch’essi assumono uno statuto iconico “altro” rispetto alla funzionalità abituale: le case sullo sfondo e un treno che arriva da lontano non danno tanto l’impressione della profondità quanto quella della particolare atmosfera che la Colino vuole infondere alle sue tavole; sono, in buona sostanza, delle reminiscenze dell’Espressionismo. Forse per una minor confidenza con il “mestiere” i racconti di Fortuna presentano poi dei contrasti nettissimi tra nero e bianco, e spesso gli eventuali tentativi di sfumature riempitive si risolvono nell’accumulo di segni fittissimi che ricordano una volta stampati le antiche incisioni su legno e non danno quindi né movimento né profondità alle immagini.
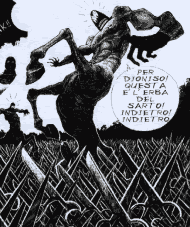 Ben diverso il trattamento grafico dei racconti brevi (dalle tre alle sei tavole) che completano il volume. Qui le sfumature sono infatti un elemento fondamentale del disegno, che dimostra quindi dove siano le sue radici, cioè nell’illustrazione. Il vello del capro montato da Fenicio Plusvalia (protagonista del primo di questi racconti brevi, che per scelta o per una svista è privo di titolo) è reso con una grande perizia ed i graffi bianchi della luce non solo rendono con un buon realismo l’idea del pelo, ma suggeriscono con estrema abilità i chiari e gli scuri, e quindi la profondità. Un altro esempio della grande cura profusa nella realizzazione di queste storie (che si manifesta non solo con uno sfumato efficace ma anche con un maggiore equilibrio espressivo tra bianco e nero) è l’immagine del mare nella splash page che apre Los Fugitivos del Reino. Le acque solcate dai motoscafi ed i riflessi che invece compaiono nelle zone calme rendono veramente l’idea del mare, soggetto tra i più ostici da raffigurare, ancora più difficile da rappresentare con dei semplici colpi di raschietto.
Ben diverso il trattamento grafico dei racconti brevi (dalle tre alle sei tavole) che completano il volume. Qui le sfumature sono infatti un elemento fondamentale del disegno, che dimostra quindi dove siano le sue radici, cioè nell’illustrazione. Il vello del capro montato da Fenicio Plusvalia (protagonista del primo di questi racconti brevi, che per scelta o per una svista è privo di titolo) è reso con una grande perizia ed i graffi bianchi della luce non solo rendono con un buon realismo l’idea del pelo, ma suggeriscono con estrema abilità i chiari e gli scuri, e quindi la profondità. Un altro esempio della grande cura profusa nella realizzazione di queste storie (che si manifesta non solo con uno sfumato efficace ma anche con un maggiore equilibrio espressivo tra bianco e nero) è l’immagine del mare nella splash page che apre Los Fugitivos del Reino. Le acque solcate dai motoscafi ed i riflessi che invece compaiono nelle zone calme rendono veramente l’idea del mare, soggetto tra i più ostici da raffigurare, ancora più difficile da rappresentare con dei semplici colpi di raschietto.
Anche a livello di storie i racconti brevi sono più complessi, non foss’altro per la durata maggiore, delle gag di Fortuna. Qui c’è un sarcasmo (pur se palesato manifestamente solo nella storia senza titolo di cui sopra) piuttosto tagliente, indirizzato principalmente contro l’arrivismo ed il conformismo ed un altro più sottile, che non è al centro delle storie, riservato ai maschi.
 E’ evidente anche una maggiore partecipazione della Colino alle storie che narra ed una di esse (Papà vuole che lavori, una sorta di poesia illustrata) ha per protagonista proprio la disegnatrice, che si ritrae (come nella serie Los Misterios de Ashley House) con fattezze molto più “disastrose” di quanto sono in realtà. Questa surreale storiellina in rima e la successiva, Solitudine, sembrano a prima vista un cedimento all’autocommiserazione ed al facile effetto sentimentalistico ma anche stavolta le trovate grafiche e quelle contenutistiche sono troppo esasperate per non strappare un sorriso al lettore: Vittorino, il penoso protagonista di Solitudine (che a tratti si abbandona a momenti di “polimorfismo espressivo” degni di un manga ), cerca in tutte le maniere di essere amato o quantomeno accettato dagli altri ed invece persino il suo pappagallo si uccide pur di non dover più sopportare la sua mesta figura! Con una premessa del genere il finale del racconto, che in un altro contesto sarebbe stato tragico, diventa un lieto fine.
E’ evidente anche una maggiore partecipazione della Colino alle storie che narra ed una di esse (Papà vuole che lavori, una sorta di poesia illustrata) ha per protagonista proprio la disegnatrice, che si ritrae (come nella serie Los Misterios de Ashley House) con fattezze molto più “disastrose” di quanto sono in realtà. Questa surreale storiellina in rima e la successiva, Solitudine, sembrano a prima vista un cedimento all’autocommiserazione ed al facile effetto sentimentalistico ma anche stavolta le trovate grafiche e quelle contenutistiche sono troppo esasperate per non strappare un sorriso al lettore: Vittorino, il penoso protagonista di Solitudine (che a tratti si abbandona a momenti di “polimorfismo espressivo” degni di un manga ), cerca in tutte le maniere di essere amato o quantomeno accettato dagli altri ed invece persino il suo pappagallo si uccide pur di non dover più sopportare la sua mesta figura! Con una premessa del genere il finale del racconto, che in un altro contesto sarebbe stato tragico, diventa un lieto fine.
Le ultime due storie di Rabia Maxima, Fatti del Peloponneso e Los Fugitivos del Reino, sono invece smaccatamente umoristiche e provocatorie. Poiché entrambe hanno il loro punto di forza narrativo nella sorpresa finale, sarebbe crudele rivelare come si concludono, basterà dire che i protagonisti sono, nel primo “sketch”, degli agguerriti centauri e delle furbe amazzoni, con addosso sottili capi d’abbigliamento tra il neoclassico ed il sadomaso. In Los Fugitivos del Reino i personaggi principali sono invece una coppia di diavoli in fuga che si ritrova in compagnia dei due clandestini Ariel (un angelo disertore) ed Antonino (un beato pentito), anch’essi in fuga ma verso una destinazione ben diversa da quella dei diavoli… Assolutamente irresistibile la visione che la Colino dà dei meccanismi che regolano inferno e paradiso, rappresentati come una rigida gerarchia tecnologizzata e fortemente militarista.
 Dalla lettura di queste ultime storie che concludono il volume Rabia Maxima si capisce anche quanto fascino debbano esercitare su Maria Colino la mitologia e la cosmologia, passioni che la accomunano ad altri grandi disegnatori visionari come Lucho Olivera, Enki Bilal e soprattutto Philippe Druillet. E il paragone con questi Maestri viene retto benissimo.
Dalla lettura di queste ultime storie che concludono il volume Rabia Maxima si capisce anche quanto fascino debbano esercitare su Maria Colino la mitologia e la cosmologia, passioni che la accomunano ad altri grandi disegnatori visionari come Lucho Olivera, Enki Bilal e soprattutto Philippe Druillet. E il paragone con questi Maestri viene retto benissimo.
Di Maria Colino in Italia possiamo leggere per il momento solo il volume di Jorge Vacca ma speriamo che l’interesse che ha suscitato solleciti altre pubblicazioni quanto prima (tanto più che lo scorso anno in Spagna la giovane disegnatrice è stata oggetto di pubblicazioni prestigiose, ristampe e riproposizioni con altri editori).


