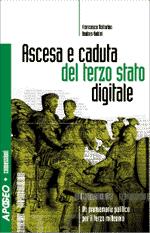
“É Marx messo a testa in giù.”
Così scrive Alvin Toffler su «New Scientist», il 19 marzo 1994. “[…] è la cultura che sempre di più guida la tecnologia e l’economia. L’economia si basa sulla conoscenza e questa si basa sulla cultura”. Questa di Toffler, assieme a mille altre considerazioni importanti (da quelle in Prefazione, di Marco Cattaneo, «Le Scienze», alle lezioni di Thomas S. Kuhn, a quelle di Vannevar Bush, di Martin Greenberger o Giuseppe Caravita, sono contenute nel bel libro di Francesco Bollorino e Andrea Rubini, Ascesa e caduta del terzo stato digitale , per APOGEO. Un libro che oltre a costituire un promemoria politico per il terzo millennio, ci spiega — tra le tante cose — come la Cambogia, proveniente da “trent’anni di sanguinose guerre civili, di repressione e di arretramento culturale ed economico” sia oggi un florilegio di scuole d’informatica; come Internet sia arrivato in Bhutan, paese arrampicato sulle pendici d’Himalaia; come esista miracolosamente in Nepal (45.000 abbonati su 600.000 abitanti), o in Bangladesh e come, a fronte dei 165 milioni di unità connesse in rete oggi, per il 2005 se ne prevedano addirittura il doppio.
Internet come evento rivoluzionario, dunque, che segna l’avvento della società dell’informazione postindustriale, che non rappresenta un evento solamente “cumulativo” del vecchio “paradigma sociale” ma uno scarto culturale, politico, oltre che tecnologico, paragonabile per portata all’avvento della stampa; che, soprattutto, nel gennaio del 1993 contava ancora un milione e trecentomila host di pubblico dominio a disposizione nel DNS, mentre nel gennaio del 1999 questi erano diventati 43 milioni. A dire, insomma, che la nascita del “terzo stato digitale”, quello appunto d’una “borghesia digitale”, “trasversalmente diffuso sul pianeta sempre più disgiunto dalla realtà socio-economica in cui opera, anche a causa dei processi di globalizzazione” è processo che, con i rischi annessi e connessi, deve esser tenuto ben presente e che necessariamente dovrà portare ad un ripensamento complessivo dei rapporti di forza all’interno della public sphere. Così Bollorino e Rubini, portandoci per mano tra comunità della bohemia artistica di San Francisco degli anni ’60, come i Diggers di Haight Ashbury, o nei manifesti delle comunità hackers, tracciano con capacità l’identikit della borghesia digitale, senza rinunciare, in tutta onestà, a rilevare gli aspetti discriminanti del mezzo, come quelle tariffe di accesso al servizio di rete attraverso uno dei 12 Internet Service Provider in Bangladesh, che sono di circa 11 dollari ogni 10 ore mensili. Il che vuol dire, su base annua, la metà del PIL procapite del paese del subcontinente indiano. Ma se il medium non è ancora a disposizioni di tutti, va detto che i due autori sottolineano come sia avversato proprio dai regimi militari dittatoriali (esemplare il caso riportato dello SLORC, State Law League and Order Restoration Council, sorta di giunta militare birmana). Da regimi che ne avversano l’insorgenza nel disegno complessivo d’un controllo dell’informazione che, tuttavia, proprio nei confronti di Internet, potrà poco (l’unico modo per lo SLORC birmano per porre dei paletti alla circolazione delle notizie, peraltro facilmente raggirabili, è vietare il possesso nel paese di fax e modem non autorizzati, comminando ai trasgressori pene detentive che vano fino ai 15 anni). Le problematiche politiche ed economiche connesse alla rete e all’informazione (infopoveri e inforicchi; condizionamenti a valenza non democratica sulla rete; neo-potentati; autostrade informatiche; gruppi in esilio; gift economy; regolamentazione alla deregulation; modelli di rappresentanza e di progettualità politica, ecc.) sono questioni che il lettore troverà analizzate e discusse in un libro prezioso e di agile lettura (a momenti i due autori si concedono addirittura pause letterarie: si legga Intermedio, nelle pagg.115-123, diario di Gigi che vive “in un autoappartamento di classe C”), cosicché l’opera pare tutt’altro che indirizzata al solo addetto ai lavori. (M.S.)
Francesco Bollorino, Andrea Rubini, Ascesa e caduta del terzo stato digitale, Apogeo, Milano 1999, lire 28.000
Guida alla lettura proposta dagli autori
Questo libro nasce in rete.
Prima di tutto perché i due autori si sono conosciuti sul net essendo, all’epoca, l’uno impegnato come responsabile di un progetto di cooperazione internazionale in quel di Katmandu, Nepal ed essendo l’altro collaboratore de “LE SCIENZE” residente a Genova, Italia; dal fitto scambio di e-mail, servito primariamente per fare amicizia e per scoprire interessi comuni ed il desiderio di collaborare ad un progetto culturale, è nata l’idea del libro molto prima che, dopo il ritorno di Andrea Rubini in Italia, potesse avvenire un incontro “fisico”, sotto gli ulivi assolati della Riviera Ligure, di progettazione dell’opera.
Questo libro nasce in rete.
Soprattutto dal web, da quell’infinita libreria di documenti che vi sono depositati, è stata tratta buona parte della bibliografia e delle fonti che hanno fatto da supporto, chiarimento e approfondimento dei temi trattati nell’opera, che molto deve a questa miriade di ricercatori dei quattro angoli del mondo, spesso per noi solo “un testo”, un rinvio, un “mailto:” nascosto in fondo ad una pagina in questo mondo virtuale costruito con parole tra loro interconnesse, che hanno reso disponibile on line il loro sapere: è stato bello scoprire tanto “pensiero convergente”, proveniente da ambiti culturali e sociali spesso molto diversi, è stato culturalmente educativo verificare le enormi potenzialità di recupero di dati e documenti, spesso non reperibili altrove, offerte dalle raffinate tecniche dell’information technology, è stato personalmente formativo testare, ancora una volta, le possibilità di usare, con vantaggio, la rete come luogo di lavoro, visto che tutta la gestione editoriale dell’opera è avvenuta on line sia tra gli autori che con la redazione della casa editrice, riducendo la necessità di incontro allo stretto indispensabile o al reciproco piacere di vedersi di persona.
Tipicamente ipertestuale è, per altro, la struttura dell’opera con tre livelli di lettura: il primo è rappresentato dal testo principale, cui si affiancano altri due livelli di approfondimento rappresentati dalle note in calce alle pagine e dalle schede in coda ad ogni capitolo, questo sistema, lungi dal voler essere un percorso obbligato per i lettori, permette gradi di fruizione diversificati in virtù della conoscenza dei temi o del desiderio di scavare all’interno del dato presentato.
Un discorso a parte meritano i brani a volte molto brevi, a volte più lunghi che abbiamo voluto inserire quali citazioni a capo di ogni capitolo: un tributo dovuto ai testi che hanno rappresentato il segnapasso della ricerca che sta dietro alle pagine di questo volume, un’ulteriore invito per il lettore ad un approfondimento personale delle tematiche in esso contenute.
Infine un accenno alla strutturazione “musicale” dell’opera: “ouverture”, “intermedio” e “finale” sono i titoli che abbiamo dato alle componenti narrative inserite nel testo, si tratta di un breve racconto con aspetti autobiografici e di due favole che lungi dal porsi al di fuori del percorso dell’opera vogliono offrire al lettore “altre assonanze” con cui confrontarsi nell’ottica, per altro, di una lettura unificata ed unificante di un testo che ha nella problematicità degli assunti e nella strutturazione aperta dei contenuti presentati la sua sostanziale chiave di lettura che contiamo coinvolga i lettori e li stimoli ad un confronto.
Questo libro nasce in rete e ha, infatti, nella rete la sua naturale prosecuzione.
Sul sito di Apogeo sono state approntate, appositamente e contestualmente all’uscita del libro, pagine web (http://www.apogeonline.com/terzostato/indice.html) dove, tra le altre cose, potrete trovare, puntualmente commentati ed introdotti links verso siti da cui abbiamo tratto le informazioni che hanno costituito l’ossatura portante del nostro lavoro: un’utile sistema, a parere degli scriventi, per consentire un’ulteriore approfondimento personale sugli argomenti trattati nell’opera, anche allo scopo di condividere con gli utenti della rete, lettori della presente opera o no, il frutto del nostro lavoro di ricerca.
Sempre dalle pagine web e’ possibile iscriversi ad una specifica mailing list dove poter dibattere e discutere con gli autori, in totale libertà, le tematiche che abbiamo qui sviluppato e che consideriamo un punto di partenza più che un punto d’arrivo per lo sviluppo di un pensiero partecipato e cooperativo sugli sviluppi futuri della “vita sullo schermo”.


