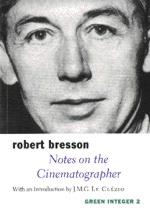 Nel mondo luccicante del cinema Robert Bresson è una presenza appartata. Ma è cruciale la posizione che occupa nella giovane storia di questo linguaggio. Parlandone come di “un regista a parte in questo mestiere terribile”, Jean Cocteau ne spiegava anche la ragione fondamentale. “Si esprime con il cinematografo come un poeta fa con la penna”. Usa la macchina del cinema come mezzo di scrittura anziché come strumento per fare spettacolo. Rigoroso e riservato, coerente fino all’intransigenza, non negozia nulla, non scende a patti con lo spettatore. Forse nemmeno con se stesso, sottomesso anch’egli al superiore dettato dal linguaggio. Bresson rifiuta ogni transizione mettendo a rischio la comunicazione. Deluso nelle sue attese, lo spettatore abituato alle convenzioni — a ciò che si conviene — appare spaesato.
Nel mondo luccicante del cinema Robert Bresson è una presenza appartata. Ma è cruciale la posizione che occupa nella giovane storia di questo linguaggio. Parlandone come di “un regista a parte in questo mestiere terribile”, Jean Cocteau ne spiegava anche la ragione fondamentale. “Si esprime con il cinematografo come un poeta fa con la penna”. Usa la macchina del cinema come mezzo di scrittura anziché come strumento per fare spettacolo. Rigoroso e riservato, coerente fino all’intransigenza, non negozia nulla, non scende a patti con lo spettatore. Forse nemmeno con se stesso, sottomesso anch’egli al superiore dettato dal linguaggio. Bresson rifiuta ogni transizione mettendo a rischio la comunicazione. Deluso nelle sue attese, lo spettatore abituato alle convenzioni — a ciò che si conviene — appare spaesato.
 Ma se non si irrigidisce e abbandona il porto sicuro di ciò che è già stato convenuto, allora il paese straniero in cui Bresson lo conduce si rivela in tutta la sua bellezza. Nato nel 1901, all’alba del secolo, dopo un periodo dedicato alla pittura, Bresson approda al cinema; realizza tredici lungometraggi tra il 1943 e il 1983; quarant’anni nei quali il passaggio dal cinema classico alla stagione della modernità segna profondamente anche la sua opera e riceve da lui un apporto determinante. Nel suo lavoro questa transizione assume i connotati di una critica radicale al cinema stesso.
Ma se non si irrigidisce e abbandona il porto sicuro di ciò che è già stato convenuto, allora il paese straniero in cui Bresson lo conduce si rivela in tutta la sua bellezza. Nato nel 1901, all’alba del secolo, dopo un periodo dedicato alla pittura, Bresson approda al cinema; realizza tredici lungometraggi tra il 1943 e il 1983; quarant’anni nei quali il passaggio dal cinema classico alla stagione della modernità segna profondamente anche la sua opera e riceve da lui un apporto determinante. Nel suo lavoro questa transizione assume i connotati di una critica radicale al cinema stesso.
Dopo l’esordio sotto il segno del “comico folle”, i primi film, quelli girati negli anni Quaranta, maturano nel solco della tradizione, sia pure esaltata e sublimata, portata a un livello di depurazione così alto che già prefigura lo stile inconfondibile della sua scrittura. Le tracce di una nuova forma dell’espressione si intensificano di film in film nel decennio successivo producendo una graduale ma inesorabile opera di smantellamento delle regole e convenzioni consolidate. La contestazione tocca tutti gli essenziali elementi di base del linguaggio cinematografico.
 La macchina da presa non va usata per riprodurre una scena che davanti ad essa va allestita: si cadrebbe nel detestato ibrido del teatro filmato. Va impiegata invece per creare un mondo possibile attraverso la giuntura poetica dei frammenti che essa cattura. Niente più attori professionisti. Niente attori del tutto, né recitazione. Nessuno che finga, che si sforzi di apparire un altro, quello che non è. Solo “modelli”: persone che si danno allo sguardo nel loro essere. Niente musica di commento, ma suoni e rumori impiegati come una partitura musicale. Immagini e suoni devono integrarsi e darsi il cambio evitando quella ridondanza così usuale e diffusa che ormai “si guarda senza vedere, si ascolta senza sentire”.
La macchina da presa non va usata per riprodurre una scena che davanti ad essa va allestita: si cadrebbe nel detestato ibrido del teatro filmato. Va impiegata invece per creare un mondo possibile attraverso la giuntura poetica dei frammenti che essa cattura. Niente più attori professionisti. Niente attori del tutto, né recitazione. Nessuno che finga, che si sforzi di apparire un altro, quello che non è. Solo “modelli”: persone che si danno allo sguardo nel loro essere. Niente musica di commento, ma suoni e rumori impiegati come una partitura musicale. Immagini e suoni devono integrarsi e darsi il cambio evitando quella ridondanza così usuale e diffusa che ormai “si guarda senza vedere, si ascolta senza sentire”.
Come il suono, anche l’immagine viene impiegata in funzione evocativa, scaricata dal dovere di rappresentare. Le immagini non si esauriscono in ciò che mostrano, ma rinviano all’invisibile. La regia allora non è più organizzazione e direzione di una messa in scena, ma tessitura di immagini e suoni orchestrati per dare a questo linguaggio la potenza di una lingua. Un tentativo arduo, una prova rischiosa, una vera sfida.
 Il cinematografo di Bresson che così prende forma si offre come una interruzione nella linea di sviluppo del cinema tutto proiettato verso una incessante conquista del visibile. I suoi film costituiscono un punto di catastrofe nella storia del cinema. La provocazione lanciata contro “tutta una critica che non fa distinzione tra cinema e cinematografo” rende legittimo chiedersi se lui appartenga alla storia del cinema o non sia piuttosto un corpo estraneo, inintegrabile. Il percorso compiuto da Bresson dentro il linguaggio specchia una parallela evoluzione sul piano del pensiero.
Il cinematografo di Bresson che così prende forma si offre come una interruzione nella linea di sviluppo del cinema tutto proiettato verso una incessante conquista del visibile. I suoi film costituiscono un punto di catastrofe nella storia del cinema. La provocazione lanciata contro “tutta una critica che non fa distinzione tra cinema e cinematografo” rende legittimo chiedersi se lui appartenga alla storia del cinema o non sia piuttosto un corpo estraneo, inintegrabile. Il percorso compiuto da Bresson dentro il linguaggio specchia una parallela evoluzione sul piano del pensiero.
Fino al Procès de Jeanne d’Arc i suoi eroi approdano, sia pure in forme diverse, alla salvezza. Come Jeanne d’Arc, anche la novizia e il curato vincono nella estrema perdita e testimoniano col loro sacrificio la possibilità della redenzione. Nelle Dames du Bois de Boulogne il sentimento ha ragione del sentimento. Il condannato si conquista la libertà e uno “strano percorso” conduce il borsaiolo alla propria meta.
 A partire da Au hasard Balthazar sembra che nessun calvario possa riscattare un universo terreno governato dal male. Nessuna Passione, nessuna salita al Golgota può salvarlo. La morte è spesso un suicidio con cui il protagonista si libera di un mondo che appare irredimibile: Mouchette, Une femme douce, Le diable probablement. Il male che dilaga assume sempre più chiaramente le sembianze del denaro fino alla loro netta identificazione nell’Argent. È lui, probabilmente, il diavolo che ci governa. La Grazia ha abbandonato il mondo. Mentre dunque agli occhi di Bresson il mondo è andato degradandosi riducendo le speranze di salvezza, lui ha continuato la sua opera di sovversione del linguaggio del cinema anche per dire in forme sempre più terse e sublimi questa verità amara.
A partire da Au hasard Balthazar sembra che nessun calvario possa riscattare un universo terreno governato dal male. Nessuna Passione, nessuna salita al Golgota può salvarlo. La morte è spesso un suicidio con cui il protagonista si libera di un mondo che appare irredimibile: Mouchette, Une femme douce, Le diable probablement. Il male che dilaga assume sempre più chiaramente le sembianze del denaro fino alla loro netta identificazione nell’Argent. È lui, probabilmente, il diavolo che ci governa. La Grazia ha abbandonato il mondo. Mentre dunque agli occhi di Bresson il mondo è andato degradandosi riducendo le speranze di salvezza, lui ha continuato la sua opera di sovversione del linguaggio del cinema anche per dire in forme sempre più terse e sublimi questa verità amara.

