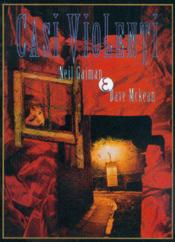 Un volumetto cartonato di 44 tavole, una copertina prevalentemente rossa e nera che raffigura le solite, inconfondibili stranezze grafiche e due nomi che abbiamo spesso visto accomunati durante l’ultimo decennio: Neil Gaiman e Dave McKean.
Un volumetto cartonato di 44 tavole, una copertina prevalentemente rossa e nera che raffigura le solite, inconfondibili stranezze grafiche e due nomi che abbiamo spesso visto accomunati durante l’ultimo decennio: Neil Gaiman e Dave McKean.
Quello che abbiamo tra le mani, tuttavia, è il loro primissimo lavoro, per la prima volta in Italia dopo dodici anni (otto, se consideriamo che la prima edizione a colori, quella americana pubblicata dalla Tundra, è del 1991, ed è quella considerata definitiva dagli autori). Una piccola gemma, una graphic-novel di dimensioni ridotte preziosa anche per chi ha avuto modo di godere, a suo tempo, della versione USA. Preziosa perché, oltre a testimoniare lo straordinario valore degli autori fin dall’esordio, lascia ben sperare in una futura edizione italiana delle loro collaborazioni successive. Certo, la qualità si paga: 22.000 lire non sono pochissime in rapporto alla quantità del materiale, ma per ora ringraziamo la Magic Press e tiriamo avanti, perché gli spropositi sono altri (mi riferisco alle 50.000 per “300” di Frank Miller, aggravate dal fatto che si attendeva un’opera sull’antica Grecia dai tempi di “Sesso e sangue a Sin City”, cap.5 e finale).
Il sempre puntuale Pasquale Ruggiero, fonte inesauribile di informazioni sulle zone d’ombra dei fumetti che produce (indispensabili, ad esempio, per districarsi nel continuo trip di “The invisibles”), ci fa notare l’assonanza tra l’originale “Violent Cases” e “violin cases”, ovvero le custodie di violino in cui i gangsters sono soliti — nella tradizione di un immaginario anche cinematografico — riporre l’immancabile mitra. Allora “Casi violenti” è una gangter-story? Non precisamente. O meglio, non solo: è un ricordo di infanzia, ma è anche una storia sull’ infanzia, ed è anche un abile saggio di destrezza narrativa sull’arte di raccontare e di saper ascoltare.
l’originale “Violent Cases” e “violin cases”, ovvero le custodie di violino in cui i gangsters sono soliti — nella tradizione di un immaginario anche cinematografico — riporre l’immancabile mitra. Allora “Casi violenti” è una gangter-story? Non precisamente. O meglio, non solo: è un ricordo di infanzia, ma è anche una storia sull’ infanzia, ed è anche un abile saggio di destrezza narrativa sull’arte di raccontare e di saper ascoltare.
La storia si dipana attraverso il racconto in prima persona di un uomo — in tutto e per tutto simile a Neil Gaiman — che rievoca un preciso periodo della propria infanzia, non eccessivamente traumatica ma certamente caratterizzata da una presenza adulta (i genitori e i loro amici, i nonni) sorda alle domande dei bambini.
Saper ascoltare: l’unico che ne sembra in grado è un anziano fisiatra (il ragazzino ha un braccio slogato per colpa del padre), capace di degnare il piccolo protagonista della giusta considerazione, e che coglie l’occasione per raccontarci di quando Al Capone era suo cliente abituale. Di nuovo, saper ascoltare: l’unico modo per meritarsi una storia. E una storia nella storia: il protagonista, narratore da adulto, ascoltatore da bambino, ci conduce nel panorama indefinito dei ricordi più distanti, fatti di nebbie (e i colori e il tratto di Dave McKean rendono l’idea), di spazi vuoti, di pezzi mancanti, di realtà deformata dal tempo e dallo sguardo infantile. E così il mondo “dei grandi” diviene “più grande”, nelle sue insolite prospettive, nella magia che attraversa la quotidianità, spaventoso e al tempo stesso attraente come mai più lo sarà. Quindi, il mago che ci fa paura diviene anche qualcosa da sbirciare da dietro le tende, magari un po’ defilati, perché non si sa mai che ci veda.

|
“è bene che le cose pericolose vadano sbirciate da dietro i divani, o da sotto le coperte: bisogna mettersi in posizione tale da poterle guardare, se si vuole, ma senza che loro possano vedere te” |
Un’atmosfera che, personalmente, mi ha consentito di rievocare le sensazioni provate di fronte a film come “Stand by me”, o qualche film di Truffaut. Sicuramente Gaiman (insieme ai sudamericani, in un contesto differente) è uno degli sceneggiatori più capaci nell’affrontare e nel cogliere con sensibilità le sfumature — troppo spesso dimenticate — dell’innocenza infantile. “Casi violenti” diviene così un fumetto non solo sull’infanzia, ma di riflesso sulla curiosità, quella che caratterizza anche il mestiere del narratore, e che consente di vedere il mondo come un insieme di storie degne di essere tramandate. “Per me, il mondo è composto di storie”, ci dice Gaiman1: non ci spiegheremmo altrimenti come tutto — dalla quotidianità alle efferatezze di Al Capone, pur nella crudezza di un nuovo registro grafico adottato da McKean — scivoli via, come una favola a tratti un po’ lugubre, ma innocua, perché se l’orco cattivo esiste è ormai morto e sepolto, anche se alla fine pare che i gangsters vengano a prendersi il fisiatra. Che forse non farà una bella fine, ma almeno da piccoli il ricordo — o meglio il sentore — della morte può essere esorcizzato, e perdersi in qualche immagine indistinta, in qualche vignetta nera.

|
“… e a quel punto, lottando per restare lucidi, con la speranza che non finisca mai, certi che il sogno, una volta interrotto, non tornerà mai più, …vi svegliate. Ed è un nuovo inizio.” |
Tutte le opere di Neil Gaiman sono riflessioni sull’arte della narrazione: evidentemente in perenne ricerca, pur sapendo benissimo cosa vuole, Gaiman pone — e ci pone — una serie di interrogativi intrecciati con enorme talento in un tessuto tanto perfetto (tanto naturale, tanto necessario) da apparire realizzato con estrema semplicità. A volte sembra dotato di vita propria, destinato ad accrescersi autonomamente, ma stiamo pur certi che Gaiman sa bene quando tirare a sé i fili e dare una conclusione al tutto. Lo ha sempre fatto: l’unico suo personaggio che avrebbe potuto ribellarsi e tentare di sopravvivere al proprio destino — in quanto egli stesso creatore di forme, mi sto ovviamente riferendo a Sandman — si è dovuto rassegnare alla propria sorte, al definitivo taglio della matassa. L’Autore, o se vogliamo una sua prospettiva, deve morire — staccarsi dall’opera — per dare senso e vera autonomia alla propria creatura, e solo in seguito passare il testimone (il figlio di Sandman); l’autore, quello in carne ed ossa, deve essere in grado di resistere alla tentazione di compiere un passo di troppo e rovinare tutto. Se poi la storia dovrà proseguire, lo farà reggendosi sulle proprie gambe, nei sogni di qualcun altro.
 È questo l’insegnamento, a posteriori presente in ogni suo lavoro, dell’autore britannico: un plauso alla sua coerenza (aveva promesso una durata limitata per Sandman e ha mantenuto la parola) e alla sua capacità di regalarci queste gemme perfettamente compiute. Sul fronte grafico, il talento di Dave McKean non si discute: illustratore, fotografo, grafico al computer, eclettico nello spaziare tra tecniche diverse, come risulta evidente nella globalità del suo lavoro. Qui il tratto — spesso il tratteggio — si fa talvolta nervoso ma al tempo stesso sicuro, capace di abbozzare strutture complesse con rapidi cenni di matita, acquerellata in blu, nero, marrone; rielaborato, questo stile può ricondurre alle mezzetinte delle sequenze iniziali di “Arkham Asylum”. Altre volte, ma più raramente, il segno è essenziale, scarno, con i retini volutamente eccessivi della quattordicesima tavola. Altrove — le scene di Capone — le linee si spezzano, si induriscono, e le superfici perdono la morbidezza di pastello e colori ad acqua per estendersi in larghi spazi dominati dal nero, dal crudo contrasto col bianco, dall’intrusione di linee di color rosso scuro.
È questo l’insegnamento, a posteriori presente in ogni suo lavoro, dell’autore britannico: un plauso alla sua coerenza (aveva promesso una durata limitata per Sandman e ha mantenuto la parola) e alla sua capacità di regalarci queste gemme perfettamente compiute. Sul fronte grafico, il talento di Dave McKean non si discute: illustratore, fotografo, grafico al computer, eclettico nello spaziare tra tecniche diverse, come risulta evidente nella globalità del suo lavoro. Qui il tratto — spesso il tratteggio — si fa talvolta nervoso ma al tempo stesso sicuro, capace di abbozzare strutture complesse con rapidi cenni di matita, acquerellata in blu, nero, marrone; rielaborato, questo stile può ricondurre alle mezzetinte delle sequenze iniziali di “Arkham Asylum”. Altre volte, ma più raramente, il segno è essenziale, scarno, con i retini volutamente eccessivi della quattordicesima tavola. Altrove — le scene di Capone — le linee si spezzano, si induriscono, e le superfici perdono la morbidezza di pastello e colori ad acqua per estendersi in larghi spazi dominati dal nero, dal crudo contrasto col bianco, dall’intrusione di linee di color rosso scuro.
Non mancano, tuttavia, le usuali divagazioni grafiche (un vero e proprio eccesso di informazioni visive, solitamente ad accompagnare una proiezione mentale in maniera evocativa anziché descrittiva) fatte di tutto ciò di cui è fatta la copertina: fotografie ritoccate, computer, collages, tessuti, radiografie (immancabili, vedere i volumi di Sandman). Tori Amos, i Rolling Stones e Stephen King, in diverse circostanze beneficiari dell’arte di McKean, ne sono testimoni. Né più varia potrebbe essere la costruzione della tavola: le vignette sono montate orizzontalmente, verticalmente o anche più arbitrariamente, ovvero senza particolare rispetto (a prima vista) di proporzioni e/o distanze.  Sovrapposte, isolate nel bel mezzo della pagina, in sequenze più o meno lunghe, esse sono, tuttavia, pensate in costante rapporto con lo sfondo, sia esso un’ulteriore vignetta senza bordi, un semplice elemento decorativo o una distesa nera. Una dialettica forte, ma anche necessaria ad accogliere una notevole quantità di testo scritto, vera e propria unità di montaggio che contribuisce a fornire al lettore l’andamento complessivo e la direzionalità della tavola. Memorabile, nell’ambito del montaggio verticale, la scena dello scambio di banconote.
Sovrapposte, isolate nel bel mezzo della pagina, in sequenze più o meno lunghe, esse sono, tuttavia, pensate in costante rapporto con lo sfondo, sia esso un’ulteriore vignetta senza bordi, un semplice elemento decorativo o una distesa nera. Una dialettica forte, ma anche necessaria ad accogliere una notevole quantità di testo scritto, vera e propria unità di montaggio che contribuisce a fornire al lettore l’andamento complessivo e la direzionalità della tavola. Memorabile, nell’ambito del montaggio verticale, la scena dello scambio di banconote.
Mano a mano che il racconto del fisiatra si infittisce, aumenta vistosamente la presenza sullo sfondo di locandine cinematografiche ad accompagnare il testo, mai arbitrarie nel loro apparire, ma ogni volta consone alla circostanza che ne viene così ulteriormente rafforzata. Possiamo così notare, tra gli altri, i manifesti de “Il mistero del falco”, “La storia del generale Custer”, “Nemico pubblico”, “L’uomo che sapeva troppo”. Lo stesso personaggio narrante, improvvisamente trasfigurato dal ricordo, diventa identico a Peter Lorre (alle sue spalle una locandina: “Wine of youth”). Una prosa come quella di Gaiman andrebbe letta in inglese, ma la traduzione è sicuramente all’altezza; traduzione che, invece, non arriva per “From Hell”, il capolavoro di Alan Moore perennemente segnalato nei prossimi arrivi delle fumetterie, la cui trasposizione nella nostra lingua crea evidentemente grossi grattacapi a chi di dovere. La notizia proviene proprio da Lucca, dove tutti si aspettavano invece il definitivo annuncio dell’uscita. Peccato, sarebbe stato veramente un Novembre perfetto.
segnalato nei prossimi arrivi delle fumetterie, la cui trasposizione nella nostra lingua crea evidentemente grossi grattacapi a chi di dovere. La notizia proviene proprio da Lucca, dove tutti si aspettavano invece il definitivo annuncio dell’uscita. Peccato, sarebbe stato veramente un Novembre perfetto.


