 “Un tempo Valery voleva diventare ufficiale di marina. In quello che è diventato si possono ancora riconoscere i segni di questo sogno giovanile. Anzitutto nella sua poesia, nella contenuta ricchezza delle sue forme che il linguaggio prende al pensiero come il mare alla bonaccia; e in secondo luogo in questo suo pensiero, un pensiero spiccatamente matematico, che si curva sui fatti come se fossero carte nautiche, e senza compiacersi alla vista delle ‘profondità’ è già felice di poter seguire una rotta non pericolosa.” Così inizia un saggio del ’31 dedicato alla poesia di Paul Valery (2), con questa metafora di cui si serve in un gioco abilissimo, alternante. E nel teorico di quella che appare la quintessenza della poesia pura, “quasi avventurosamente, eppure metodicamente” si approfondisce il dubbio cartesiano, fino a diventare dubbio sulla stessa questione, sul domandare: “Bisogna formare, dentro di sé, una domanda che preceda tutte le altre e domandi a ciascuna di esse qual è la sua validità”. Fino a portare il ricercatore al di là di se stesso.
“Un tempo Valery voleva diventare ufficiale di marina. In quello che è diventato si possono ancora riconoscere i segni di questo sogno giovanile. Anzitutto nella sua poesia, nella contenuta ricchezza delle sue forme che il linguaggio prende al pensiero come il mare alla bonaccia; e in secondo luogo in questo suo pensiero, un pensiero spiccatamente matematico, che si curva sui fatti come se fossero carte nautiche, e senza compiacersi alla vista delle ‘profondità’ è già felice di poter seguire una rotta non pericolosa.” Così inizia un saggio del ’31 dedicato alla poesia di Paul Valery (2), con questa metafora di cui si serve in un gioco abilissimo, alternante. E nel teorico di quella che appare la quintessenza della poesia pura, “quasi avventurosamente, eppure metodicamente” si approfondisce il dubbio cartesiano, fino a diventare dubbio sulla stessa questione, sul domandare: “Bisogna formare, dentro di sé, una domanda che preceda tutte le altre e domandi a ciascuna di esse qual è la sua validità”. Fino a portare il ricercatore al di là di se stesso.
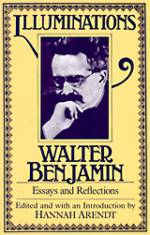 Scrittore — saggista, Benjamin vive nella Vienna di Musil, di Kraus, in una situazione di crisi, crisi delle strutture intere della società. Egli riconosce che non si può più giungere a sintesi grandiose, universali ed oggettive: la problematicità, il non concludere appaiono in lui come la conseguenza dell’impossibilità di compiutezza, della non definitezza dei risultati. Il suo lavoro si basa sull’interesse per il dramma barocco tedesco, i rapporti tra arte e tecnologia, i problemi della narrativa e dell’avanguardia, il rapporto critico con lo storicismo. Fa critica inventando un linguaggio, né didattico, né accademico, in cui i pensieri si rivestono di immagini, con uno stile secco e nitido, fatto di ellissi, di una brevità intensa: un mosaico, lo definisce Renato Solmi, suo traduttore.
Scrittore — saggista, Benjamin vive nella Vienna di Musil, di Kraus, in una situazione di crisi, crisi delle strutture intere della società. Egli riconosce che non si può più giungere a sintesi grandiose, universali ed oggettive: la problematicità, il non concludere appaiono in lui come la conseguenza dell’impossibilità di compiutezza, della non definitezza dei risultati. Il suo lavoro si basa sull’interesse per il dramma barocco tedesco, i rapporti tra arte e tecnologia, i problemi della narrativa e dell’avanguardia, il rapporto critico con lo storicismo. Fa critica inventando un linguaggio, né didattico, né accademico, in cui i pensieri si rivestono di immagini, con uno stile secco e nitido, fatto di ellissi, di una brevità intensa: un mosaico, lo definisce Renato Solmi, suo traduttore.
Se nell’Ottocento sono stati i romanzieri a darci delle forti metafore e immagini della nostra cultura, nel Novecento sono gli storici ed i ricercatori sociali, come Wilde, Veblen: così Neil Postman. (3)
 Esiste un forte legame tra metafora ed arte. In Benjamin il valore dell’immagine scaturisce da una educazione familiare di tipo artistico, il padre era mercante d’arte. Si consolida nella sua formazione attraverso il rapporto con il misticismo ebraico, simbolico e biblico, sollecitato dall’amicizia con Gershom Scholem, e l’attenzione verso le avanguardie, in particolare l’espressionismo, mediato da Ernst Bloch. Si esprime in un linguaggio chiuso, faticoso, labirintico. “Ogni verità ha il suo palazzo nella lingua”, dichiara. Questa concezione integrale della lingua, come espressione dell’unità profonda del reale, è di derivazione post-romantica, in parte tra Nietzsche ed il teologismo ebraico. In una sorta di nominalismo, la parola è la cosa, e la parola trova la sua espressione nel nome, che è tutto. La cifra del suo pensiero è l’allegoria.
Esiste un forte legame tra metafora ed arte. In Benjamin il valore dell’immagine scaturisce da una educazione familiare di tipo artistico, il padre era mercante d’arte. Si consolida nella sua formazione attraverso il rapporto con il misticismo ebraico, simbolico e biblico, sollecitato dall’amicizia con Gershom Scholem, e l’attenzione verso le avanguardie, in particolare l’espressionismo, mediato da Ernst Bloch. Si esprime in un linguaggio chiuso, faticoso, labirintico. “Ogni verità ha il suo palazzo nella lingua”, dichiara. Questa concezione integrale della lingua, come espressione dell’unità profonda del reale, è di derivazione post-romantica, in parte tra Nietzsche ed il teologismo ebraico. In una sorta di nominalismo, la parola è la cosa, e la parola trova la sua espressione nel nome, che è tutto. La cifra del suo pensiero è l’allegoria.
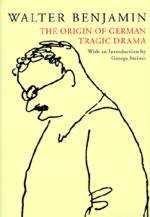 In Aristotele il rapporto arte — tecnica era il problema della tecnica nell’arte; i crociani, che risolvevano i problemi dell’arte in un contesto storicamente e culturalmente imposto, liquidavano la tecnica come momento secondario. Ma quando la tecnologia prevale, l’arte si trova in una situazione in cui non può più dominare e perde la sua autonomia: è il momento dell’egemonia della tecnica. Il Futurismo e il Bauhaus identificano funzionalità ed arte. In Italia il problema dell’estetica tecnologica è visto attraverso le posizioni di Morasso e Marinetti: per Morasso la macchina è come la Nike di Samotracia, la tecnologia si ricongiunge all’arte classica. La macchina è più bella della Nike di Samotracia, la macchina è alla base della nuova civiltà: Marinetti. In Germania, invece, il dibattito è più stimolante ed intenso: nel ’36, quando Benjamin scrive il suo saggio sull’opera d’arte, si trova in un momento intermedio. Il problema si pone in un modo nuovo: “La riproducibilità tecnica modifica il rapporto delle masse con l’arte”. Nel rapporto arte — tecnica si inserisce un terzo termine: industria — massa. Non si può pensare di realizzare in uno schema la complessità dei rapporti, in corrispondenza non univoca, che si creano tra arte — tecnica, tecnica — massa — industria, industria — massa — arte.
In Aristotele il rapporto arte — tecnica era il problema della tecnica nell’arte; i crociani, che risolvevano i problemi dell’arte in un contesto storicamente e culturalmente imposto, liquidavano la tecnica come momento secondario. Ma quando la tecnologia prevale, l’arte si trova in una situazione in cui non può più dominare e perde la sua autonomia: è il momento dell’egemonia della tecnica. Il Futurismo e il Bauhaus identificano funzionalità ed arte. In Italia il problema dell’estetica tecnologica è visto attraverso le posizioni di Morasso e Marinetti: per Morasso la macchina è come la Nike di Samotracia, la tecnologia si ricongiunge all’arte classica. La macchina è più bella della Nike di Samotracia, la macchina è alla base della nuova civiltà: Marinetti. In Germania, invece, il dibattito è più stimolante ed intenso: nel ’36, quando Benjamin scrive il suo saggio sull’opera d’arte, si trova in un momento intermedio. Il problema si pone in un modo nuovo: “La riproducibilità tecnica modifica il rapporto delle masse con l’arte”. Nel rapporto arte — tecnica si inserisce un terzo termine: industria — massa. Non si può pensare di realizzare in uno schema la complessità dei rapporti, in corrispondenza non univoca, che si creano tra arte — tecnica, tecnica — massa — industria, industria — massa — arte.
 Benjamin affronta la definizione del concetto di riproducibilità. Ogni opera d’arte è unica, ma può essere riproducibile. La riproducibilità di cui parliamo ora è invece condizionata dalla tecnica e dalla serialità. Con questi strumenti viene meno la sua ‘aura’. L’aura nasce dalle origini stesse dell’arte, come espressione del rito e del culto, è il carattere che rende unica l’opera d’arte, autentica, nella sua segretezza religiosa: ha quindi carattere di sacralità. Man mano che il carattere cultuale si perde, la sacralità viene ad avvolgere direttamente l’artista, il genio. Per il carattere di massa dell’arte, gli oggetti si devono ravvicinare: tutto ciò implica un mutamento del gusto, nel quadro più generale di una civiltà in formazione. Con l’avvento dei mezzi di riproduzione, la fotografia (4) (in coincidenza con il socialismo), viene meno il criterio dell’autenticità e si trasforma l’intera funzione dell’arte. La ricezione dell’opera avviene secondo due accenti diversi: il primo cade sul valore cultuale, il secondo sul valore espositivo. La riproduzione tecnica accresce in maniera poderosa l’esponibilità dell’opera, che sostituisce su tutta la linea il valore cultuale.
Benjamin affronta la definizione del concetto di riproducibilità. Ogni opera d’arte è unica, ma può essere riproducibile. La riproducibilità di cui parliamo ora è invece condizionata dalla tecnica e dalla serialità. Con questi strumenti viene meno la sua ‘aura’. L’aura nasce dalle origini stesse dell’arte, come espressione del rito e del culto, è il carattere che rende unica l’opera d’arte, autentica, nella sua segretezza religiosa: ha quindi carattere di sacralità. Man mano che il carattere cultuale si perde, la sacralità viene ad avvolgere direttamente l’artista, il genio. Per il carattere di massa dell’arte, gli oggetti si devono ravvicinare: tutto ciò implica un mutamento del gusto, nel quadro più generale di una civiltà in formazione. Con l’avvento dei mezzi di riproduzione, la fotografia (4) (in coincidenza con il socialismo), viene meno il criterio dell’autenticità e si trasforma l’intera funzione dell’arte. La ricezione dell’opera avviene secondo due accenti diversi: il primo cade sul valore cultuale, il secondo sul valore espositivo. La riproduzione tecnica accresce in maniera poderosa l’esponibilità dell’opera, che sostituisce su tutta la linea il valore cultuale.
Benjamin espone ancor più chiaramente la definizione di “aura” nella “Piccola storia della fotografia”, che anticipa il saggio sull’opera d’arte di cinque anni:
“Che cos’è, propriamente, l’aura? Un singolare intreccio di spazio e di tempo: l’apparizione unica di una lontananza, per quanto possa essere vicina. (…) ora, il bisogno di avvicinare le cose a se stessi, è intenso quanto quello di superare l’irripetibile e unico, in ogni situazione, mediante la sua riproduzione.” (p.70)
 Vienna con Karl Kraus e la scuola di Francoforte giungono a conclusioni profondamente diverse. L’esperienza di Vienna ed il crollo di una cultura sono sentiti come il presentimento di un crollo più vasto, europeo. In America Adorno sente la mancanza di radici, che ci furono solo nell’Illuminismo. Egli mette al centro della sua teoria estetica la condizione di ‘ovvietà’ dell’arte. Parafrasando Benjamin inizia: “È ormai ovvio che niente più di ciò che concerne l’arte è ovvio, né nell’arte stessa né nel suo rapporto con il tutto; ovvio non è neppure il suo diritto all’esistenza”(5). Benjamin, invece, ha un senso problematico della crisi. Dalle contraddizioni della realtà si traggono tensioni positive: l’aura che, persa, suscita nuove possibilità (come con la fotografia di Atget). Con Adorno si dubita che l’arte possa continuare ad esistere e quale sarà la sua posizione nella società; con il Dada, Duchamp, il Formalismo russo e il Futurismo, il senso della deperibilità dell’arte ha generato un’altra opera di senso diverso.
Vienna con Karl Kraus e la scuola di Francoforte giungono a conclusioni profondamente diverse. L’esperienza di Vienna ed il crollo di una cultura sono sentiti come il presentimento di un crollo più vasto, europeo. In America Adorno sente la mancanza di radici, che ci furono solo nell’Illuminismo. Egli mette al centro della sua teoria estetica la condizione di ‘ovvietà’ dell’arte. Parafrasando Benjamin inizia: “È ormai ovvio che niente più di ciò che concerne l’arte è ovvio, né nell’arte stessa né nel suo rapporto con il tutto; ovvio non è neppure il suo diritto all’esistenza”(5). Benjamin, invece, ha un senso problematico della crisi. Dalle contraddizioni della realtà si traggono tensioni positive: l’aura che, persa, suscita nuove possibilità (come con la fotografia di Atget). Con Adorno si dubita che l’arte possa continuare ad esistere e quale sarà la sua posizione nella società; con il Dada, Duchamp, il Formalismo russo e il Futurismo, il senso della deperibilità dell’arte ha generato un’altra opera di senso diverso.
Dice Peter Szondi: “La concezione benjaminiana dell’arte non è critica, è utopica.” L’attenzione di Benjamin si rivolge in realtà all’epoca in cui la tecnica come tale rappresentava una possibilità, quando il dominio dei rapporti tra natura e umanità (6) era ancora all’orizzonte del futuro. In realtà si potrebbe dire, seguendo Adorno, che, al di là dell’utopia, è critica e messianica insieme:
“La conoscenza non ha altra luce che emana dalla redenzione sul mondo: tutto il resto si esaurisce nella ricostruzione a posteriori e fa parte della tecnica. Si tratta di stabilire prospettive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue fratture e le sue crepe, come apparirà un deformato e manchevole, nella luce messianica.” (7)
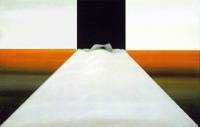 Lo storico non ha a che fare con l’immagine eterna del passato, ma deve formulare un’esperienza con il concreto storico, in cui deve immergersi. Si libera della contemplatività dello storicismo a favore di una costruzione che colga il nesso tra storia — epoca — vita — opera e lo ricrei, ottenendo così che sia preservata e conservata nell’opera, l’opera della vita, nell’opera della vita l’epoca e nell’epoca il corso della storia. “Non perché io sia professante della visione del mondo materialista, ma perché mi sforzo di orientare il mio pensiero su quegli oggetti nei quali la verità compare nel modo più pregnante. E non si tratta oggi di idee eterne né di valori atemporali”. Nel saggio su “E. Fuchs, il collezionista e lo storico ” ridefinisce il suo rapporto con il materialismo storico. (8)
Lo storico non ha a che fare con l’immagine eterna del passato, ma deve formulare un’esperienza con il concreto storico, in cui deve immergersi. Si libera della contemplatività dello storicismo a favore di una costruzione che colga il nesso tra storia — epoca — vita — opera e lo ricrei, ottenendo così che sia preservata e conservata nell’opera, l’opera della vita, nell’opera della vita l’epoca e nell’epoca il corso della storia. “Non perché io sia professante della visione del mondo materialista, ma perché mi sforzo di orientare il mio pensiero su quegli oggetti nei quali la verità compare nel modo più pregnante. E non si tratta oggi di idee eterne né di valori atemporali”. Nel saggio su “E. Fuchs, il collezionista e lo storico ” ridefinisce il suo rapporto con il materialismo storico. (8)
Le collezioni di Fuchs sono le risposte dell’uomo pratico alla aporie della teoria. Il suo interesse per l’arte non è mosso dal piacere per il bello, ma dalla ricerca della verità. E la verità si trova sempre negli estremi, nelle strutture drastiche dell’opera d’arte, sia contenutistiche che formali. Il grottesco costituisce la massima accentuazione di ciò che è sensibilmente rappresentabile e si presta ad esprimere la propulsione creatrice sia dell’epoca di fioritura che di decadenza, secondo una polarità estremizzante. Così Fuchs il collezionista raccoglie caricature e opere pornografiche. Il culto della forza creatrice lo porta comunque a privilegiare il Rinascimento, ma il suo carattere peculiare e la considerazione per le cose comunemente disprezzate, apocrife, e, nello studio sulla scultura Tang, l’abilità tecnica nella riproduzione e la loro completa anonimia. La riproducibilità dell’arte permette di capire l’importanza della ricezione, e alla revisione del concetto di genio, liberando la storia dell’arte dal feticcio del maestro. Ciò che deplora nella storia dell’arte è che non siano considerati problemi importanti connessi all’arte come il successo dell’artista, la durata, la volontà della durata, non l’originalità, come in Valery. “L’idea di progresso, quella valida, autentica, è l’idea della trasferibilità dei metodi, che corrisponde in Valery, al concetto della costruzione con la stessa evidenza con cui contrasta all’idea fissa dell’ispirazione. L’opera d’arte, ha detto uno dei suoi interpreti, non è una creazione; è una costruzione in cui l’analisi, il calcolo, la pianificazione svolgono il ruolo principale.” (9)
 Il cinema, come l’architettura, come l’epopea, propone l’oggetto alla ricezione collettiva simultanea: verifica le condizioni di un’arte di massa, intesa come avvicinamento dell’oggetto. Il culto del divo, come il mago, come il chirurgo, cerca di conservare quella magia della personalità che da tempo è ridotta alla magia fasulla del proprio carattere di merce. Non solo: la tecnica del film, come la tecnica sportiva, implica che chiunque assista alle prestazioni diventi un semispecialista. Così, nell’ambito dello scrivere, la diffusione della stampa e la rubrica di lettere al direttore finisce col far perdere la distinzione sostanziale tra autore e pubblico: la competenza letteraria non viene più raggiunta attraverso una preparazione specializzata, ma attraverso quella politecnica, e diventa così di dominio pubblico. Con il cinema ciò accade in modo molto più rapido: chiunque può interpretare se stesso. Ancora non siamo nel villaggio globale, a Andy Wahrol, al cinema americano di Corman e Tarantino. “La massa distratta fa sprofondare nel proprio grembo l’opera d’arte”.(10) Degli edifici, come del cinema, si fruisce in un duplice modo: attraverso l’uso, attraverso la percezione. La fruizione d’uso non avviene sul piano dell’attenzione, quanto su quello dell’abitudine. Con il cinema si ottiene quanto il Dada e le esperienze delle avanguardie ricercavano con la pittura e la letteratura: lo shock, che impedisce il momento contemplativo, il raccoglimento, il giudizio. La ricezione dell’opera d’arte avviene nella distrazione, induce nel pubblico un atteggiamento valutativo che non implica attenzione, il pubblico è un esaminatore, ma un esaminatore distratto.
Il cinema, come l’architettura, come l’epopea, propone l’oggetto alla ricezione collettiva simultanea: verifica le condizioni di un’arte di massa, intesa come avvicinamento dell’oggetto. Il culto del divo, come il mago, come il chirurgo, cerca di conservare quella magia della personalità che da tempo è ridotta alla magia fasulla del proprio carattere di merce. Non solo: la tecnica del film, come la tecnica sportiva, implica che chiunque assista alle prestazioni diventi un semispecialista. Così, nell’ambito dello scrivere, la diffusione della stampa e la rubrica di lettere al direttore finisce col far perdere la distinzione sostanziale tra autore e pubblico: la competenza letteraria non viene più raggiunta attraverso una preparazione specializzata, ma attraverso quella politecnica, e diventa così di dominio pubblico. Con il cinema ciò accade in modo molto più rapido: chiunque può interpretare se stesso. Ancora non siamo nel villaggio globale, a Andy Wahrol, al cinema americano di Corman e Tarantino. “La massa distratta fa sprofondare nel proprio grembo l’opera d’arte”.(10) Degli edifici, come del cinema, si fruisce in un duplice modo: attraverso l’uso, attraverso la percezione. La fruizione d’uso non avviene sul piano dell’attenzione, quanto su quello dell’abitudine. Con il cinema si ottiene quanto il Dada e le esperienze delle avanguardie ricercavano con la pittura e la letteratura: lo shock, che impedisce il momento contemplativo, il raccoglimento, il giudizio. La ricezione dell’opera d’arte avviene nella distrazione, induce nel pubblico un atteggiamento valutativo che non implica attenzione, il pubblico è un esaminatore, ma un esaminatore distratto.
 Alcuni dei temi del saggio sull’opera d’arte, il concetto di aura, lo shock, sono ripresi nell’ambito della critica letteraria, nei saggi su Baudelaire e Parigi del ’39. L’inizio della poetica delle avanguardie novecentesche viene fatto risalire al tentativo Poe — Baudelaire, che avevano reagito alla rivoluzione industriale, al primo rapporto arte — tecnologia, con la rivendicazione dell’autonomia dell’arte. D’altra parte, sia Poe sia Baudelaire cercano, come le avanguardie, di realizzare quell’effetto di shock che è l’esperienza abituale dell’uomo moderno, in mezzo alla folla e al traffico cittadino, lo stesso, sostiene Benjamin, dell’operaio addetto alle macchine. La stessa frammentazione dell’esperienza a cui oggi, al di là della ‘reificazione’ del modello capitalistico di quegli anni, siamo tutti sottoposti, all’avvicinamento esasperato, tattile, ottico, sonoro, degli oggetti. E la parola? La citazione, il frammento, la cifra di Benjamin.
Alcuni dei temi del saggio sull’opera d’arte, il concetto di aura, lo shock, sono ripresi nell’ambito della critica letteraria, nei saggi su Baudelaire e Parigi del ’39. L’inizio della poetica delle avanguardie novecentesche viene fatto risalire al tentativo Poe — Baudelaire, che avevano reagito alla rivoluzione industriale, al primo rapporto arte — tecnologia, con la rivendicazione dell’autonomia dell’arte. D’altra parte, sia Poe sia Baudelaire cercano, come le avanguardie, di realizzare quell’effetto di shock che è l’esperienza abituale dell’uomo moderno, in mezzo alla folla e al traffico cittadino, lo stesso, sostiene Benjamin, dell’operaio addetto alle macchine. La stessa frammentazione dell’esperienza a cui oggi, al di là della ‘reificazione’ del modello capitalistico di quegli anni, siamo tutti sottoposti, all’avvicinamento esasperato, tattile, ottico, sonoro, degli oggetti. E la parola? La citazione, il frammento, la cifra di Benjamin.
“La percettibilità — afferma Novalis — è un’attenzione. La percettibilità di cui parla non è altro che quella dell’aura. (…) Avvertire l’aura di una cosa significa dotarla della capacità di guardare. Questa dotazione è la scaturigine della poesia. Quando l’uomo, l’animale o un oggetto inanimato, dotato di questa capacità del poeta, alza gli occhi e o sguardo, esso è attratto lontano: lo sguardo della natura risvegliata sogna e nel suo sogno trascina il poeta. Anche le parole possono avere la loro aura. Come l’ha descritta K. Kraus: “Quanto più davvicino si guarda una parola e tanto più lontano essa guarda” (11).



