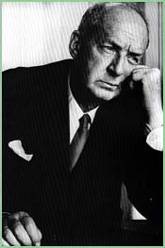 Un docente sussiegoso e austero? Probabilmente no, anche se imponeva agli allievi regole precise. “Durante i miei seminari è vietato parlare, fumare, lavorare a maglia, leggere il giornale, dormire e, per l’amor di Dio, prendere appunti”, chiariva all’inizio di ogni anno. Più che dell’accademico Vladimir Nabokov (di cui ricorre ora il centenario della nascita) doveva avere il piglio vivace del conversatore ironico e intelligente. E infatti per tutto il lungo periodo — dal 1941 al 1958 — in cui si trovò a insegnare letteratura nelle università americane amava ripetere l’opinione di uno studente che, chiamato a riassumere i motivi della scelta dell’iscrizione al corso, aveva risposto: “L’ho fatto perché apprezzo le storie e chi sa raccontarle”.
Un docente sussiegoso e austero? Probabilmente no, anche se imponeva agli allievi regole precise. “Durante i miei seminari è vietato parlare, fumare, lavorare a maglia, leggere il giornale, dormire e, per l’amor di Dio, prendere appunti”, chiariva all’inizio di ogni anno. Più che dell’accademico Vladimir Nabokov (di cui ricorre ora il centenario della nascita) doveva avere il piglio vivace del conversatore ironico e intelligente. E infatti per tutto il lungo periodo — dal 1941 al 1958 — in cui si trovò a insegnare letteratura nelle università americane amava ripetere l’opinione di uno studente che, chiamato a riassumere i motivi della scelta dell’iscrizione al corso, aveva risposto: “L’ho fatto perché apprezzo le storie e chi sa raccontarle”.
Anche Nabokov, al pari del suo allievo, amava le storie. “I grandi romanzi — ripeteva — sono grandi fiabe. Accarezzatene i particolari. Stile e struttura sono l’essenza di un libro. Le idee generali non servono a nulla”. Così durante le sue lezioni privilegiava l’analisi dei piccoli dettagli che gli consentivano di mettere in luce la maestria di un autore, le combinazioni grazie alle quali si accende la “scintilla sensuale” che dà vita a un testo. “Qualunque somaro — disse una volta in un’intervista — può assimilare l’essenziale dell’atteggiamento di Tolstoj di fronte all’adulterio, ma per poter davvero godere della raffinata arte tolstojana il bravo lettore deve aver voglia di immaginare la disposizione di una carrozza ferroviaria sul treno notturno Mosca-Pietroburgo qual era cento anni fa”.
 A disagio davanti a qualsiasi pubblico, preparava in anticipo le sue analisi, anche se in aula si lanciava di tanto in tanto in commenti estemporanei. “Benché in cattedra avessi elaborato un sottile movimento degli occhi — confessa in un testo autobiografico — per gli studenti svegli non c’era il minimo dubbio sul fatto che stavo leggendo e non parlando”. Alcuni anni più tardi dagli appunti sarebbero nate le memorabili “Lezioni di letteratura”, dalle quali emerge, tra l’altro, che giudicava Kafka e Flaubert i massimi autori moderni nella loro lingua, Joyce un maestro, mentre Conrad gli appariva “adatto al massimo all’infanzia” e Dostoevskij “un teatrante da strapazzo”.
A disagio davanti a qualsiasi pubblico, preparava in anticipo le sue analisi, anche se in aula si lanciava di tanto in tanto in commenti estemporanei. “Benché in cattedra avessi elaborato un sottile movimento degli occhi — confessa in un testo autobiografico — per gli studenti svegli non c’era il minimo dubbio sul fatto che stavo leggendo e non parlando”. Alcuni anni più tardi dagli appunti sarebbero nate le memorabili “Lezioni di letteratura”, dalle quali emerge, tra l’altro, che giudicava Kafka e Flaubert i massimi autori moderni nella loro lingua, Joyce un maestro, mentre Conrad gli appariva “adatto al massimo all’infanzia” e Dostoevskij “un teatrante da strapazzo”.
L’anticonformismo, del resto, costituì sempre la nota caratteristica di Nabokov, come dimostra anche la sua ormai notissima storia personale. Discendente da una famiglia della vecchia nobiltà di San Pietroburgo, decise di emigrare in Inghilterra dopo la rivoluzione, studiando all’università di Cambridge per poi trascorrere quindici anni a Berlino guadagnandosi da vivere con ogni genere di lavoro (maestro di tennis e di boxe, risolutore di problemi scacchistici e di giochi enigmistici) e scegliere infine di stabilirsi in America avendo ottenuto un incarico prima al Wellesley College e quindi alla Cornell University. Alla fama internazionale giunse solo nel 1955 grazie a “Lolita” e trascorse l’ultimo periodo della vita in Svizzera in compagnia delle amatissime farfalle, spegnendosi a Montreux nel 1977.
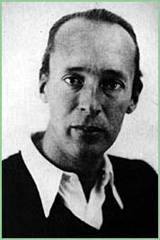 Sulle sue doti artistiche non nutrì mai alcun dubbio: “penso come un genio, scrivo come un autore eminente”, affermò una volta. E quando un giornalista gli chiese se si sentiva un personaggio replicò con aristocratico distacco: “Mi vanto di essere una persona priva di interesse per il pubblico. Non mi sono mai ubriacato in vita mia. Non dico parolacce. Non ho mai lavorato in un ufficio o in una miniera di carbone. Non ho mai fatto parte di circoli o associazioni. Non c’è credo o scuola che abbia avuto su di me il benché minimo influsso. Non c’è nulla che mi annoi quanto i romanzi politici e la letteratura a sfondo sociale”.
Sulle sue doti artistiche non nutrì mai alcun dubbio: “penso come un genio, scrivo come un autore eminente”, affermò una volta. E quando un giornalista gli chiese se si sentiva un personaggio replicò con aristocratico distacco: “Mi vanto di essere una persona priva di interesse per il pubblico. Non mi sono mai ubriacato in vita mia. Non dico parolacce. Non ho mai lavorato in un ufficio o in una miniera di carbone. Non ho mai fatto parte di circoli o associazioni. Non c’è credo o scuola che abbia avuto su di me il benché minimo influsso. Non c’è nulla che mi annoi quanto i romanzi politici e la letteratura a sfondo sociale”.
Forse il libro più utile per avvicinarsi al suo mondo è “Intransigenze”, la raccolta delle interviste rilasciate nel corso degli anni sessanta e settanta tradotto nel 1994 dall’Adelphi, una sorta di capricciosa, irrituale e obliqua autobiografia. Il rituale che presiedeva allo scambio di opinioni tra lui e i giornalisti incaricati di interrogarlo era ferreo: Nabokov esigeva di conoscere in anticipo le domande per potersi presentare all’appuntamento con un testo già pronto, e quindi chiedeva immancabilmente di controllare le bozze dell’articolo per evitare la minima divergenza tra quanto dai lui detto e ciò che sarebbe stato effettivamente stampato.
 “Nessuno — spiega — dovrebbe chiedermi un’intervista se per ‘intervista’ s’intende una chiacchierata fra due normali essersi umani. In altri tempi ci hanno provato almeno due volte, e una volta era presente un registratore, e quando riascoltammo il nastro e io ebbi finito di ridere, mi fu chiaro che mai più in vita mia avrei ripetuto un esercizio del genere. Oggi prendo tutte le precauzioni necessarie per costringere a una dignitosa ritirata chi dà la caccia al mandarino. Le domande devono essere inviate per iscritto, ricevono risposte scritte, e le risposte devono essere riprodotte alla lettera. Sono queste tre condizioni inderogabili”.
“Nessuno — spiega — dovrebbe chiedermi un’intervista se per ‘intervista’ s’intende una chiacchierata fra due normali essersi umani. In altri tempi ci hanno provato almeno due volte, e una volta era presente un registratore, e quando riascoltammo il nastro e io ebbi finito di ridere, mi fu chiaro che mai più in vita mia avrei ripetuto un esercizio del genere. Oggi prendo tutte le precauzioni necessarie per costringere a una dignitosa ritirata chi dà la caccia al mandarino. Le domande devono essere inviate per iscritto, ricevono risposte scritte, e le risposte devono essere riprodotte alla lettera. Sono queste tre condizioni inderogabili”.
Se è carente sotto il profilo della spontaneità, se manca qualsiasi nota di ‘colore’ — elementi che del resto Nabokov odiava in maniera feroce — la raccolta offre tuttavia una sintesi esauriente delle idee (spesso assolutamente peculiari) del narratore sul mondo, sulla letteratura e su molti colleghi. Poco incline all’uso delle perifrasi, Nabokov punta diritto al bersaglio, demolendo con feroci battute l’opera di T.S.Eliot o di Ezra Pound (“artisti disgustosi e di secondo rango”), i romanzi di Pasternak (“scrive cose squallide, piene di cliché”), l’impegno di Sartre o di Bertrand Russell (“qualsiasi cosa dicano o facciano io dico o faccio il contrario e sono certo di non sbagliarmi”). A lui, del resto, la compagnia dei contemporanei non piaceva, visto che proclama: “La mia arte è troppo avanti perché qualcuno possa raggiungerla”.
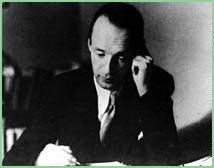 Dalle risposte offerte nel corso delle interviste emerge il ritratto di un Nabokov sempre deciso a sottolineare l’abissale distanza che lo separa dai suoi colleghi sia per quanto riguarda le opinioni che nei comportamenti quotidiani. In più di una circostanza, inoltre, insiste sull’assurdità di scrivere un romanzo iniziando dalla pagina di apertura per poi avanzare in progressione. Lui, al contrario, lavora su blocchi, su singole scene mai in sequenza: “Io — spiega — non faccio come quasi tutti gli altri che passano da un capitolo all’altro. Preferisco prendere un pezzetto qui e un pezzetto là, finché ho riempito tutti i vuoti”.
Dalle risposte offerte nel corso delle interviste emerge il ritratto di un Nabokov sempre deciso a sottolineare l’abissale distanza che lo separa dai suoi colleghi sia per quanto riguarda le opinioni che nei comportamenti quotidiani. In più di una circostanza, inoltre, insiste sull’assurdità di scrivere un romanzo iniziando dalla pagina di apertura per poi avanzare in progressione. Lui, al contrario, lavora su blocchi, su singole scene mai in sequenza: “Io — spiega — non faccio come quasi tutti gli altri che passano da un capitolo all’altro. Preferisco prendere un pezzetto qui e un pezzetto là, finché ho riempito tutti i vuoti”.
Decisamente insolita risulta anche la routine del lavoro: “Non ho mai imparato a scrivere a macchina. — confessa — In generale inizio la giornata davanti a un bel leggio all’antica che ho nel mio studio. Più tardi, quando sento la gravità mordicchiarmi i polpacci, mi siedo su una comoda poltrona accanto a un comune scrittoio, e infine, quando la gravità comincia a risalire la colonna vertebrale, mi sdraio su un divano in un angolo. Così ogni giorno per almeno otto ore, scrivendo a matita su schede fabbricate apposta per me”.
 Gran parte delle interviste offrono una larga messe di notizie in merito alle radicate certezze di Nabokov sulla letteratura e il dettagliato resoconto della genesi delle sue opere. In nessuna, poi, manca un accenno ai bersagli che si diverte a colpire (e a ingiuriare) senza misericordia. È un elenco dove, oltre agli autori già citati, figurano Dostoevskij, Balzac, Conrad, D.H. Lawrence, Thomas Mann e Sartre. Il più vituperato resta comunque Freud, di cui Nakobov non nasconde di pensare tutto il male possibile. “Il freudismo — sostiene più volte — mi sembra uno dei raggiri più ignobili che la gente possa praticare su se stessa”.
Gran parte delle interviste offrono una larga messe di notizie in merito alle radicate certezze di Nabokov sulla letteratura e il dettagliato resoconto della genesi delle sue opere. In nessuna, poi, manca un accenno ai bersagli che si diverte a colpire (e a ingiuriare) senza misericordia. È un elenco dove, oltre agli autori già citati, figurano Dostoevskij, Balzac, Conrad, D.H. Lawrence, Thomas Mann e Sartre. Il più vituperato resta comunque Freud, di cui Nakobov non nasconde di pensare tutto il male possibile. “Il freudismo — sostiene più volte — mi sembra uno dei raggiri più ignobili che la gente possa praticare su se stessa”.
Roccioso nel difendere le sue opinioni e i suoi pregiudizi, non si piegò neppure di fronte a offerte che altri avrebbero giudicato allettanti. Quando una volta un periodico dopo l’uscita di “Lolita” gli chiese di rispondere con un breve articolo da compensare lautamente alla domanda “lo scrittore ha una responsabilità sociale?” replicò con un rifiuto stizzito avendo trovato il quesito “insopportabilmente idiota”. Come era del resto inevitabile aspettarsi da un uomo che sembra vissuto per errore in questo secolo, un aristocratico geniale e intransigente, con un altissimo concetto di sé e un sovrano disprezzo per l’universo mondo.


