 La sua immagine è notevolmente distante da quella foto stampata nel retro del libro che lo immortala giovane e sorridente.
La sua immagine è notevolmente distante da quella foto stampata nel retro del libro che lo immortala giovane e sorridente.
Me lo ritrovo dinnanzi presso il luogo indicatomi dal suo editore e subito la mia emozione entra in connubio con una sorta di stupore: i suoi capelli neri sono ora completamente bianchi, sensibilmente più lunghi e scarmigliati, in modo tale da suggerirmi la somiglianza nemmeno troppo vaga con Albert Einstein. Impressione, questa, accresciuta da due enormi baffi che risaltano prepotenti sul viso scavato da profonde rughe. Pare più vecchio rispetto ai suoi sessantasei anni.
Non ho nemmeno il tempo di compiere gesti o dire qualcosa che lui mi si fa incontro allungando la mano e stringendo la mia in modo energico e deciso. Un largo sorriso smaschera gli ultimi tre denti rimastigli, mentre lo osservo con aria sorpresa, del tutto impressionato dalle sue gigantesche dimensioni che superano di gran lunga quelle che mi ero immaginato prima di conoscerlo.
 Vorrei che mi facessi visitare i luoghi più cari a Leopardi.
Vorrei che mi facessi visitare i luoghi più cari a Leopardi.
La sua richiesta mi sorprende nonostante avessimo già avuto modo di parlare al telefono del grande poeta recanatese e mi avesse in questa occasione manifestato tutta la sua ammirazione per Leopardi. Non pensavo, però, che l’ansia di respirare l’aria degli stessi luoghi che avevano ispirato il “vate del romanticismo italiano” fosse tale da avere la priorità sulle esigenze di chi aveva appena concluso un lungo viaggio.
Comunque quest’estrema attenzione e rispetto che ripose nei confronti del Leopardi mi riempì, come recanatese, d’orgoglio. Con entusiasmo lo faccio salire sulla mia auto, pronto ad accompagnarlo presso “Il Colle dell’Infinito”.
Questa é tutta la prospettiva che Leopardi vagheggia nella sua poesia, l’infinito?
Sì, questa è tutta la prospettiva dell’Infinito leopardiano, mentre quelli laggiù sono gli arcani monti di cui parla nelle “Ricordanze” — rispondo compiaciuto, indicando nel frattempo i monti lontani che appaiono sfumati all’orizzonte.
Jack appare commosso alla vista di quel panorama che aveva ispirato uno dei più grandi poeti dell’umanità, mentre aspetto di cogliere il momento opportuno per rivolgergli qualcuna delle innumerevoli domande che mi turbinano in testa.
Andrea Marinelli (AM): So che hai tradotto Pasolini negli Stati Uniti. Che cosa ti ha spinto a farlo?
Jack Hirschman (JH): Ho tradotto Pasolini perché ritengo le sue idee geniali e coraggiose.
AM: Cosa intendi definendole coraggiose?
 JH: Penso a Salò o le 120 giornate di Sodoma, un’opera rivoluzionaria per una forma d’arte come il cinema.In questo film rappresenta la violenza in un modo crudo e drammatico come mai era stato fatto prima. Pasolini ha capito quanto straordinaria potesse essere la forza delle immagini. Forse, se riguardiamo questo film oggi, l’impatto non è così duro e forte come allora, perché nel frattempo il cinema e la televisione ci hanno lentamente educati alla violenza; ma quando uscì impressionò anche i più audaci propugnatori d’un crudo realismo: quelli come me insomma! Ricordo che in quel film vidi stravolti tutti i canoni espressivi e oltrepassato largamente il limite di ciò che era lecito rappresentare. Per questo non posso che definire Salò o le 120 giornate di Sodoma un’opera coraggiosa, ideata e realizzata da un uomo realmente coraggioso.
JH: Penso a Salò o le 120 giornate di Sodoma, un’opera rivoluzionaria per una forma d’arte come il cinema.In questo film rappresenta la violenza in un modo crudo e drammatico come mai era stato fatto prima. Pasolini ha capito quanto straordinaria potesse essere la forza delle immagini. Forse, se riguardiamo questo film oggi, l’impatto non è così duro e forte come allora, perché nel frattempo il cinema e la televisione ci hanno lentamente educati alla violenza; ma quando uscì impressionò anche i più audaci propugnatori d’un crudo realismo: quelli come me insomma! Ricordo che in quel film vidi stravolti tutti i canoni espressivi e oltrepassato largamente il limite di ciò che era lecito rappresentare. Per questo non posso che definire Salò o le 120 giornate di Sodoma un’opera coraggiosa, ideata e realizzata da un uomo realmente coraggioso.
AM: Cos’altro ti piace dell’arte di Pasolini?
JH: Amo la sua capacità di descrivere la sofferenza dei diseredati, dei disoccupati, degli emarginati, degli accattoni e dei senza tetto che popolano i sobborghi delle grandi città italiane, anche se condivido solo in parte la sua critica a quel modernismo esasperato che ci allontanerebbe violentemente dai valori più autentici.
AM: Perché sottolinei di condividerlo solo in parte? Cos’è che ti rifiuti di avallare nella visione pasoliniana delle cose?
JH: Non condivido i suoi rimpianti nei confronti di una civiltà pre-industriale e solo semi-tecnologica. In una poesia come Il pianto della scavatrice ad esempio, sembra emergere chiaramente questa sua idea relativa ad una civiltà industriale ed iperurbanizzata, che si edificherebbe compiendo un vero e proprio omicidio nei confronti della vecchia civiltà pre-industriale, quella che ai suoi occhi poggiava su valori più stabili e genuini.
AM: Quale è invece la tua posizione nei confronti della tecnologia moderna?
 JH: Penso che la tecnologia sia fortemente neutrale. Può essere lo strumento di dominio esercitato da coloro che ne possono disporre per mezzo del capitale, ma può anche costituire — qualora non se ne facesse un uso proprio — un mezzo di emancipazione, progressivo e proporzionale al suo accrescersi, dal duro lavoro fisico. Purtroppo la tecnologia è apparato di “cose morte”, tanto che la vitalità e la voglia di vivere e lottare diminuiscono con l’aumentare degli oggetti artificiali e senza vita. Forse l’uomo riesce ad apprezzare maggiormente l’esistenza in quei luoghi in cui domina la vita biologica.
JH: Penso che la tecnologia sia fortemente neutrale. Può essere lo strumento di dominio esercitato da coloro che ne possono disporre per mezzo del capitale, ma può anche costituire — qualora non se ne facesse un uso proprio — un mezzo di emancipazione, progressivo e proporzionale al suo accrescersi, dal duro lavoro fisico. Purtroppo la tecnologia è apparato di “cose morte”, tanto che la vitalità e la voglia di vivere e lottare diminuiscono con l’aumentare degli oggetti artificiali e senza vita. Forse l’uomo riesce ad apprezzare maggiormente l’esistenza in quei luoghi in cui domina la vita biologica.
Abbandoniamo il “colle dell’infinito” per dirigerci verso il locale all’interno del quale Hirschman reciterà alcune delle sue poesie.
AM: Tu sei cresciuto all’interno della generazione Beat: ti consideri ancora legato a quella visione delle cose o pensi di essertene distaccato in qualche modo?
JH: Voglio onorare in primo luogo, prima di parlare dei miei rapporti con i rappresentanti della generazione Beat, quello che considero uno dei miei grandi maestri: Edwin Arlington Robinson. Naturalmente non l’ho mai potuto conoscere di persona, perché quando morì ero ancora bambino, ma fu proprio leggendo ripetutamente la sua opera maggiore “The Children of the Night” che ho iniziato ad amare la poesia.
Mi piaceva il suo rivoluzionario stile colloquiale e ne condividevo la pretesa di voler descrivere la realtà dei vinti, degli emarginati, dei falliti, di tutti coloro che erano stati truffati dal “sogno americano”, proprio in un’epoca in cui tutti gli altri ancora cantavano la grandezza di quella illusione. Robinson in questo fu profetico, perché quella stessa realtà che lui descriveva, diventerà dominante negli anni immediatamente successivi alla sua morte, quelli della Grande Crisi che ispirerà anche i romanzi di Steinbeck.
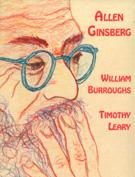 Per quanto riguarda la “Beat Generation”, posso tranquillamente affermare la mia trascorsa appartenenza e la mia solidarietà a quel gruppo di intellettuali. Non posso nemmeno negare la mia vecchia amicizia con Ginsberg né di essere orgoglioso di aver fatto parte di un gruppo di intellettuali che, primi negli Stati Uniti, si sono opposti ad un certo tipo di sistema. A quel tempo combattevamo il consumismo, le convenzioni date per indiscutibili e la mediocrità dei valori borghesi, per non parlarepoi della nostra ferma opposizione alla guerra del Vietnam, che io ho pagato a caro prezzo.
Per quanto riguarda la “Beat Generation”, posso tranquillamente affermare la mia trascorsa appartenenza e la mia solidarietà a quel gruppo di intellettuali. Non posso nemmeno negare la mia vecchia amicizia con Ginsberg né di essere orgoglioso di aver fatto parte di un gruppo di intellettuali che, primi negli Stati Uniti, si sono opposti ad un certo tipo di sistema. A quel tempo combattevamo il consumismo, le convenzioni date per indiscutibili e la mediocrità dei valori borghesi, per non parlarepoi della nostra ferma opposizione alla guerra del Vietnam, che io ho pagato a caro prezzo.
AM: Ma ti senti ancora legato a quegli ideali o pensi di poter muover qualche critica?
JH: Sono critico senz’altro nei confronti di quell’individualismo-anarchico che costituiva la logica dominante del nostro gruppo e che non ritengo per nulla costruttivo. Penso che sia necessario cambiare le cose, credo ancora in una possibile futura società comunista da realizzare tramite una rivoluzione. Una rivoluzione guidata dalla massa di diseredati ed emarginati che aumentano e crescono di misura, proporzionalmente alla loro rabbia.
AM: Quale pensi debba essere quindi il compito di un artista o di un intellettuale? E quale il tuo compito?
JH: Il mio compito consiste nel dar voce alla rabbia ad alla disperazione di tutti questi individui emarginati, che lottano per sopravvivere in una società dominata dal capitale e dalla logica del profitto.
Recita alcuni testi da “Soglia Infinita”, il suo primo libro pubblicato in Italia e poi altri da “Arcani”, la sua ultima opera.Tutti lo seguono, trasportati sia dalla forza dei versi che da quel suo melodico timbro vocale, che possiede tutto il vigore necessario per coinvolgere totalmente.
Un prepotente scroscio di applausi accoglie la fine di ogni poesia, fino all’ultimo e più intenso, che saluta la conclusione della serata, con tutti che gli si avvicinano tempestandolo di domande. Mi trattengo in disparte, sicuro che presto sarà nuovamente il mio turno. Arriviamo a casa mia, dove Hirschman resterà ospite per la notte, prima di ripartire per Bologna il giorno successivo. Ci sediamo comodi sul divano per poter riprendere la conversazione sospesa qualche ora prima.
AM: Ricordo di aver letto in una breve biografia su di te che sei stato per molti anni amico di Bukowski. Cosa ricordi di lui?
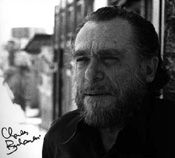 JH: È stato sicuramente un grande artista, che possedeva una strabiliante capacità di scrittura. È riuscito a rappresentare delle realtà psicologiche difficili da tratteggiare, e soprtattutto ha descritto personaggi e situazioni che potevano apparentemente non interessare a nessuno, riuscendo invece a renderli interessanti e coinvolgenti. I personaggi che descrive lui sono gli stessi a me cari, perché sono quelli che appartengono all’America plebea, quella delle strade, dei vicoli e dei bar. Ciò che non ho condiviso di lui è quella che io personalmente considero la declinante parabola conclusiva della sua carriera: le sue ultime opere infatti, come, “Il diario di un vecchio sporcaccione”, mi sono invise, perché assumono un tono manierista e ricercato. La critica ancora non lo ha sottolineato, ma io penso che ben presto sarà d’accordo con me nel considerare l’ultimo Bukowski come un manierista.
JH: È stato sicuramente un grande artista, che possedeva una strabiliante capacità di scrittura. È riuscito a rappresentare delle realtà psicologiche difficili da tratteggiare, e soprtattutto ha descritto personaggi e situazioni che potevano apparentemente non interessare a nessuno, riuscendo invece a renderli interessanti e coinvolgenti. I personaggi che descrive lui sono gli stessi a me cari, perché sono quelli che appartengono all’America plebea, quella delle strade, dei vicoli e dei bar. Ciò che non ho condiviso di lui è quella che io personalmente considero la declinante parabola conclusiva della sua carriera: le sue ultime opere infatti, come, “Il diario di un vecchio sporcaccione”, mi sono invise, perché assumono un tono manierista e ricercato. La critica ancora non lo ha sottolineato, ma io penso che ben presto sarà d’accordo con me nel considerare l’ultimo Bukowski come un manierista.
AM: L’ultima domanda che vorrei rivolgerti è relativa al destino della poesia. Quale pensi possa essere il suo futuro?
JH: Personalmente ritengo che la poesia, come altre forme d’arte, abbia un grande compito da assolvere, che è quello di cercare di rappresentare, nel suo linguaggio specifico, la verità. Certo, mentirei se mi definissi molto ottimista nei confronti dell’attuale poesia americana, che si perde dietro alle follie dei cosiddetti poeti apocalittici e le insulsaggini dei minimalisti. Bisogna tornare a rivolgersi a quella che è la realtà concreta, guidati dalla forza di un’idea che possa dar senso all’opera che ci si accinge a compiere.
intervista a cura di
Andrea Marinelli
Tre poesie
Da Multimedia Edizioni
i lavori inediti di Jack Hirschman
Our Best Harvest
Meridel Le Sueur (1900-1996)
Now I am walked into
I am knocked I am poured through
what’s left of me I am said to
by the seeds exploiding
I am given birth to
at the point of my death
Rock I
rock with my baby Earth
at my nipple, I am sung naked
I am shook all the death out of me
Work done, work go on being
said sung changing
the way today already was
Only the thrust only the yearning
burst grapes into wine
burst corn-kernals into the suns
light the future is a land
Meridel
sow well our best harvest
Meridel
Il nostro miglior raccolto.
A Meridel Le Sueur (1900-1996)
Ora sono entrata
ho bussato sono defluita attraverso
è stato detto cosa è rimasto di me
attraverso i semi esplosivi.
Io sono nata
al punto della mia morte.
Io pendolo di roccia
dondolo con la mia piccola Terra
al mio capezzolo, io sono stata cantata nuda,
a lavoro finito, il lavoro continua ad essere
raccontato cantato cambiato
allo stesso modo oggi come ieri.
Soltanto la spinta soltanto la smaniosa
uva che esplode in vino
il chicco di mais che esplode in soli
illuminano il futuro che è una terra
Meridel
seminate bene il nostro miglior raccolto
Meridel.
On the death of Willem De Kooning,
American painter
When I think of the victories
we must win,
whether here for the workers and the poor
or everywhere against police brutality,
that is, throughout the world of
the New Class and the massing
of its energies for the global struggle
against the global thugs and their
cancerous world-state corps,
when the really generous expansion
from within revolution’s process
simply takes hold of the heart
and lifts it like an Albanian
unlocking the doors to the jails,
or Willem De Kooning raising that giant
brush of his Bolton’s Landing period,
that giant moustache of a brush
like what janitors use to paint
the floors of the world the color
of human labor, then I know
that monumentality of feeling at one
with what’s heroically simple and real
as an answer to Death, and I can
re-begin belonging to the dream
of humanity again.
Sulla morte di Willem De Kooning,
pittore americano.
Quando io penso alle vittorie
che noi dobbiamo vincere,
o qui per gli operai e i poveri,
o ovunque contro la brutalità della polizia,
è lo stesso, ovunque nel mondo della
Nuova Classe e nell’ammassarsi
delle loro energie e per la lotta globale
contro gli strangolatori del mondo e il loro
cancerogeno corpo dello stato universale;
quando l’espansione realmente generosa
dall’interno del processo della rivoluzione
semplicemente prende il cuore in mano
e lo innalza come un albanese
aprendo le porte alle prigioni,
o come Willem De Kooning alzando quel gigantesco
pennello del suo periodo di Bolton’s Landing,
quel gigantesco baffo di un pennello;
come quegli inservienti che usano dipingere
i pavimenti del mondo con il colore
della fatica umana, io conosco
quella imponenza di un sentimento comune
con ciò che è eroicamente semplice e concreto
come una risposta alla Morte, e posso
ricominciare appartenendo di nuovo al sogno
dell’Umanità.
Two Years
Two years is too years too long
to be locked out,
scabbed, replaced
for having committed
an act of loyalty
to the human race.
And now international support
of unions, survivalists
and the likes of John Pilger,
Ken Loach
and artists and writers everywhere
mark a fight that’s become worldwide
and doesn’t ride in a royal coach.
Ordinary Joe and Jane
know exatly what we mean.
Two years is two years too long
I’m not here simply to sing a song
We’re all down for the Dockers
and coming on strong.
This winter the bosses fall!
Two years is two years too long.
Due anni.
Due anni sono troppi anni troppo lunghi
Per essere chiusi fuori
Ricoperti di rogna, rimpiazzati
Per aver commesso
Un atto di lealtà
Per la razza umana.
E ora gli aiuti internazionali
Di sindacati, attivisti
E persone come John Pilger,
Ken Loach
E artisti e scrittori ovunque
Indicano una lotta che è diventata globale
E che non corre in un cocchio regale.
I soliti Joe e Jane
Sanno esattamente cosa intendiamo
Due anni sono troppi anni troppo lunghi
Io non sono qui semplicemente per cantare una canzone.
Noi siamo tutti con i Dockers
E proseguiamo con forza.
Quest’inverno i capi cadono:
Due anni sono troppi anni troppo lunghi.
Jack Hirschman

