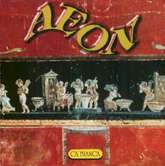|
|
|
AEON, dice il testo-titolo. Non-tempo, frammento d’un altro tempo, eternità (al di là e altro dal logos). Sottotitolo: funky, acid jazz, latino. Elenco di generi, come se si trattasse (solo) della loro contaminazione. Un sottotitolo che indica generi-camente e nell’indicazione è fuorviante. Dice molto meno di ciò che potrebbe o semplicemente non dice (quello che incontreremo nell’ascolto). Non dice soprattutto l’abbandono all’ascolto a cui dovremo (e dovremmo) arrenderci.
Ma stiamo al testo, o almeno proviamoci. Con una avvertenza, rinnovata ad ogni nuovo ascolto: dovremo liberare l’orecchio (ós, oris, il buco, la breccia…), rimuovere quel che lo ottura. Per arrivare all’abbandono (dell’ascolto, che l’ascolto per-mette, pre-mette), dovremo prima passare (forse) per la ricezione-comprensione del testo scritto. Sarà un andare a ritroso, “fino a che tutti gli elementi, i livelli, le voci, saranno uno”: il suono, la voce (phone¢). Come in una specie di terapia di diseducazione del nostro orecchio/occhio/linguaggio. Un lavoro di cernita, in costante sottrazione. L’abbandono apparirà quindi alla fine, come “punto d’arrivo” di un lavorío che lo precede: un lavorío dell’ascoltatore, pre-messo e richiesto dal lavorío da cui il disco è nato. Incontriamo piani d’ascolto diversi. Proviamo qui, sommariamente, ad elencarli.
Primo livello: la morbidezza e la suadenza delle molteplici sonorità incontrate ci avvolge (Miles Davis, Jão Gilberto, Ray Mantilla, Astor Piazzolla…). Diffidiamo? Diffidiamo. Stiamo ascoltando uno straordinario acid jazz, una sorta di delizioso sottofondo, che, scartato a priori il problema (accademico) dei generi, li contamina e li mescola. In questa prima impressione, anche fallace — il disco è anche questo — ci conforta l’equilibrio complessivo, l’armonia ottenuta da “un lavoro di cesello” e di limatura (ecco già una prima sottrazione — non nostra), che si intuisce fatto in studio. La pulizia e l’armonia del sound circuiscono.
È che il disco non si lascia semplicemente ascoltare, come delicato e raffinato sottofondo. Il ritmo prevale e vien voglia d’alzare il volume e di ballare. Riemergono le voci distinte, gli strumenti. (Secondo livello). La voce subito (“Love knows”, “As I live to be me”), su tutto, poi alla spicciolata il cervello (non l’orecchio) distingue: la tromba (“Goodbye porkie pie hat”), il basso (“Nearly free”, “Song of my people”), il trombone e il flauto (“If a night a poet”), i saxs (“Love knows”), la fisarmonica (“As I live to be me”), la chitarra (“Goodbye…” e “Aeon”), il piano (“Aeon”), le percussioni sempre, dappertutto, presenti e nascoste. Quindi, forse, ci siamo. Stiamo ascoltando una strabiliante esecuzione-esibizione delle possibilità tecniche degli strumenti. Ma c’è qualcosa che non torna. Il virtuosismo di ogni singolo musicista/strumento non prevale mai; è sempre a disposizione, in funzione d’altro. Non c’è esibizione, ma dis-posizione.
Che cos’è, che ne è di quest’altro che ancora non s’intende?
(Terzo livello). Il testo scritto, poetico (per usare una distinzione che andrà, pur questa, abbandonata) è ciò che, per eccellenza, è oggetto di intendimento, di una comprensione. Tuttavia, quasi immediatamente, incontriamo un ennesimo depistaggio. Al terzo verso del primo pezzo, il testo dice: “Tell you that you want me”. Dunque di quale intendimento-intesa si sta parlando?!
Il paradigma della canzone melodica, tradizionale e non, italiana o internazionale, è completamente rovesciato, superato. Non è abbandonato, ché s’abbandona solo qualcosa che si è avuto/preso. I testi sono pieni di tenerezza, di emozione (sono del resto emozionanti), ma non v’è tempo per nostalgia e compiacimento. Come non v’era (auto)compiacimento nello sfruttare le possibilità tecniche delle “voci”. Caso mai è l’alterigia degli amanti a trasparire, quella netta sensazione di non essere affatto lì per caso, quell’incontro del simile anche attraverso distanze abissali e spesso a sua insaputa. Stiamo (stanno) volando da tutt’altra parte.
(Quinto livello). Fermiamoci quindi al testo, non a ciò che designa, ma a ciò che evoca (e invoca), non al segno insomma (ché in eventuale legenda perderemmo ciò che stiamo cercando — di perdere), ma al simbolo, all’immagine. Ecco forse svelato il riferimento all’haiku. Mare, sole, vento, acqua, tanta acqua. I fiumi lenti, il bagnasciuga, il risucchio (che udiamo, vero, in “Nearly free”), il suono del mare sott’acqua, conchiglie che rotolano… E colore, tanto colore, come “se veramente l’universo fosse verde e giallo”. Ma che c’è dietro/assieme a questi immagini radiose (radioso è uno dei tanti modi con cui raccontare l’esito/effetto dell’album)? C’è costante, rimbalzante i testi, l’immagine di un deserto (prima di tutto umano), di strade vuote, di gente “in fila verso la follia” (quella quotidiana, d’un turno di lavoro che segue un altro), che dà ritmo a questa realtà, che la fissa (“Reflertando”).

Di un tempo (eccoci ritornati all’inizio) che offende, deprime, duole. Di un futuro già vecchio prima d’esser nato. Da cui e con cui non si può che dissentire. La dichiarazione di un immane sofferenza senza volto e senza nome. La dichiarazione di un’impossibilità, tremendamente attuale, dell’incontro, non di negarsi nell’incontro, ma della negazione stessa dell’incontro. L’incontro che “rimane” più aperto anche dell’io, del sé che vuole tramontare. Come i nuovi amori che si aprono prima che si abbiano nuove parole, quelle di cui s’ha terrificante bisogno. Arrivano, quando si è ancora intrecciati e s’aprono, aprono nuovi spazi (come in “Nymph”).
E malgrado questo, o forse proprio attraverso questo, in questo gelo (“Here in this chill you have to dream him”), si (ri-)và oltre.
La sofferenza non si ripiega su se stessa, ma riflette, cioé rispecchia (il doppio senso del portoghese reflertando — neologismo che gioca anche con flirt) immagini di gioia possibile, prima inseguita e strappata ai giorni, allo sferragliare di questo tempo (“stanotte non è oggi e nemmeno domani”), che, successivamente, s-progettata, si rinnova senza fatica. Come “il primo slancio del mare”, appunto. E come l’onda, si risale, sempre di nuovo e sempre di poco, “in piccoli passi”, alla ricerca, al ritrovamento di un altro tempo, di un tempo altro. Fino a che la fatica (antico nome italico per il lavoro), più non sia.
Ci siamo, forse, alfine (ma di forse bisognerebbe metterne più d’uno — diffidando) arrivati. Sfidare questo tempo: “Prometeo”. L’archetipo di ogni sfida, senza assicurazione-rassicurazione alcuna d’un esito “vittorioso”, “vincere o perdere essendo parole che da tempo non hanno più significato”, per chi non vuole né vincere, né perdere, ma giocare (essere il gioco, nel gioco altro, mettersi in gioco).
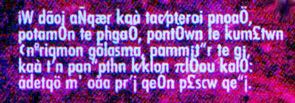
Ce l’avevano, d’altra parte, già detto all’inizio che forse molto sarebbe servito solo come allenamento. Dunque, dicevamo, che fa Prometeo? Ruba il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, che, fino ad allora, s’erano nutriti solo di cibi crudi. Quindi il passaggio dalla Preistoria (quella nuova dell’oggi) alla storia. Per questo, dio tra gli dei, è condannato al supplizio secolare e continuamente rinnovato, dal fegato che ricresce per esser nuovamente divorato dall’aquila di Giove. Una sfida immane, preannunciata impari. Una sfida (nel suo significato contro-simbolico) che vale comunque sempre la pena (proprio la pena) di giocare.
Ma Prometeo è letteralmente il “veggente”, il “profeta” e sarà infine liberato, perché riveli a Giove il futuro. Il futuro: qui, proprio non c’è due-tre-quattromila che tenga. E se la disposizione dei pezzi casuale non è, il futuro è “Marea”.
Un ultimo (?) sforzo, prima dell’abbandono. Pro-meteo, pro- (“davanti”), mêthos (“pensiero”, “cura”). Quindi il futuro è introdotto da qualcosa che pre-cede il pensiero. Che cos’è che in Occidente ha preceduto il pensiero, il logos, la dialettica? Il mito. Ritornare al mito. A ciò che c’era prima della spiegazione, della di-alettica, della separazione, del progetto. Al mistero che non si spiega, che da solo si dis-piega, ri-velandosi, come la marea, nella danza, in un pensiero che sia danza, musica. Questa musica che stiamo ascoltando è già testo ed il testo già musica. È già atto fuori dal progetto. Fuori dal piano, anche lucido, intelligente, coraggioso (comunque da percorrere), c’è l’abbandono, abbandono della fatica, l’estasi, la phoné che eccede il senso (“viverá misteriosa a danca”).
“Out from the plains the sea was flowing” in una nuova alba, in un “nuovo meriggio”.